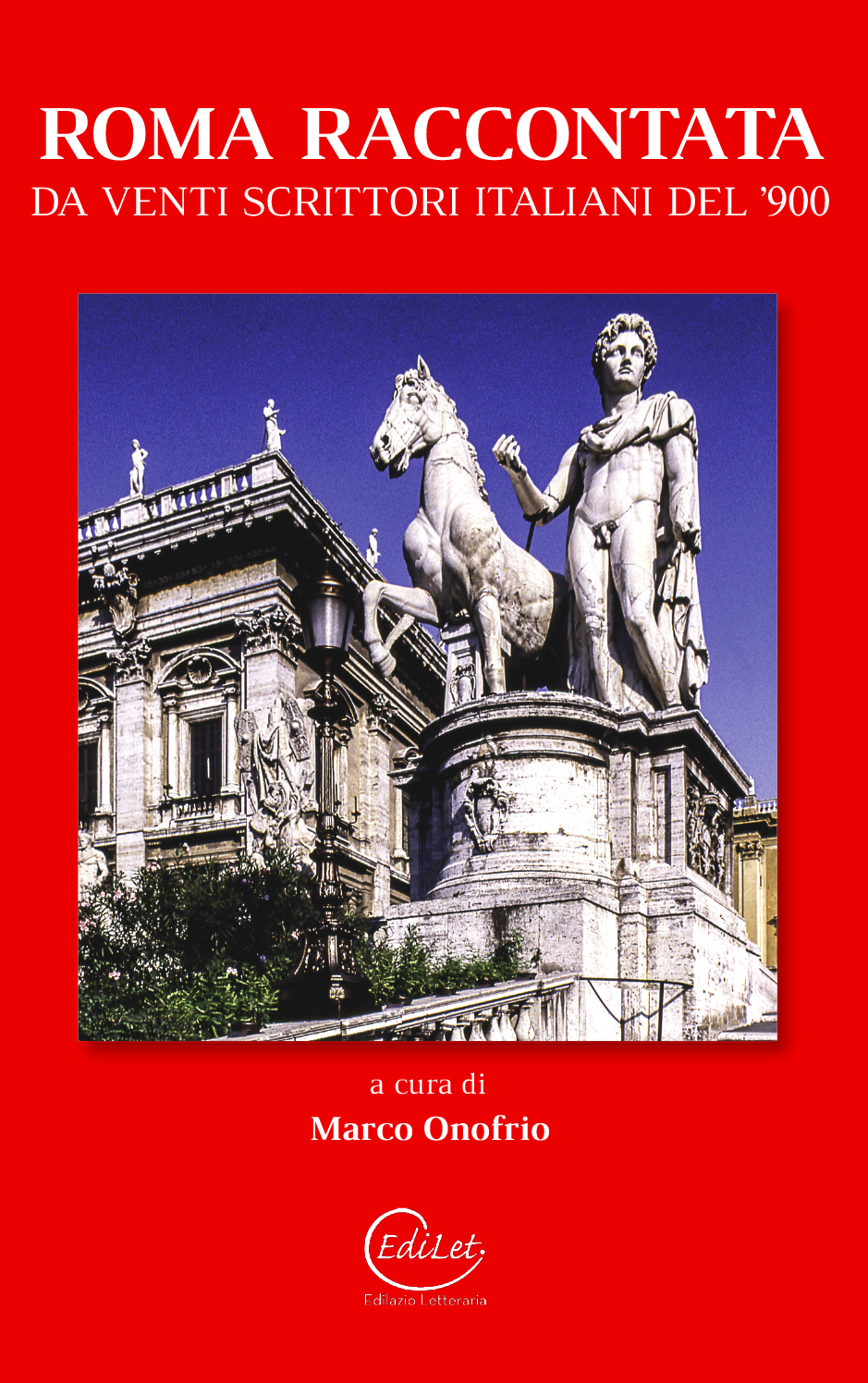Francesca Farina ha scritto un romanzo torrenziale e bellissimo (Casa di morti, Bertoni Editore, 2018, pp. 484, Euro 18), dove le cose si traducono in parole e le parole sono così forti, evocative, palpitanti di energia poetica, da trasformarsi in “cose” più reali e vere delle cose stesse. Ci troviamo dinanzi a un’opera a forma di “Mondo”, che procede con mano sicura e vista lungimirante nella ricostruzione antropologica, eziologica e filologica di una cultura, quella della Sardegna pastorale dell’entroterra nuorese, tanto profondamente da portarsi alle radici della Storia, sarda e non solo, esplorando il “silenzio di una lunga eternità” auscultata con strumenti di grande captazione, “come inseguendo una città perduta”.
Lo snodo tematico fondamentale del libro è il rapporto dialettico tra il “patrimonio incommensurabile” della Memoria, di cui l’autrice si autoproclama devota “vestale”, e il tremendo inghiottitoio dell’Oblio, cioè il “vento della dimenticanza” che soffia l’orrore della verità, oltre il velo delle illusioni squarciato dalle “unghie di un tempo distruggitore e feroce”, per cui il tumulto dei giorni (persone, vicende, cose) è destinato inesorabilmente a incenerirsi, a diventare polvere, ombra, silenzio. La Storia è una “macina” che schiaccia i suoi nati “come semi di grano”: l’esistenza degli uomini passa come “sabbia attraverso un crivello” senza lasciare tracce se non c’è chi, come lo scrittore, spende tanto ammirevole impegno per darle significato, voce, parola. Alla forza “invisibile e potente” della Storia si contrappone la disperata resistenza del Borgo, con la sua “immobile trama” scolpita dentro il cuore dei millenni.
Francesca Farina parte dalle origini mitiche (dal Sardus Pater alla stirpe eroica degli Iliensi) per poi chiamare in causa gli invasori, spesso persecutori del popolo sardo (Fenici, Punici, Romani, Bizantini, Saraceni), fino alle soglie della modernità, quando i Piemontesi chiamano a combattere le truppe dei coscritti isolani, come l’antenato impegnato in Crimea nel lungo assedio di Sebastopoli o, qualche anno più tardi, nella battaglia di Palestro. E costui, come tutti gli altri, “non sa bene cosa stia facendo, perché porta quello zaino di venti chili” che lo ha strappato, per decisione altrui, alla vita agreste del Borgo. L’insensatezza della guerra, certo, ma anche l’orrore della carneficina: spaventose mutilazioni, squarci sanguinanti, petti dilaniati, capi mozzati e ovunque terribile fetore di putrefazione: il campo verde di grano trasformato entro poche ore in campo di morte. L’autrice ci fa percepire la tensione insostenibile dei soldati “vedendo cadere i compagni e scansando la morte ogni momento”. E poi, su tutto sovrastante, il Caso-tiranno con le sue circostanze imponderabili: “chi si crede al sicuro in seconda linea è stanato come una lepre, mentre colui che presta il fianco alle pallottole è risparmiato da una misteriosa coincidenza di fatti”.
La forza del passato, dunque, con la sua potenza schiacciante: poiché il presente e il futuro sono inesistenti per quella cultura dove “il passato era presente e futuro insieme, era la Storia”. Ecco pazientemente ricostruito il tessuto organico e sociale di una terra plasmata dalle “dita dei secoli” e abitata da “spiriti indomabili”, dove alla tracotanza dei maggiorenti (come la stirpe mitica dei Barones) si contrappone la fierezza di pastori e contadini dalla tempra forte e selvaggia, dotati di qualità “leonine”, virtù “ferine” e “smisurato orgoglio”. Vivono, sopravvivono anzi, sempre sull’orlo dell’abisso: l’incognita della natura in perenne agguato (alluvioni, siccità, epidemie) li costringe a “mordere la vita coi denti” per consumare stentatamente il “pane di dolore”, l’“acqua di sangue” e il “latte di morte”.
La società chiusa, crudele e implacabile rende il Borgo un “paese dell’eterno lutto” dove regna il silenzio dei millenni, un silenzio “forte, sonoro, abbagliante”, sempre prossimo a una rivelazione. La pagina a questo punto traluce della dimensione ancestrale che sostanzia l’anima autentica della Sardegna, coi Nuraghes maestosi e inquietanti “simili a giganti muti e fermi”, e le figure ieratiche degli indigeni dai volti che “parevano scolpiti nel granito delle montagne” e le usanze ataviche protette dai vincoli sacri del sortilegio, e le donne “simili a bibliche eroine” con la loro attitudine millenaria “ereditata dalle ave più lontane” che avevano la stessa posa anche centomila anni addietro… Prima del traumatico arrivo della modernità che ha bruscamente accelerato la Storia, la continuità del mondo procedeva intatta e ininterrotta: i tempi erano sostanzialmente uguali a quelli dei secoli precedenti. Il rapporto coi fenomeni era contrassegnato da una forma di animismo primordiale che spingeva ad “adorare le querce e le fonti” sgorganti dai pozzi della dea Acqua (ad esempio il pozzo sacro di Santa Cristina). Nei tempi più remoti, infatti, “tutto era sacro per gli uomini, la terra, i fili d’erba, la pioggia, l’acqua e la neve”. Incessantemente si invocavano gli dei che “sembravano essere dappertutto, perfino nella corbella del cibo, nel pane e nel sale”. Il silenzio impenetrabile delle case era affollato da strane “presenze” di cui parlavano gli scricchiolii, le travi di legno impegnate da inquietanti e invisibili passaggi: per le scale transitavano di continuo le anime dei trapassati, i morti si aggiravano per le stanze e sorvegliavano i gesti dei vivi. I vivi e i morti erano uniti indissolubilmente, per cui non si contavano le “visite” dall’universo parallelo dell’altra dimensione, e “la paura di un incontro era pari al desiderio dell’incontro stesso”. Brividi di repulsione e attrazione connaturali all’eterna crosta della humana conditio. Così scrive Francesca Farina: “Che cosa tremenda, questa, che ogni giorno poteva essere l’ultimo e perfino ogni ora, ed ogni attimo potevano essere gli ultimi! E che cosa c’era, dopo? Perché era così inevitabile e pauroso quel passo? Perché era tanto tenacemente radicato in ogni creatura vivente l’istinto di morte? E perché tutti ne avevano desiderio ed orrore?” Il silenzio era dunque carico di presagi, e il buio nascondeva presenze sovrannaturali. La soffitta e il fòndaco, da questo punto di vista, erano i luoghi più misteriosi e paurosi della casa. La consuetudine con la morte “rientrava nella vita normalmente”. I morti preannunciavano gli eventi, quasi sempre luttuosi, attraverso un sogno, il verso di un rapace o un qualsiasi segno manifestantesi tra le pieghe più ordinarie del quotidiano.
La società era repressiva, i divieti soffocanti, il Borgo occhiuto come un Argo preposto a sorvegliare incessantemente per spegnere sul nascere il libero sviluppo delle energie. Ogni singola Casa, come la cella dell’unico alveare, era “luogo di oblio, di dolore e di morte”: tenebrosa, opprimente, con le camere perennemente chiuse, abitate da un silenzio luttuoso, così profondo “da far male” come presagendo una sciagura. La vita era dominata da un dolore primario che nasceva dalla negazione assoluta del piacere e della vita stessa. L’amore era parola inconcepibile e impronunziabile, “quasi una bestemmia”. L’educazione barbara dei fanciulli li teneva per “oggetti, piuttosto che per soggetti pensanti (…) ad essi tutto veniva negato, perfino lo sguardo, la parola, nonché il cibo, il vestiario: ogni cosa era ridotta a poco, all’essenziale”. Un unico vestito doveva bastare per anni, ma soprattutto non c’era spazio per i sentimenti: venivano negati e condannati, “l’unico valore approvato era il silenzio”. Sguardi, carezze e baci erano “sepolti in bare di granito” e tali “mancati gesti” e “tenerezze non date” generavano una “supplica perenne negli occhi”, una “spaventosa immotivata tristezza” e l’incapacità di manifestare sentimenti: chi non ha avuto mai amore, mai potrà darne. Dopo una simile amarissima infanzia, lo “straniamento, la disperazione, la nevrosi emergevano inesorabili”. Ecco ad esempio Juanne Maccus, il matto del villaggio, con gli occhi e i modi da cane, così bisognoso di amore e di riconoscimento da dimostrare “folle fedeltà a chiunque gli mostrasse un poco di attenzione”. Infatti, precisa Francesca Farina, “le violenze subite dai bambini di quelle ferali case di morti avrebbero fatto un nido di terrore nelle più intime fibre del loro essere”.
I sardi, così, emergono dalle pagine come un popolo “triste ed austero” divorato da un “tetro rovello di morte e di dolore, di lutto incessante”. E il “dolore di esistere” come una “malattia sopportata senza mai farsene avvedere”. Una vita di “lavoro inenarrabile e di stenti, di divieti, di odio e di massacro”: fame, fatica, dolore, disperazione, miseria, solitudine, emarginazione. Il romanzo, perciò, è come un “arazzo variegato” mirabilmente ordito da Francesca Farina, “instancabile tessitrice” delle proprie origini, ovvero “racconto ininterrotto” (novella Sherazade) per sopravvivere al tempo e farlo sopravvivere, ma anche come restituzione del maltolto ai “vinti” e loro postumo riscatto per le ingiustizie patite dalla Storia. Da questa fonda oscurità sorgeva poi, con l’istruzione obbligatoria, la “luce della scrittura”. Ma a scuola c’era un “maestro indimenticabile, che insegnava picchiando e urlando senza posa, terrorizzando gli alunni che nulla apprendevano se non la paura”. Naturalmente, dati i tempi di cui si parla, è quasi superfluo accennare alla inveterata subordinazione femminile (sin da fanciulle erano “sepolte vive” nel “carcere della Casa”, chiuse nelle stanze, assoggettate al “capestro della famiglia” e legate alla “ferrea catena stretta intorno al focolare”), da cui osavano emergere le donne-tigre dal temperamento ribelle, spesso tempestose e devastatrici come Erinni, e poi, forse, le donne liquide, le dee d’acqua, calme in apparenza ma bruciate dal fuoco di un “furore frenetico”. Anche se, a dire il vero, la Sardegna si distingueva da altre terre per una stabile tendenza al matriarcato, derivante dalla necessità delle donne di governare casa e prole durante i periodi di assenza – anche mesi – degli uomini, impegnati nella pastorizia. E così gli guardi erano offuscati da una “millenaria abiezione” ma talvolta, per contrasto, invasi dalla “straordinaria forza vitale” che li faceva resistere al male, al dolore, all’insensatezza, con le pupille accese da una “folle speranza, una forza oscura e segreta, la vita insomma”.
Poi ecco, con l’arrivo distruttivo della modernità, la fine di un mondo, sepolto dalle colate di asfalto e cemento, e ingannato dalla falsa felicità della chimica: “tutto, ad un tratto, divenne di plastica, perfino le sedie, i mobili, i soprammobili, le rose, le statue, i vestiti” (di nylon terribilmente infiammabile) e insomma tanti oggetti scadenti e inutili che annunciavano l’effimera civiltà del consumismo. Con la conseguente e progressiva devastazione della natura: alberi abbattuti, siepi divelte, sorgenti prosciugate, sentieri cancellati, raganelle scomparse, al posto dei “miti orti paesani” i “pretenziosi giardini” dei borghesi neocapitalisti, etc.
Ma la Sardegna autentica vive per sempre nel sangue, nella “radice del cervello”, nel “fiocco dell’anima”. La panoramica d’assieme si precisa ulteriormente con gli “affondo” della seconda parte, dedicata ai ritratti di figure della Famiglia, come le tre indimenticabili zie Enne, Nenne e Memme, quest’ultima specialmente, la “Tigre ircana” simile a Medea “ma incorruttibile, Medusa e Maga ammaliatrice” e quasi sempre “urlante e rabbiosa”, con un “diavolo per capello”. Luoghi, oggetti e volti, sepolti nella memoria, restano “come sedimentati nel fondo della coscienza, quasi fatti coscienza essi stessi”. Il “mal di Sardegna”, che ben conosce anche il turista quando abbandona l’isola, colma gli occhi e il cuore di nostalgia della terra edenica intravista fra gli scenari di quella reale: una specie di amore struggente, quasi desiderio carnale, di quelle piante, quelle rocce, quelle creature. Il paesaggio esterno si traduce in paesaggio interiore: “di ogni albero” leggiamo “portava nel sangue la visione fremente, instillatavi da un milione di anni, dacché un essere tanto simile e tanto diverso, ignoto a lui, ma fratello, aveva colto per primo quei fruttici, quelle bacche”. È la continua coscienza di essere, ciascuno di noi, l’anello di una catena infinita – e dunque il senso vivo della Storia di cui siamo parte e che di noi si compone – a conferire alla scrittura di Francesca Farina la sua tipica, particolare e universale profondità, per cui dietro le parole si avverte “un universo intero, di stelle e di abissi”, mentre la linea esteriore corrisponde “a una linea interiore (…) a volte sinuosa e spiraliforme, sfrecciante e sfuggente”.
Nel mondo e nel “modo” epistemico di questo romanzo ogni cosa ha un nome e, viceversa, ogni nome “è” una cosa (nomina sunt res, diceva Giustiniano). In quella Sardegna “ogni collina, ogni sentiero, ogni roccia portava, come le persone, un nome” e quindi la scrittura cerca idealmente di dare udienza e voce ad “ogni macchia, ogni arbusto, ogni foglia e ciascun fiore screziato”, “evocando la estrema ricchezza della natura”, nella sua inesauribile fenomenologia, e “osservando come il più acuto e sottile entomologo ogni insetto, ogni sepalo, ogni bacca, ogni goccia di rugiada”. L’autrice è talvolta presa dal demone dell’enumerazione, come quando descrive i gioielli tradizionali delle donne sarde o nomina, nello spazio di mezza pagina, oltre 30 tipi di piante diverse, anche quelle “dai nomi poco usati” (per citare Montale) come l’iperico, l’ononis, il colchico e l’euforbia. È una scrittura che sa unire le matrici opposte di Verga (la concretezza icastica di una parola che è pietra e carne) e D’Annunzio (la musica della prosodia) in pagine di grande equilibrio compositivo ed efficacia lirica, come nel passo seguente: “il mistero del futuro era grande e indefinito come quello della luna che, sporgendosi da una foresta di nubi, guardava con occhi cupi nel fondo dell’universo”.
La composizione poietica in prosa di “Casa di morti” riporta in auge la questione pluri-millenaria della Mimesis, che per Platone (X libro della “Repubblica”) è mendace in quando copia della copia della verità. Per Dante il realismo cosiddetto “figurale” annunzia e manifesta la realtà vera, quella trascendente. Quello di Francesca Farina è un realismo simbolico e fenomenologico, che vuole definire senza finire, cioè senza limitare la ricchezza dell’esistente negli schemi riduzionistici dove “non cape”, per inseguire l’irraggiungibile e inconcepibile realtà delle cose così come sono, evocando – quasi oltre le parole – quel “linguaggio privo di mediazione” a cui Hofmannsthal dedica, all’inizio del ‘900, la sua “Lettera di Lord Chandos”: la bellezza si rivela alla mente e “in ogni piega del cuore” come “perfezione di forme”, “beata opulenza di colori”, “memoria indelebile per i giorni venturi, ricchezza inesauribile, gioia perenne”.
Nelle opere la critica stilistica tende a esaminare anche la struttura dello spazio letterario. Ad esempio la “Divina Commedia” predilige lo spazio verticale, adeguato alla visione trascendente e medievale di Dante; l’“Orlando Furioso” lo spazio orizzontale, adeguato alla visione laica e rinascimentale dell’Ariosto; la “Gerusalemme liberata” mescola allo spazio verticale del cristianesimo quello orizzontale del paganesimo, etc. Qui lo spazio è, piuttosto, circolare, giacché asseconda la ruota del tempo e la dinamica ciclica delle incessanti trasformazioni. Non a caso le due parti di cui il libro si compone sono intitolate “Nel cerchio delle colline” e “Nel cerchio della famiglia”, e gli stessi personaggi emblematici della narrazione (come le tre zie) sono come magneti attorno a cui ruotano i satelliti degli altri, in una coralità che incide a propria volta la sua spirale dentro il cerchio misterioso della vita.
“Casa di morti” è un romanzo straordinario, non solo a livello storico e antropologico, ma anche a livello ontologico, di scrittura del mondo, di presa della realtà ad ogni livello della materia. La sua scrittura ricchissima e multisensoriale ripristina la dicibilità totale dell’esperienza, e dunque la perduta centralità umanistica come cardine e misura delle cose, ma con un senso “postmoderno” di apertura universale, di nuova umiltà e devozione all’essere. Ma è soprattutto il tema della Memoria a rendere il libro degno della massima attenzione. La scrittura come esorcismo dell’oblio e arca di salvezza delle cose, altrimenti destinate a scomparire. “Di ogni cosa, alberi e visi, mani e foglie, parole e fruscii del vento, tutto si portarono via gli anni”, così è scritto nell’ultima pagina; e tutto il ponderoso e poderoso romanzo che si è letto fino a quel momento non è altro, in definitiva, che il tentativo – riuscito – di opporre una misura di resistenza umana a questa sparizione.
Il libro è importante, da ultimo, anche per la sua magnifica inattualità, che lo pone in controtendenza alle mode letterarie oggi imperanti, stabilizzate sul “mordi e fuggi” di un facile e preconfezionato “intrattenimento”. Un punto fermo da cui muovere per riportare la narrativa italiana ai fasti dell’arte che un tempo, neanche troppo lontano, usavamo chiamare “Letteratura”.
Marco Onofrio