
Tag: Roma
«L’incanto e la paura». La parola, l’immagine e la Vita, tra “strazio” sublime e dolce “struggimento”. Conversazione con Chiara Mutti

Oggi faremo insieme un viaggio nel mondo creativo di Chiara Mutti. Cercando di “sentire” e “comprendere” i luoghi “fin dove giungono le parole”, ma anche oltre, e quindi ciò che considero il cuore della sua poetica, ovvero il rapporto problematico tra la realtà delle parole e la realtà delle cose, ma anche tra le rispettive e reciproche irrealtà. Da un lato il Logos riduzionistico, l’esperienza dicibile con gli strumenti umani della ragione; dall’altro il Mythos senza confini, l’altrove perturbante dell’indicibile. Ebbene, il pensiero annoda i suoi ricami nella zona franca tra il silenzio delle cose, ricco di tutte le parole che vorremmo, e il suono delle parole, povero di tutto il silenzio che non parla. Per questo la poesia è, per dirla con Robert Frost, il “suono del senso”, che afferra, racchiude e produce il senso non convenzionale delle cose, la loro realtà ultima e prima, la radice originaria della loro forma apparente.
Ma andiamo con ordine, muovendo i passi dal più recente alloro che la poesia di Chiara Mutti ha ricevuto, poco più di un anno fa…
– Dunque, Chiara, hai vinto la prima edizione del Premio Nazionale “Moby Dick”, Sezione Poesia: che ricordi hai della premiazione avvenuta nella Sala Consiliare di Palazzo Colonna a Marino (RM) il 26 settembre 2022? Che cosa distingue questo premio, secondo te, dagli altri a cui hai partecipato o che hai vinto?
– È stata un’esperienza felice! Vincere un premio è senz’altro sempre gratificante, ma questo premio ha una marcia in più… non solo per la perfetta organizzazione, ma anche per l’accoglienza e l’attenzione che mi è stata riservata. Insomma, posso dirlo: mi sono sentita coccolata e in perfetta armonia con l’ambiente per corrispondenze elettive. Sono cose che, almeno a me, accadono raramente.

– Che cos’è che ti spinge a scrivere? Che cosa ti proponi pubblicando le tue pagine?
– Credo che sia stato il mio modo spontaneo di esprimermi sin dall’infanzia, non essendo particolarmente portata ad esprimermi con le parole. Volendo fare la psicologa di me stessa, aggiungerei che è un disperato tentativo di fissare il tempo, di contenere lo straziante e continuo dissolvimento di tutte le cose. Mentre scrivo non penso ad altro che a scrivere; soltanto dopo, una volta concluso un determinato percorso, ho bisogno di metterci un punto, di chiudere un cerchio. Pubblicare significa chiudere quel cerchio, fino a un nuovo inizio.
– Puoi azzardare una “definizione” della Poesia?
– Alla Poesia sono state attribuite, nel corso del tempo, innumerevoli definizioni, e giustamente, perché infinite sono le sfumature di senso che implica e i concetti con cui la si può identificare ma, proprio per questo, sempre parziali. Per me la Poesia è e resta, in realtà, indefinibile. Penso sia un modo di vedere, anzi che sia essa stessa Sguardo: un modo particolare di percepire la vita e le cose del mondo.
– La Poesia è per te più “serbatoio del meraviglioso” o “incubatrice d’ombre”?
– Per me è senz’altro “serbatoio del meraviglioso”, le ombre sono dentro me… sono io la mia “incubatrice d’ombre”. Il miracolo è tradurle in qualcosa di luminoso e la poesia è lo strumento che mi permette di farlo.
– Perché, a costo di perdere lettori, non hai paura di sollevare la pietra delle ipocrisie e di affrontare il dolore viso a viso?
– Perché non conosco altro modo di scrivere! Se non lo facessi non solo non sarei fedele a me stessa ma non sarei fedele nemmeno alla Poesia.
– Che sentimenti provi quando scrivi? Più gioia o più sofferenza? È per te un gesto catartico, di autoconoscenza e liberazione?
– Quando scrivo provo più sofferenza che gioia, anche perché la parola è uno strumento limitato che non basta mai comunicare tutto quel che vorremmo esprimere e contro cui ci si scontra continuamente. Peraltro è uno splendido strumento di autoconoscenza e posso dire quindi che è tutte queste cose insieme. Ma non si scrive per liberarsi; non ci si libera mai completamente. Solo dopo, quando si è concluso un percorso e si pubblica, allora sì, allora se hai avuto coraggio e sei davvero disceso negli ‘inferi’, allora può avere un effetto catartico.
Il percorso di Chiara comincia, dopo alcune composizioni giovanili inedite, che probabilmente riprenderà tra qualche tempo, con il primo libro pubblicato: “La fanciulla muta”, del 2012, che segna la sua sofferente conquista della voce. La fanciulla muta è lei stessa da bambina, chiusa nel mutismo come unica maniera per rispondere all’enormità dei fatti spiacevoli che la vita la costringeva prematuramente ad accettare, ma è anche la neve, la coltre del silenzio puro che porta la realtà a scarnificarsi fino all’essenza, al cuore metafisico dell’esperienza e della sua memoria.
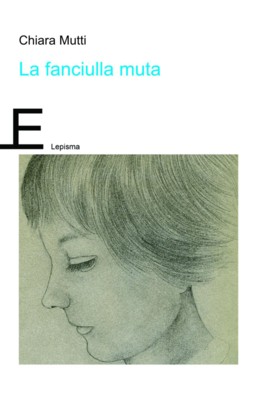
LA FANCIULLA MUTA
Hanno chinato la cima
i cipressi
ad annusare l’odore dei prati
un odore bianco
un nonnulla
un marmoreo affiorare
di gigli
e il silenzio
è un richiamo del cielo
un sorriso stupito
un fantasma
la fanciulla muta.
CANCELLI
Osservo dalle dune
un filo d’erba
agitarsi lieve
alla salsedine
lontano
una vela va
oltre il mio dito alluce
serena
tra gli ombrelloni e il mare
biancoverde biancoverdeblu
sfocato
nel tremulo calore della sabbia
l’alta marea tace
dei rumori dell’anima
spezzati
sull’orlo della spiaggia.
NIN-TU
Sorella MadreTerra
infausta nelle mie mani
lasciasti il dono
dissipato
alfine come topi in massa
nell’innato istinto
correremo giù dalla tua rupe
ciechi come falene
rese cieche dalla luce
folli come scimmie
rese folli dalla prigionia
gravidi come cagne
sciuperemo il seme
prosciugheremo il mare
e il miracolo dei pesci
non si ripeterà
la spiga brucerà l’asfalto
landa di nessuno.
Solo ci sarà dato
il respiro degli eroi
che seppero cantarti
benevola e terribile
vulcano d’Islanda
lapilli e cenere
l’incanto e la paura
l’inesplicabile bellezza
tanto che ingrata torno
a consegnarti un intimo vagito
IL DOLORE DELLA SOLITUDINE
È il dolore della solitudine
uno stesso dolore per tutti
un dolore a tonfo sordo
che scuote il cuore
rosso e azzurro di vene
gonfio che trattiene
si accartoccia e stride
come un freno a mano
tirato
nell’universo del ricordo.

A SILVIA
Madre
che abbandonai
alle tortuose vie della follia
troppo presto, per non serbarne colpa
non fosti mai
mamma, sorella, amica
ma forse figlia.
Mi irrigidii
serbando nei ricordi i tuoi fantasmi
lontana, eppur commossa
dalla tua vita
solitaria e stolta.
D’amor non fosti amata
spietato il senso della sorte
e mi sorprendo, ora
a ricordarti nel tuo affetto infante.
Io, adulta
non seppi mai dirti che t’amo
neanche l’ultima volta che ti vidi
terribile, eppur bella
nella rigidità eterea della morte
E VOLTO PAGINA
E volto pagina
sono colei che volge
lo sguardo indietro
ma non torna
ed i vestiti smessi
non mi stanno
pure
vi riconosco
il peso del mio corpo
e lì dove ho sostato a lungo
l’anima si è consumata nella fibra
e lì dove ho mangiato
il cuore si è nutrito nella macchia
e lì dove ho ceduto
lo strappo si è allargato nel dolore.
Il respiro poetico di Chiara si accorda col respiro cosmico dell’essere. La sua voce domina con grande naturalezza il solfeggio delle pause, cioè il rapporto metasemantico che regola l’avvicendarsi di parola e silenzio. Con questo libro impara appunto a scolpire il silenzio in un movimento di scavo e ricapitolazione dell’esperienza. Anche come studio archeologico del sé: la faticosa costruzione della persona, le ere geologiche e geometriche assimilate nella propria crescita.
– Parlaci della tua passione per l’archeologia. Che rapporto hai con il passato? Fra l’altro uno dei tuoi libri di poesia ha un titolo bellissimo, “Archeologie del cielo”…
– Grazie! Ho sempre avuto un forte legame con le radici, che siano intese come origine personale o in senso antropologico, cioè estese a tutto il genere umano. Ho sempre provato un senso di stupore e di meraviglia nel venire a contatto con i manufatti antichi, con i resti archeologici, e in parte anche un senso di gratitudine; forse la mancanza del senso di appartenenza a una famiglia mi ha portato ad aver bisogno di sostituirlo con un senso di appartenenza più esteso.
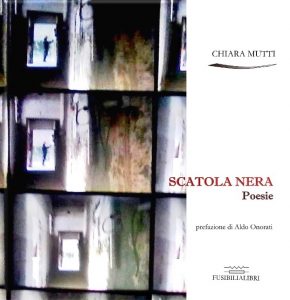
Il secondo libro, “Scatola nera”, giunge quattro anni dopo la “Fanciulla” a, come dire? sporcare di realtà gli esiti sublimati di quell’esordio. È lo spleen pumbleo dell’esperienza con il suo ingombro, è il “muro della terra” di dantesca e caproniana memoria. Di che cosa è metafora “Scatola nera”? della memoria automatica di bordo, come quella degli aerei? dell’inconscio? dell’anima profonda e immemoriale? dello spessore opaco del mistero? Le risposte ovviamente restano sospese.
COSTELLAZIONI
I
Eravamo sulle labbra della luna
un soffio di polvere bianca,
squame argentee di salmoni
risaliti alla corrente.
Il coro d’inermi fanciulli
emise qualche nota stonata,
un’uggia di rauchi conati.
Duro il sangue pulsò
corrompendo ogni desiderio:
tracciavamo i punti alla cometa
una domanda, una domanda, una domanda
nascevamo sopraggiungendo al giorno
tutto il resto sembrava sera
e la notte era già il tempo del dopo.
II
Dall’emisfero boreale
il vento soffiava gelido di ghiaccio,
pavidi e tremanti
riparammo sotto l’apparenza
seguendo traiettorie
perpendicolari: al nulla
immobile, piombando il sonno
suggeriva sistemi in divenire,
non sapevamo che il nostro
era solo un vagare in tondo?
Un suono di sirena fissa
accanto all’ultima luce.
Il futuro è rimasto irrivelato
come un pianeta dissolto.
III
Prima che piede
ci spingesse al passo
milioni di zampette confuse
segnarono orme di galassia,
solo ali di libellula astrale
ci liberarono dall’orda
distinguendoci l’un l’altro,
vennero a portarci
una nuova forma di confine.
Il margine era acqua
e non era finito, oltre la sostanza,
che potesse quietare
l’ansia del crescere.
Pure il ventre, così vuoto e scarno,
sembrava ora estendersi al pleroma.
Mani d’ossa tintinnanti
musicarono il vuoto.
IV
Perché mai questa scia
di detriti alla deriva?
Questo nulla che ci attrae
più dell’atomo scomposto?
Cambierò la tua fede
in un carro,
un pavone, un cavallo,
una capra bianca.
Puoi frenare il volo del cigno?
Incalzare la risposta del corvo?
Domani, domani.
Forse la materia è madre
strappata agli abissi:
per questo siamo nati.
Forse non siamo che forma.
V
Oh! come tutto muove
e muta, e segue:
solo noi sembriamo
eternamente in atto di finire.
Sempre con occhi vani
ci appressiamo alla vista
pure un giorno dura,
ogni sole, un giorno
e una notte, una notte
basta
per tutte le stelle.
LA LUNA ASSENTE
Sembrava, il brusio, salisse dai fondali
dall’argano, geniali intricati
artifici umani
o forse proveniva da un dio irredento
condannato per la sua vile assenza.
Di ora in ora avanzava sugli spalti
più su, sulle mura
le grida roche
spossate alla calura, alla fame, all’attesa.
La notte, inesorabile, è giunta.
Il pollice verso, la luna assente.
Non adirarti con me!
L’uomo che siede al di là della luce
ha intonato un canto
i fiumi scorrono sotto.
IL LUME
Era forse la tua voce
quel lontano lamento?
O era il vento?
La mano non raggiunse
il mento
che tremava.
Oh lacrima!
rimasta impigliata alla falce.
Tu non hai che parole d’ossa
– i miseri resti –
non gridi, non corri,
non sai
quale mistero ti ha visto.
Chi ti ha riconosciuto?
Chi ha divelto la porta?
Oh! restituitele gli occhi
ridatele il sonno:
la palla è caduta lontano.
Solo un velo di terra
è rimasto
tra la ciotola e il lume.
“Scatola nera” è il suo libro più psicanalitico, rappresenta la catabasi necessaria al raggiungimento della luce, la discesa agli inferi della memoria per fare i conti con se stessa e la verità della propria storia nel mondo. È un’opera molto densa e coesa, che aspira alla dimensione unitaria del poema sinfonico disteso sul “basso continuo” di una musicalità poco cantabile che definirei “dark”, in cui si innestano slanci verticali da cui vengono episodicamente illuminate le atmosfere, come feritoie di una galleria. A proposito di musica…
– Che rapporto hai, in genere, con le altre espressioni artistiche? Di che cosa nutri la tua immaginazione?
– Amo tutte le espressioni artistiche: pittura, scultura, architettura, musica… ma anche grafica e naturalmente fotografia. Posso dire di avere un trasporto particolare con la pittura, avendo avuto modo di respirare quest’arte già in famiglia: mia madre Silvia, il prozio Adolfo Mutti (pittore affermato, in particolare a Brescia e in Lombardia) e il bisnonno Giacomo Mutti erano pittori. Mi piacerebbe approfondire meglio cinema e teatro, ma tutto non si può fare, soprattutto lavorando, però, d’altra parte, proprio il mio lavoro mi dà la possibilità di vivere a stretto contatto con l’arte e oggi posso dire che non potrei più farne a meno. L’arte nutre costantemente la mia anima prima ancora della mia immaginazione.

– Sappiamo che sei anche una bravissima fotografa. Hai anche esposto in mostre fotografiche. Che rapporto c’è, secondo te, fra scrittura e immagine fotografica?
– Diciamo che mi diletto e ho un buon occhio fotografico, ma non sono una professionista. Questo però, e in parte è voluto, mi consente di sperimentare e di spaziare verso soggetti diversi in piena libertà. Poesia e fotografia sono due forme espressive molto diverse e apparentemente contrastanti, ma hanno entrambe un potere evocativo fortissimo e, in questo senso, diventano due vasi comunicanti. Il rapporto tra fotografia e poesia, infatti, per me è molto stretto e posso dire che amo creare immagini con le parole così come fare poesia con le immagini. Può sembrare un’utopia, ma rappresenta una grande sfida e come tutte le sfide mi affascina.




Infatti alcune splendide fotografie entrano in dialogo con le composizioni poetiche del suo terzo libro, “Archeologie del cielo”. C’è un rapporto paritario tra le due forme espressive, per cui le poesie finiscono per essere come fotografie senza immagine, e le fotografie come poesie senza parole. È un libro di trascendenza immanente, di sublimazione concreta, di assalto carnale del mistero. Infatti assomma gli esiti dei due libri precedenti: la poesia è un lievito che ri-anima le cose del loro brivido ancestrale, ricongiungendo lo spirito alle radici del sacro e risvegliando l’atteggiamento di adorazione degli antenati. E questo le consente di esplorare labirinti enigmatici di incanto e paura, ai bordi dell’indicibile complessità.
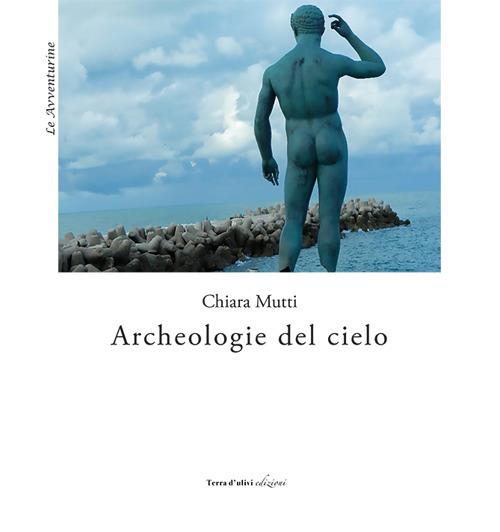
*
Io vivo. Ma se fossi sogno?
L’allegoria sarebbe il giorno
e la luce tempo.
I colori brillerebbero di una tale infamia
che la notte sarebbe
l’unico porto sicuro.
Il porto in cui la quiete
ha sepolto il giorno.
Ma i ricordi, i ricordi
le fluttuazioni
chi spegnerebbe loro il lume fioco?
Anche il cielo,
il più nero di stelle,
ha le sue prigioni.
*
Noi siamo la continuazione
di quanto è stato prima
e ci sarà domani.
Apparenza e realtà
in una sola dimensione.
Ed è cosa piccola, così piccola
così impossibile da contenere!
Un raggio di luce che danza
qui, ora lì, oltre,
fin dove la penombra può arretrare.
Forse eravamo qui da sempre.
Lo siamo già nei ricordi del Golgota
e nelle valli scoscese,
lo siamo nelle case di pietra,
nelle finestre
diventate azzurre.
Anche loro riflettono cielo,
come noi
che di cielo abbiamo avuto le mani
e quanto abbiamo toccato
è diventato pianta, acqua, animale, dio
Universo
potremmo già essere santi
o dannati per sempre:
chi può decidere il destino?
Guardami, è l’alba,
io sono stata in questa luce
e sono ancora
il principio del mondo.
*
Illuminata dal basso
si ergeva, alta, la rupe.
Era il silenzio immobile
sacro come la croce
su cui muoiono gli uomini
e Dio.
– Un rosso sangue
languente nel cielo –
Più in basso scorreva la vita
infinitamente più in basso
nel fiume scorreva
l’ora precipitava
nel buio profondo
pur continuando a errare.
*
Il cielo ha molti segreti
ma alla vista
si aprono chiare le nuvole.
Nei petali hanno raccolti di nettare
e producono un suono strano:
a volte scoppi di risa
oppure un borbottare
fitto fitto.
Ascolto e aspetto
la replica dei rami
che le foglie persistano o cadano
o se ne vadano
con lo stesso struggente rumore
della mano che si allontana.
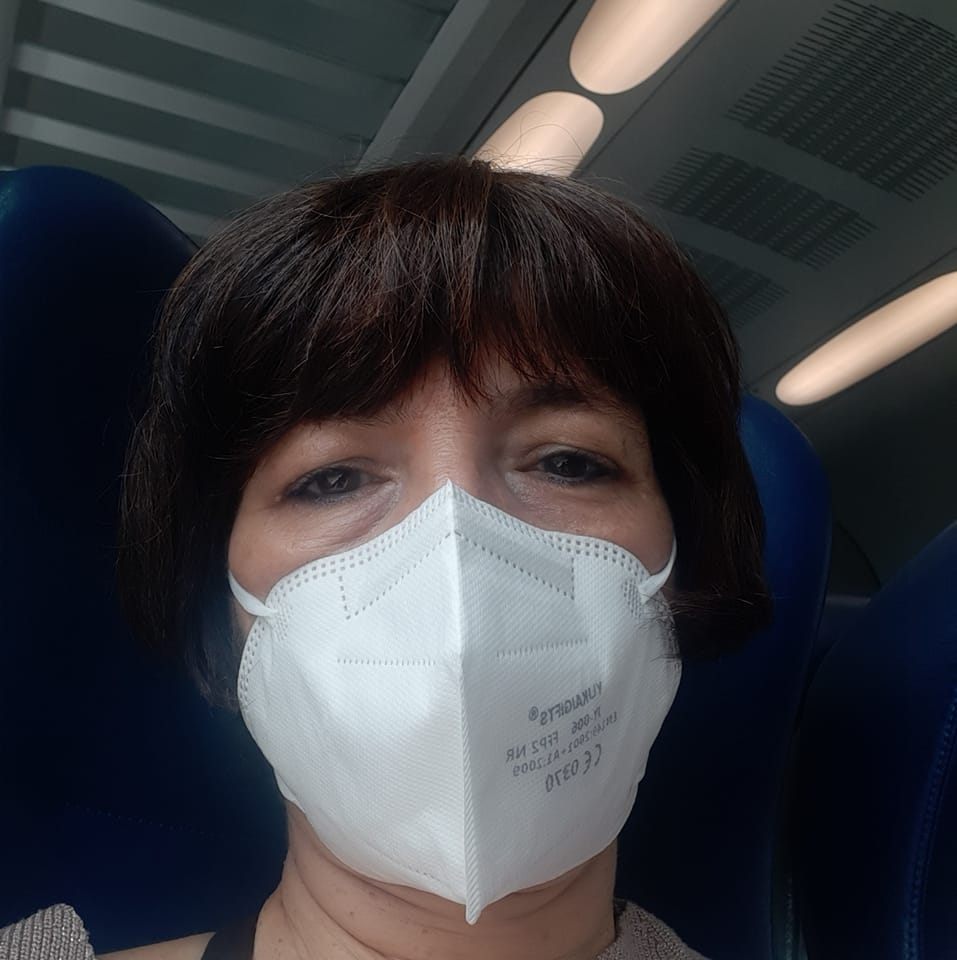
E arriviamo così al quarto libro, le prose liriche di “Amen” in cui Chiara immagina che Giulia, la protagonista autobiografica delle vicende narrate, faccia i conti con una infanzia traumatica e dolorosa, segnata dalla malattia psichiatrica della madre e dalle conseguenti fughe familiari del padre. Ho avuto il piacere di scrivere la Prefazione del libro, in cui fra l’altro dichiaro che «Amen è lo stadio finale di una conquista: significa scendere a patti col passato, con l’annosa e mai del tutto superata “paura di vivere”. Significa imparare a perdonare, abbracciare, amare, benedire e lasciare andare. Significa guardare nello spavento del buio con una fiducia e una forza tali da vederci una luce che brilla». “Amen” è notevole anche perché, grazie all’intensità dello sguardo e dello stile, riesce a intessere la consonanza di due dimensioni estetiche generalmente difficili da accordare, se non inconciliabili: l’umano e il sublime.
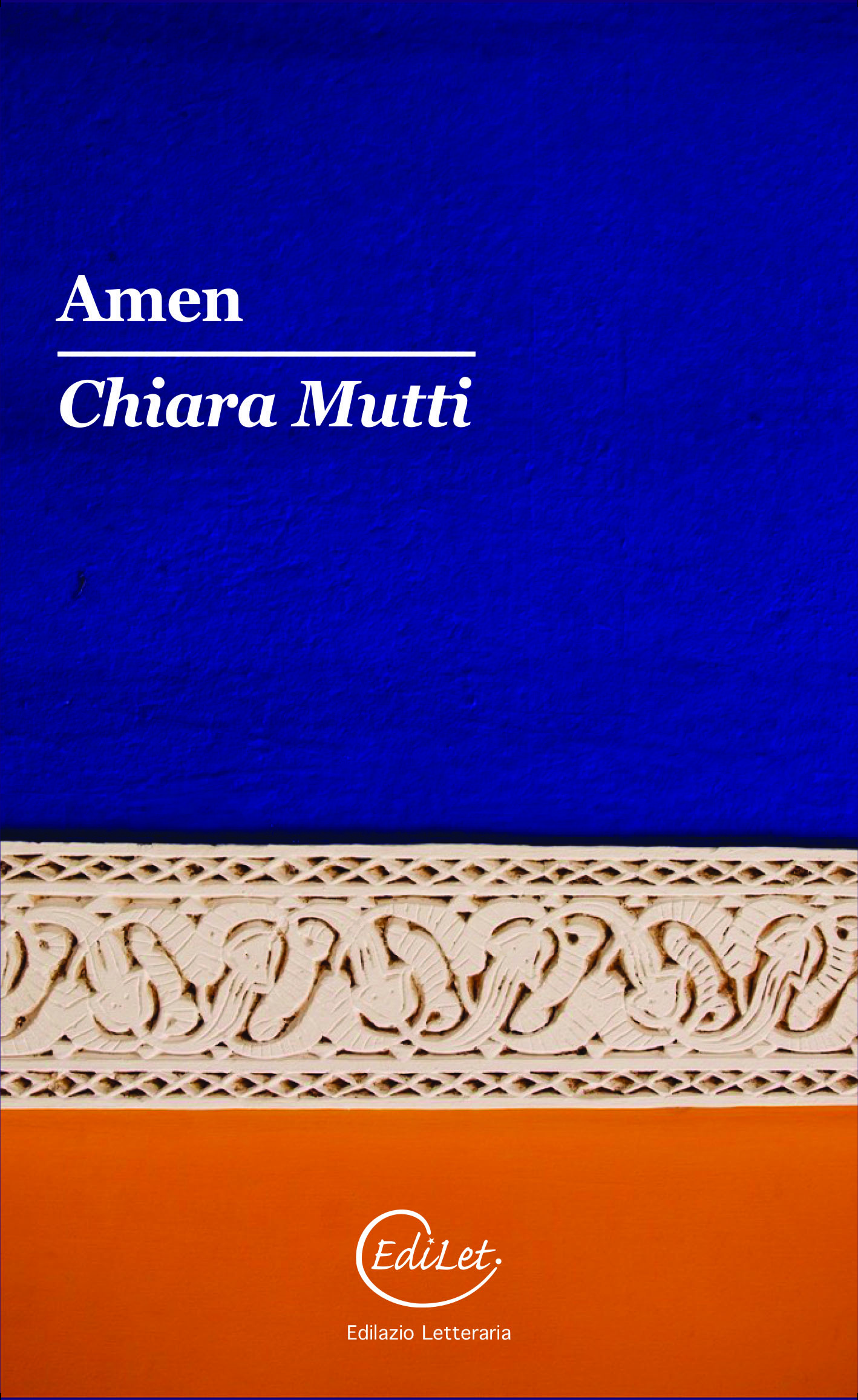
*
Quando suo padre morì, vent’anni dopo, si era già imposta di precludersi alla sua vista, alle sue mani, alla sua voce per il resto della sua vita. Si rifiutò di andare al suo funerale ma gli concesse una corona di fiori. Era consolatorio, pensava, che quella corona fosse lì in sua assenza, era consolatorio e vendicativo. Ma così facendo lo tratteneva con sé. Le ci vollero altri dieci anni per risolversi a lasciarlo andare: “Ora sediamoci qui, uno di fronte all’altro, come non siamo mai stati in grado di fare. Potremmo scegliere il muretto del noce, ricordi?”
“Attorno al noce” diceva suo padre, “metti le pietre una sull’altra” e lei le faceva combaciare scegliendole una per una, che combaciassero perfettamente. Una per una, perché rivelassero la loro parte migliore. Anche lei, come quelle pietre, avrebbe voluto mostrare la sua parte migliore! Aveva sempre la capacità di stimolare il suo orgoglio: era bravo a elargire consigli, a dare la direzione, a sollecitare, a indurre, a manipolare il suo bisogno di piacergli. Aveva nella sua bella voce, bassa, con una elegante francesissima pronuncia della erre moscia, qualcosa che l’attraeva, che la convinceva, come se rivelasse una particolare sapienza; una padronanza del mondo, pensava, capace di svelarne i misteri.
“Anch’io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura”…“ma chi ascolta me vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male.”
Giulia immaginò di sedersi proprio attorno a quel noce, sul muretto di sassi che aveva tanto amorevolmente costruito, e finalmente aprì gli argini dando libero sfogo al fiume delle sue parole:
“Ora sono io che faccio i conti con te, sono qui a fare i conti perché non avanzi niente, a rinfacciarti i dolcetti di marzapane e l’amore sprecato per la tua persona, i tuoi monologhi ascoltati come fossero oro colato, e tutte le volte che li hai smentiti con la tua condotta, gli sforzi per aderirti e la sensazione di non valere mai abbastanza, il rifiuto e il senso di colpa per il rifiuto, la delusione e la rabbia e la rabbia e la rabbia.
Sono qui per dimenticare la paura del buio, per perdonare l’abbandono, per vincere il senso di colpa, per onorare la furia della rivolta, per abbracciare me stessa.
Sono qui a dirti che ho smesso di essere te e il contrario di te, e qualsiasi persona tu abbia voluto che fossi.
Sotto l’albero mi sono seduta, ho liberato dal laccio il mio piede, posso vedere l’istante prima e tutti gli istanti dopo quel primo istante, anche se posso comprendere solo una parte del tutto.
Ora che sono libera sono ancora una volta sola, ma posso essere cielo, vento, terra, albero e sono acqua che scorre.”
Non è dato sapere come abbia reagito il padre di Giulia a queste parole, né se si sia mai posto domande, in vita, a questo proposito, né se le sia poste dopo la morte. Non sappiamo d’altronde se esista vita dopo la morte, o meglio in che modo e in che forma la nostra energia si riunisca al cosmo.
Sappiamo solo che un padre non è altro che un uomo, pertanto fallibile. Non è il superuomo che avremmo desiderato che fosse! E allora prendiamo la nostra vita e lasciamo che scorra: nessuna diga, per quanto robusta, potrà rallentarne il corso, e quella diga che abbiamo tanto attentamente costruito, con gli errori degli altri, non è altro che la nostra paura di vivere.
A quell’uomo che Giulia ha tanto amato e odiato io oggi dico: “Va’! Riposa in pace.”
Amen

– Uno dei temi principali ravvisabili in “Amen” è quello del perdono. Come lo intendi? Come lo hai affrontato nel corso del libro?
– Non parlerei propriamente di perdono, non nell’accezione cristiana del termine. Si tratta di accogliere e accettare la realtà dei fatti per quelli che sono e di superare il proprio rancore. Diciamo che è qualcosa che, prima di tutto, concediamo a noi stessi per crescere ed essere liberi, e così raggiungere uno stato di pace e consapevolezza. La chiamerei più poeticamente un’epifania.
– Sostanzialmente sei conosciuta come poetessa. Com’è stato passare dai versi alla prosa? C’è un rapporto possibile tra la Poesia e la Narrativa?
– Senz’altro nasco poetessa e, a mio avviso, continuo ad esserlo. Nel senso che si tratta comunque di prosa poetica. Il romanzo segue altre vie, ha delle regole ben precise e nasce da altri presupposti ed io temo di essere troppo indisciplinata per seguire delle regole, finisco per seguire il mio impulso creativo, che è sostanzialmente di natura poetica. Per contro la prosa dà sicuramente maggiore libertà formale e questo mi ha permesso di esprimermi maggiormente.
– Sei stata già tradotta in Romania e hai in preparazione un libro di poesie in Francia, in edizione bilingue. Qual è il titolo? Che emozione provi nell’essere tradotta?
– Sì, il libro è ancora in fase di lavorazione ma dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno con il titolo Murmures (Sussurri). Essere tradotti in un’altra lingua dà una grande emozione: significa portare i propri versi in un’altra dimensione, varcare i propri confini, non solo geografici ma anche umani. Provo una grande riconoscenza per chi si adopera nell’arte della traduzione, per la difficoltà che comporta e per la grande cura, l’attenzione che offre ai nostri versi. Il francese è una lingua che amo anche per le sue sonorità.
Ora vorrei tentare di portarmi alle radici dello sguardo poetico di Chiara: “strazio” e “struggimento”, secondo me, rappresentano le parole-chiave. È la temperie autunnale dell’anima, il cammino della caducità che segna d’ombre-luci il trascolorare inesorabile della decadenza. Percepisce così la fine ininterrotta delle cose, attimo dopo attimo, ma questo non le impedisce di adorare la realtà, anzi l’aiuta ad estrarne il sacro e ad abbracciarne la bellezza attraverso un manto di malinconia, di dolce tristezza che rende sostenibile e quasi caro il dolore che prova.
– Quanto influiscono le tue origini lombarde nel tuo modo di guardare e sentire le cose? Per esempio nel tuo modo di descrivere il paesaggio… E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– Influiscono molto, non solo nel mio modo di descrivere il paesaggio: contribuiscono a creare un mio personale paesaggio interiore e influiscono, anche se parzialmente, nel mio modo di intendere la vita, pur non avendo mai vissuto stabilmente in quei luoghi. Forse le nostre origini sono inscritte nel nostro DNA e in qualche modo costituiscono un nostro patrimonio etico, oltre che genetico. Ho molto caro quel senso di lontananza che provocano i grandi spazi della pianura padana, i cieli rosa nell’aria gelida e limpida dell’inverno che fanno da sfondo ai filari di pioppi, le imperscrutabili nebbie e la bruma gelida che risale i canali, il senso di dolce, struggente malinconia e le tante suggestioni che ne derivano.
– E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– C’è tanto anche di romano e di laziale, Roma è la città dove sono nata e dove lavoro, dove quindi vivo gran parte della giornata. È una signora zozza e un po’ cafona che non smette mai di sorprenderti, di commuoverti con la sua sconvolgente bellezza e di sfiancarti con i suoi perenni contrasti. Ad ogni angolo trovi qualcosa che non avevi ancora visto o che, pur avendolo visto, ti sorprende ancora e ancora. E la luce che si riflette sui muri rossi e giallo ocra dei vicoli di Roma… una luce diafana trasparente… E i rumori, i suoni più prossimi che, in certe strade, ti giungono come da infinite lontananze, echi di rumori. A Tivoli vivo, o per meglio dire dormo, ormai da molti anni. È una cittadina bellissima, ricca di vestigia e di ville patrimonio Unesco. Senz’altro diversi miei componimenti sono ispirati ai suoi panorami ed alle atmosfere che li animano. Mi piacerebbe però che i tiburtini imparassero ad amare di più la propria città, a rispettare e far rispettare il bene comune. In questi ultimi anni ho visto dei progressi per quel che riguarda il turismo, ma ci sarebbe ancora da fare molto! Poi ho vissuto in altri luoghi, e infine ci sono le città d’elezione, le città simbolo, le città sogno. Un poeta ha un forte legame immaginifico con le proprie città, le mie sono tante ma non mi sento legata a nessuna in particolare, pur amando Roma sopra ogni altra.

– Che cosa bolle in pentola? Quale sarà il tuo prossimo libro?
– Non faccio quasi mai programmi, vivo la letteratura e la poesia per ispirazione e per quel che viene giorno per giorno, leggo molto, scrivo poco, o comunque con delle lunghe pause tra una pubblicazione e l’altra. Se volessi però dare una risposta un po’ più concreta, e svelare un mio vecchio sogno nel cassetto: mi piacerebbe realizzare un libro di fotografie. Poi l’idea di rimettere mano alle mie poesie giovanili, già da qualche tempo mi ‘frulla in testa’, chissà che prima o poi non la realizzi.
– Lavori al Ministero della Cultura. Non voglio metterti in imbarazzo, ma secondo te dove sta andando la cultura italiana?
– Ehm… c’è una domanda di riserva?! Sarò sincera, non mi sento molto positiva al riguardo: immagino stia andando lì dove sta andando l’Italia. Ma forse in questo momento, dopo l’ennesima riforma del Ministero, sono un po’ contrariata. La missione principale, a mio avviso, resta sostanzialmente la tutela e la conservazione del bene e questo, checché se ne dica, comporta essenzialmente costi, oltre che grandissimo impegno e competenza. Potremmo diventarne ricchi? È un’attività che non dà ricavi: è un servizio atto a preservare il bene e a impedirne la distruzione. Poi sì, c’è la valorizzazione e la promozione, che, a mio avviso, dovrebbero garantirne la conoscenza e l’accesso da parte di tutti i cittadini. Ma anche questo aspetto non può diventare un business, perché altrimenti vorrebbe dire rendere la cultura un privilegio per pochi. Quello che ho trovato, invece, positivo nell’evoluzione del concetto di bene culturale in questi ultimi anni è stato il modo di ripensare lo spazio culturale, renderlo interattivo, cioè coinvolgere il cittadino nelle attività culturali… ché poi renderlo partecipe significa anche renderlo corresponsabile del bene stesso, quindi contribuire alla sua tutela, e così il cerchio si chiude.
(a cura di Marco Onofrio)

Chiara Mutti, autrice di origini lombarde (bresciane e mantovane, per l’esattezza), è nata a Roma, vive da 30 anni a Tivoli e lavora al Ministero della Cultura in qualità di funzionario per le tecnologie. È appassionata di archeologia, antropologia e fotografia. Ha pubblicato tre raccolte poetiche – “La fanciulla muta” (Lepisma Edizioni, 2013), “Scatola nera” (Fusibilia Edizioni, 2016), “Archeologie del cielo” (Terra d’ulivi Edizioni, 2019) – con le quali ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Con “Amen” (EdiLet, 2023) ha pubblicato il suo primo libro di narrativa.
















