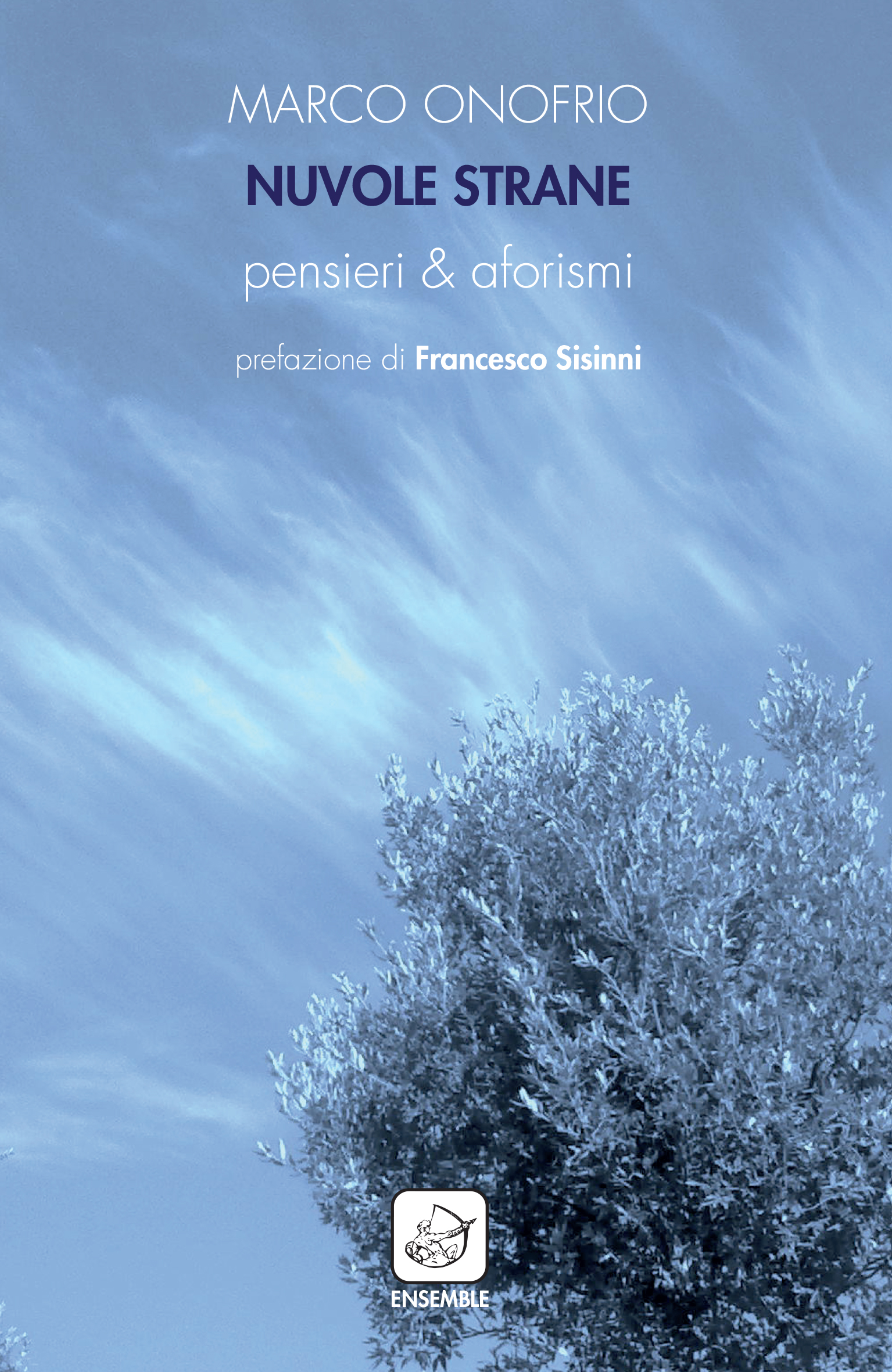Questo secondo libro di racconti di Palmira De Angelis, dieci anni dopo il felice esordio di Ultimo banco, è bello anzitutto perché ben scritto. E non è poco; in tempi di sciatteria letteraria istituzionalizzata, riporta in auge la scrittura come “composizione” equilibrata di elementi: contenuti, dettagli, simboli, sfumature, orchestrazione sinfonica dei periodi e “alchimia musicale” nell’incontro delle singole parole. Insomma, un prodotto narrativo consapevole dove finalmente la scrittura non gira a vuoto su se stessa intorno a un cardine inconsistente, ma nasce dalla Vita come estratto quintessenziale dell’esperienza.
Qualcuno ha coniato il neologismo “scrivivere” per segnalare la necessità assoluta di scrivere che impregna e impegna la vita di uno scrittore: la sua vita “è”, integralmente, la scrittura. La scrittura della Vita, rivissuta, pensata e immaginata a partire dalla propria esperienza. Quelle cose, chi scrive, non può non dirle: lo scelgono per dirsi e lui se ne fa strumento pur di portarle alla luce.
A parte i colori (Ensemble, 184 pagg., 15 euro) racchiude in volume 15 racconti che nascono dalla Vita: la vita di Palmira De Angelis e di ognuno di noi. Della Vita l’autrice ci fa sentire tutto il lato problematico: l’impaccio, lo sgomento, lo sconcerto, la vergogna di essere, e i tentativi spesso patetici di arginare il vuoto e oltrepassare il dolore, ingegnandosi per essere felici. Sono racconti che spesso nascono da “qualcosa di luttuoso”: una “sensazione di tetraggine” e di paura, “come trovarsi sull’orlo di un burrone” verso uno “sprofondo di morte”. C’è qualcosa di non detto perché indicibile, un “trauma originario” di cui il racconto è reperto e risvolto, ellittico del suo nucleo di verità. Una frattura del tempo che ha prodotto lacerazioni invisibili e permanenti: dopo di allora nulla è più stato come prima.
La Vita grazie a Dio è ricca di cose bellissime (l’autrice lo sa: “c’è anche la gioia”, scrive nelle ultime pagine del libro), ma qui dispiega il suo “fado” e il pensiero stesso della sua musica soprattutto come sforzo, patimento, afflizione, immensa fatica e noia del suo trito grigiore.
E quindi leggiamo:
“Vissero felici e contenti: ci si ferma sempre qui nelle favole perché non puoi mica raccontare tutto il tran tran delle giornate”;
“C’erano stati solo giorni e giorni, tutti uguali, giorni che erano l’unità di misura della sua vita, uno dopo l’altro, uno dietro l’altro, come tanti vagoncini di un trenino merci pieni fino all’orlo, di un trenino veloce che non si fermava mai”;
“Uscivi la mattina e tornavi la sera. In mezzo c’era la vita. Quand’è che s’è spezzato, s’è rovinato tutto?”
In mezzo, appunto, c’è la Vita, che ci scorre davanti agli occhi mentre siamo sempre impegnati a fare qualcos’altro, e che ci sfugge come il ricordo di un sogno lontano, dai contorni imprecisabili. Ed è qualcosa di imperfetto e di incompiuto per tutti: “come una frase cominciata e lasciata a metà”. E ancora: “un discorso che comincia bene e poi all’improvviso s’ingarbuglia”.
Da una parte le aspettative, dall’altra la dura realtà. Inganno e disinganno. Speranza e disperazione. Il mondo delude le nostre aspettative, con la sua realtà furente e feroce “di schifo, di furbi, di puzza e di rabbia”. Il mondo creato dagli esseri umani, beninteso; non la rerum natura, con la “magnifica gloria di ciò che è vivo, immutabile ed eterno”. Per capire l’atrocità dell’uomo, traumaticamente percepita alla luce della sensibilità poetica, c’è una immagine indimenticabile: i pesci che agonizzano al supermercato. «I pesci non erano morti del tutto, avevano la bocca aperta e l’occhio fisso, ma le branchie si muovevano, si aprivano e si chiudevano piano piano. (…) Poi c’era un pesce lungo e nero, come un’anguilla, che ogni tanto provava a srotolarsi, chissà, forse provava a scappar via. (…) Una strage in piena regola. La gente vuole essere sicura che il pesce è fresco, ma è come guardare un condannato a morte mentre viene giustiziato».
Qual è la soluzione? La risposta dello spirito, cioè la Poesia: il vascello fuori posto (un modellino che al supermercato ha funzione pubblicitaria ma che nessuno guarda) viene rubato dai due ragazzi protagonisti dell’omonimo racconto (“Il vascello”), e riportato al “posto d’onore”, cioè nell’alveo della sua “inutile” e per questo autentica bellezza. E dunque: ricollocarci al cardine delle cose essenziali, proprio nella misura in cui il mondo ci trascina altrove.
L’esistenza delle persone è un ciclo inconcludente, segnato dallo sforzo vano: come quello dei tassinari molisani a Roma (sintetizzato nel racconto “I giorni della merla”: una vita ad ammazzarsi di lavoro, per poi arrendersi al cancro) o emblematicamente rappresentato dalle fotografie dei turisti, incorniciate nei salotti del pianeta per mostrare “come si era una volta, prima di ingrassare, dimagrire, prima di ammalarsi”.
Ecco il silenzio dello spazio quotidiano, lo spessore del tempo, gravido di pensieri e ricordi: “In cucina si sentiva solamente il motorino del frigorifero che ripartiva e dopo un po’ si rispegneva, e in queste giornate di tramontana la porta che ogni tanto sbatteva piano”. E quindi l’attitudine all’ascolto che caratterizza i personaggi: “ascoltava ad occhi chiusi tutti i rumori”, si legge ad esempio a p. 38. Che rapporto c’è tra il silenzio della casa e il silenzio della Storia? È sui fondamenti invisibili di questo vuoto che si crea il mondo, e noi ne siamo coinvolti fino a consumarci di “resistenza”.
Il cuore di ognuno di noi è ingombro di fantasmi, e a un certo punto scocca l’insight, la rivelazione, il pensiero che “si affaccia” improvvisamente tra le pieghe del quotidiano, magari mentre si è seduti al tavolo della cucina e si puliscono gli spinaci da lessare per la cena. Dunque si leggono frasi come “all’improvviso ho visto, ho veramente visto”… “gli tornava in mente ora”… “le tornavano in mente le cose del passato come fossero di un’altra vita”… “le è venuto in mente all’improvviso, mentre era sull’autobus”… La vita interiore domina le azioni dei personaggi: è una forza incontrastabile a cui la coscienza deve sottostare: “non poteva evitare che rapidissimamente gli passassero davanti agli occhi le scene”.
Il passaggio dalla Realtà al Sogno, che questi racconti continuamente articolano, parte da uno stato permanente di macerazione (cioè di scansione analitica del tempo attraversato) per arrivare, semmai, alla fosforescenza fuggevole della rêverie, dove può ancora sopravvivere – come in una riserva – l’incanto del mondo immaginario. Sono personaggi, soprattutto le donne, a cui piace pensare e fantasticare. “Penso e ripenso” potrebbe essere il loro slogan. Per esempio, a p. 29: “Questo le succedeva anche quando era ragazza e andava a scuola. Anzi, andava male a scuola proprio perché il pomeriggio, quando doveva fare i compiti, non riusciva a smettere di pensare”. Ed ecco, ancora, la definizione della “lettura divagante”: “È che quando mi metto a leggere la mente comincia a vagare e dopo due ore che sono lì seduta con il libro in mano sono avanzata sì e no di cinque pagine. Ogni parola del libro diventa la prima di un discorso mio che continua, parole mie, i miei pensieri che se ne vanno a spasso”. Questo sono, anche, le parole così come le usa Palmira De Angelis nei racconti: porte girevoli che socchiudono scenari sulla complessità umana dei personaggi, sul loro destino, sulle storie di cui si accenna e si lascia appena intuire. Ad esempio il divano comprato, con le cambiali, nel lontano 1969: “Francesco al liceo non poteva invitare gli amici a casa per quel divano vecchio che avevate, di finta pelle rossa con le molle rotte”. Basta un dettaglio per evocare un mondo. Da cui l’attenzione ai minimi particolari, l’importanza decisiva dei “fattori invisibili all’occhio” che si rendono visibili grazie alla capacità di saper cogliere gli “indizi” e di “frugare bene tra le verità sepolte” per capire “il perché”.
La verità delle verità, però, resta sempre irraggiungibile: “rimestare nel passato. Per trovare i collegamenti, le cause. Ma più guardi indietro e più dimentichi. Più ci pensi e più tutto cambia”. Per questo Palmira De Angelis ripudia la prospettiva del narratore onnisciente e predilige la struttura “aperta” di una narrazione mai apodittica o viziata di prospettivismo, da cui il lettore uscirà con più domande e meno risposte di prima. La Vita stessa è soggetta all’imponderabile, in una dimensione fluida e precaria dove la fine delle cose è sempre in agguato. Ogni attimo passa per sempre e non ritorna, come scopre con rammarico il ragazzo che allo stadio di Londra, durante Arsenal-Fiorentina 0-1 del 1999, si lascia sfuggire il gol decisivo di Batistuta, e “intanto pensavi che se fossi stato a casa, davanti alla TV, l’avrebbero rimandato subito il gol, quattro o cinque volte, da tutte le prospettive”. Meglio esserci e vivere dal vivo, sia pure con limiti percettivi, o avere della realtà un’esperienza completa ma artificiale (come quella dell’immagine televisiva)? Meglio – senza dubbio – esserci autenticamente, a costo di un’esperienza labile e parziale! Meglio essere allo stadio! Cioè, immergersi nel pathos della Vita in fieri, in attesa del kairòs, l’attimo fuggente e decisivo come un gol, grazie a cui la vita cambierà… oppure no.
A questa imperfezione costitutiva del reale si contrappongono le virtù riparatrici e medicamentose della Poesia, intesa come Poìesis, attività estetica di ricomposizione delle forze del mondo attraverso l’armonia dei suoni. Per questo è possibile parlarne anche in sede di narrativa: a prescindere dal fatto che anche la prosa è una “scatola di suoni” soggetta a regole metriche e ritmiche, Palmira De Angelis dà una perfetta e forse inconsapevole auto-definizione della propria scrittura quando, nel racconto “La signorina Rubì”, mette in scena una inedita e appartata poetessa, ammiratrice di Guido Gozzano, alla costante ricerca della “parola che s’accorda col suono”, legata e piegata al ritmo di un’idea, per cui il tono deve essere colloquiale, il fraseggio compiuto e melodioso, la visione chiara: “tutto deve essere dato, con immediatezza e con semplicità”. La leggerezza nasce da un lavorio intenso e nascosto che ricorda lo “stile dell’anatra” di Raffaele La Capria. Così è, di fatto, la scrittura di questi racconti.
Epperò Poesia è anche “scavare tra una parola e l’altra piccole trincee” dove lasciar trapelare brividi e palpiti inquieti, e soprattutto rovistare tra le immondizie alla ricerca della perla, convinti che proprio là è possibile trovarla. Così anche la realtà caotica di Roma – declinata attraverso toponimi come Testaccio, Castro Pretorio, Piazza Vittorio, Villa Borghese, Tiburtina, Nomentana, Tuscolana, etc. – trova, nonostante il degrado, la sua appassionata trasfigurazione poetica: “E questa è Roma. (…) Ed è amore che sente. Non è lei stessa la prima ad esserne sorpresa? Ama l’aria fresca dopo il caldo afoso nella metro. Ama le automobili, gli autobus, i turisti che ingombrano il marciapiede (…) le colonne antiche sdraiate sulle pietre antiche, i piccioni, l’arco di Costantino, tutto”. In quel “tutto” c’è ogni altra parola dicibile e l’accordo mediante cui entrare in consonanza, perché apparteniamo insieme al mondo umano. E nell’incognita delle occasioni può nascondersi tutto il bene o il male che ci attende, e non potremo mai sapere come sarebbe andata se invece… o come sarà dopo la fine delle storie… un po’ come al cinema quando il film è finito e sei già ai titoli di coda, mentre la gente si alza per tornare alla realtà.
Non è chiaro, insomma, se il timone della vita è nelle nostre mani o tutto accade per conto suo: “Tutto è diverso, eppure tutto è uguale. Non cambia niente. O forse no”. Il libro conclude, peraltro, con la consapevolezza di un tempo meno irreversibile. “Questo ho capito. Si può cancellare e riscrivere. Cancellare e riscrivere”. Come quando si compone un racconto al computer, il che ci dà speranza. È forse in questa capacità di rispecchiamento reciproco tra Letteratura e Vita il valore umano più importante di “A parte i colori”, e uno dei motivi più validi per leggerlo.
Marco Onofrio