
Tag: Poesia
“La memoria dell’ombra”, di Stefania Di Lino. Lettura critica
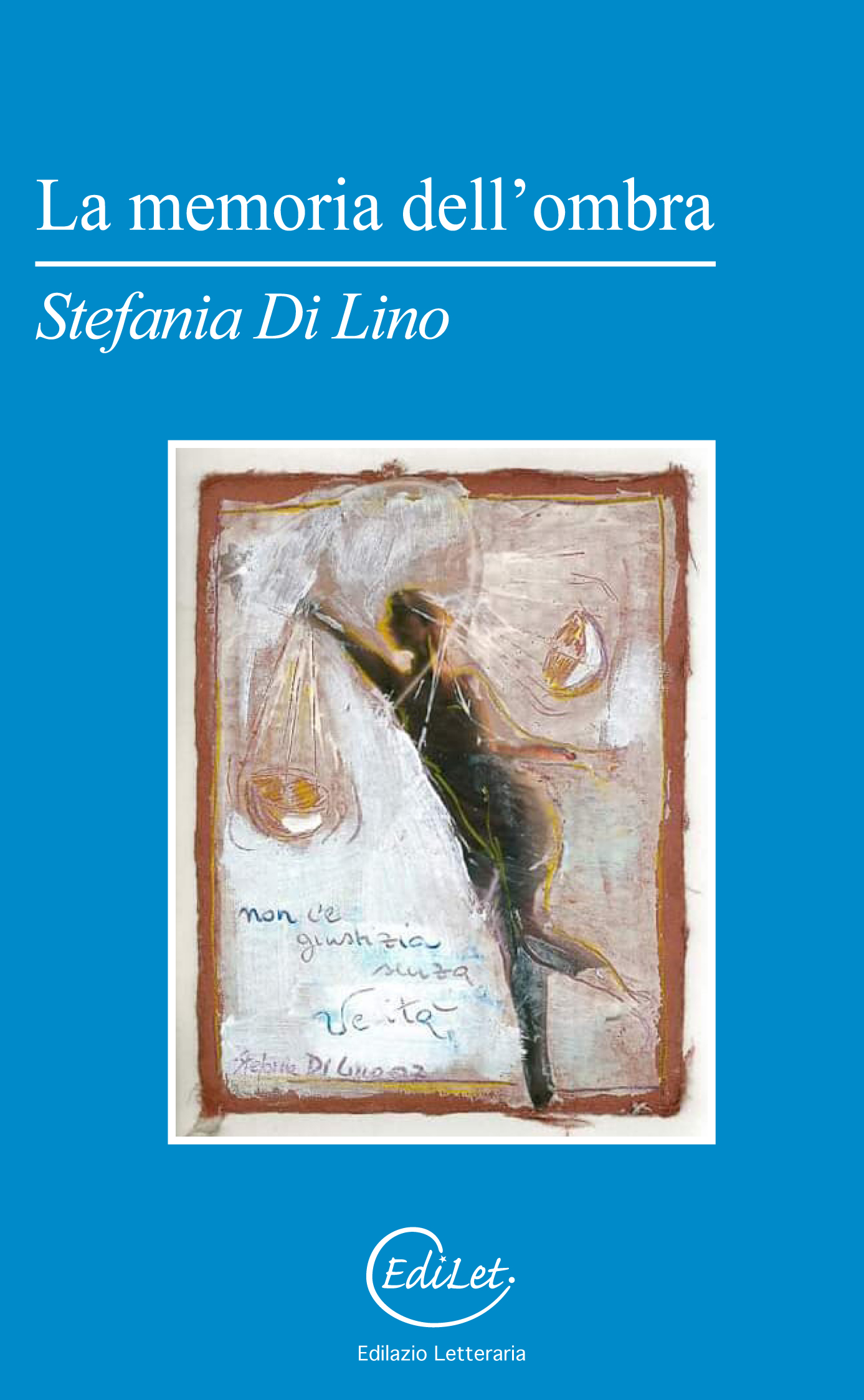
In questo suo quarto libro (La memoria dell’ombra. Poemetto, EdiLet, 2024, pp. 96, Euro 13), Stefania Di Lino accentua e acuisce la vocazione metapoetica che talvolta affiorava nei precedenti: focalizzare e definire la misura del proprio dire, diventandone l’oggetto e facendone a sua volta un possibile “correlativo soggettivo”. Il poeta può parlare di sé e del mondo anche mentre riflette sugli strumenti umani dell’espressione poetica. Una delle domande sottese in tutto il poemetto (tale è, di nome e di fatto, data la coesione che lega le singole composizioni) è infatti: che cos’è la poesia? Che cosa le è dato di poter essere e fare?
Non a caso la quarta di copertina riporta, dal testo, i seguenti versi: “la poesia nasce / dagli argini rotti della parola / è un dire cosa / che altrimenti non sapremmo”. E non sapremmo altrimenti perché solo in quel modo potremmo dirla. Pensiamo alla parola del vocabolario: essa opera un “travaso normativo” che riduce la complessità infinita delle cose. Contiene perciò il significato convenzionale, quello normale e consueto che utilizziamo per comunicare. La parola poetica nasce quando il contenitore della parola del vocabolario non basta più: è magma che cola dalle sue crepe, è luce che balugina dalla scorza del significato che si apre. Stefania Di Lino traguarda ulteriormente: ha bisogno della “parola segno”, della “parola gesto” capace di processare e performare la profondità. Infatti scrivendo cammina “sull’impervio confine liminale” (appunto limen, soglia che divide ma unisce al contempo) “tra la terra promessa e quella perduta”, vale a dire tra il non più e il non ancora; laggiù, sul bordo dell’ignoto fin troppo noto, esplora il “crinale scosceso di una lingua sconosciuta” che appunto nella poesia sa, deve, vuole dirsi.
Ecco dunque la poetica fondamentale di una scrittura che ha luogo “tra il dire e il non dire / e talvolta si mostra tacendo”, pronunciata magari “a fior di labbra”, per far conoscere cose “da sempre sapute”: ma saperle non vuol dire conoscerle, dato che l’abitudine ottunde la percezione fino ad annullarla. Qualche esempio? Il rumore continuo sfuma nel silenzio (chiunque abiti accanto ad una ferrovia, come noto, non fa più caso al passaggio dei treni). E il dolore cronico produce anestesia. E ancora: avere sempre qualcosa sotto gli occhi, lo rende invisibile, ecc. Il poeta è un sabotatore a servizio della verità. Svela gli inganni e de-automatizza gli sguardi, portandoli alla consapevolezza. Toglie polvere dagli occhi e solleva pietre dai giorni. Anche se poi resta sempre il muro della terra, la parete invalicabile dell’ultimo spessore divisorio. E “un peso / oltre la misura del cuore”, da cui non è possibile affrancarsi. La poesia è un’operazione di coscienza critica: procede attraverso l’“autopsia del cuore” nel tentativo di “trovare ragioni allo schianto”: da quello cosmico del Big Bang a quello che ci scoppia dentro ad ogni battito del cuore, e ogni volta che prendiamo contatto con la realtà dell’assurdo in cui siamo immersi. Certo, per sopravvivere occorre dimenticare la verità; ma appunto la poesia vuol farci vivere, non solo sopravvivere! Ho letto qualche giorno fa su Internet questo monito: “ti chiederanno di scegliere tra affondare o galleggiare. Tu scegli di volare!”
La poesia di Stefania Di Lino ha una vocazione civile che non appare vistosamente, dacché non la esibisce mai in “posa”; ciò le consente di restare immune dal difetto comiziale-tribunizio, tipico di molte scritture impegnate. È, semmai, autentica: nasce dal dissenso sincero, dalla ricerca eslege della verità. È un atto di disobbedienza incoercibile; non si può vietare di pensare, così come non si può bloccare l’avvento della primavera o il fiorire dei prati. Penso a Tommaso Campanella e ai 27 anni di ingiusta prigione che non gli impedirono di scrivere “La città del sole” senza disporre di carta, quindi a mente! Incidendo le parole del libro nella sua prodigiosa memoria. L’uomo è forte ed è in grado, se davvero vuole, di oltrepassare qualunque ostacolo. Stefania Di Lino parla di “libertà indomita”, cifra che approvo e in cui mi riconosco completamente. La scrittura è “spietata luce”, e deve esserlo per esercitare la sua pietas. C’è sovrapposizione simbolica di luce e lama, di ispezione conoscitiva e strumento per tagliare. Parla infatti di “bisturi affilato” e “fendente raggio laser” che purifica mentre esplora e avanza. Il poeta “incide” le cose, e la sua penna è una “punta di coltello”: anche per ferire e uccidere, se necessario. L’arte si “annida nella forma”, è segreto cuore dell’apparenza. Lo svelamento può essere esercitato come lettura in filigrana e controluce; ma anche e soprattutto come scavo: “pietre da cavare / parole dure da masticare / (…) e tutto l’indigesto da digerire”. La poesia è un digestivo, forse, ma è a sua volta indigestibile (cioè non digeribile, e insieme non gestibile). Elabora infatti gli “eoni dell’inquietudine” confrontandosi col Perturbante di certe immagini: da quella terribile ed emblematica di pag. 40 (“ho messo una testa di Medusa al posto del cuore”) alla preda “impigliata nella ragnatela” che “per poco ancora vibra”, alla ferita sempre aperta e sanguinante da cui “sgorga la parola”, all’“atroce tonfo” che chiude la rovina del corpo, ai giorni che come sangue “gocciolano graffiati”, ecc.
È un percorso accidentato e sconveniente, politicamente scorretto, che implica il coraggio di chi scrive e, di conseguenza, quello di chi legge. Non è un libro per struzzi, in attesa o in procinto di nascondere la testa nella sabbia. Stefania sfonda tutte le pareti per arrivare alle questioni fondamentali, e dunque alle domande ineludibili: ad esempio “cosa rimane di noi e dei giorni passati?”; “dove porteremo il nostro sangue?”; “in quale terra / e con quale umanità continuare?”; “dove comincerà l’incendio? / dove verrà acceso il primo fuoco?”, ecc. Ecco l’importanza dell’ombra e della sua memoria, l’identità metafisica e il doppio evanescente del nostro corpo, a ricordarci che siamo fumo di attimi in volo. Ecco perché “nell’andare” occorre “ricordare sempre la propria ombra”, l’ombra che ci riporta alla verità della nostra condizione, poiché richiama la presenza del corpo che fa schermo alla luce, ma anche la sua evanescenza.
La poesia si profila anche come terapia e cura contro “la ferocia del tempo e degli uomini”, sapendo che “quella che più duole” è “una morte non morte”, cioè la vita non vita che uccide la nostra autenticità e la nostra anima ogni giorno. Così il diavolo tortura le anime all’inferno: mantenendole in attesa, perennemente sospese nell’irrealtà. Così tirano avanti gli alienati, gli automi disumanizzati di cui l’atroce macchina della Storia ha bisogno – come di ingranaggi – per andare avanti. Il poeta attraversa l’inferno, il “buco nero chiamato dolore” per ricucire “con punti invisibili gli strappi” e le “mute lacerazioni”. È un Orfeo che cerca “il punto più alto / da cui la notte precipita”. Poesia, allora, “è fare del dolore musica”.
Stefania registra lo sconcerto dei nostri tempi, il “frantumarsi del credo” (ovvero l’impossibilità di credere a qualunque cosa, poiché tutto sembra diventato in-credibile): “tutto ora è aperto alla follia / è l’atroce delle cose esplose / sono i resti sparsi”. Siamo inetti, impotenti, disillusi, scoraggiati. Ci vede “ai posti di smarrimento”, anziché a quelli di combattimento. Al poeta non resta che scrivere sulle macerie stesse “la poesia dei ruderi”: “Scrivo come fossero tutti morti / o come fossi morta anche io”. Non solo le conseguenze, ma la loro analisi a ritroso, fino alle cause prime: non solo “la purulenza dell’odio / l’incuria mortale del disamore”, ma anche il “male nascosto nel seme che nessuno vede” perché è alla radice, e infatti aggiunge male al male, e “intacca contagia recide / lega e sporca”. Eppure Stefania Di Lino esercita la capacità eroica di “cavare energia dal niente”, di non rinunciare a “far nascere” e a “far venire alla luce”, a rispondere agli appelli del mondo, nonostante tutto, “se chiamati da una voce di madre” che sappia di origine e sorgente. Accenna talvolta a dimensioni nascoste e ancestrali, psicanalitiche del profondo, gnostiche e quasi escatologiche: una specie di “controtelaio” occulto della realtà, a cui tendono i sogni, che infatti “sono tasselli vividi / tessere lucide di un mosaico antico da ricomporre”. Parla di “spazio obliquo interstiziale” dove avvengono “minime le cose care” e le invisibili metamorfosi del tempo. È nell’ombra che dimora l’incanto, e in essa deve immergersi la mente per raggiungere i livelli della sua vita estatica. Ci sono composizioni in cui il soggetto si spersonalizza completamente, materializzandosi e vegetalizzandosi, abbracciando la frequenza inconscia della vita istintiva, il “neutro” dell’ES da cui, forse, sale il dolce richiamo delle maree, la tentazione di andare giù “fino all’origine del sangue”. Scrive allora di “tana verde”, “cuore di pietra antica”, “muschi e licheni”, “occhi di bestia” che “brillano / dello stesso luccichio della luna”. È il mondo senza di noi, al di fuori di noi, la dismisura oltre la nostra misura. La memoria stellare dialoga con la memoria animale e con la memoria cellulare: è anche questa, ritengo, la “memoria dell’ombra”.
Stefania Di Lino intesse un profondo elogio della diversità, scrive per “gli irregolari / i randagi i marginali” che incontra quando esce di notte, solitaria viandante, per vivere Roma oltre i fondali della città teatro. Lei stessa così si definisce: “ma io sono una che arriva / quando gli altri vanno via / appartengo alla genia dei fuori tema / degli inattuali”. Aleggia in tutto il libro un grande sogno di libertà, anzi di liberazione, che è spinto dal vento dell’esistenza e a sua volta si dispone a spingerlo, a soffiarlo dentro e intorno a noi per fomentarci al riscatto, alla vera evoluzione delle nostre vere energie. Tutto questo pur sapendo benissimo che la ricerca della verità è infinita e, per definizione, mai definitiva. Anche la ricerca poetica: “si cerca ancora / lungo esercizio / è la parola”. Ecco perché le poesie di Stefania dispongono i versi di seguito, in orizzontale, come una finta prosa, e soprattutto terminano sempre con la virgola, a indicare un movimento che non conclude ma rinasce sempre da se stesso. Come la vita.
Marco Onofrio
“L’uomo che parla ai libri. 110 domande a Dante Maffìa” letto da Valerio Mattei
La definizione di “introduzione al personaggio” o “all’opera di”, riferendosi a L’uomo che parla ai libri. 110 domande a Dante Maffia, a cura di Marco Onofrio (EdiLet, Roma, 2018, pp. 88, Euro 13,00), è talmente riduttiva e fuorviante che nella presente recensione non si proverà neanche ad usarla. Questo libro, miracolosamente agile, data l’enormità dei contenuti che veicola, è un prodigio di sintesi, introspezione, speranza e nostalgia, carne e spirito, eterno e quotidiano e tutta un’infinità di categorie opposte, ma tali solo alla povera percezione della nostra umile mente lineare. La stessa che non sente mai che la Terra gira a velocità inimmaginabili, che crede ancora al tempo tic-tac tic-tac, che crede ancora che le cosiddette “cose” realmente entrino in esistenza una dopo l’altra solo per il fatto che la nostra limitata percezione mentale e cosciente ci arriva sempre e solo lentissimamente, così come un moscerino, posandosi su un libro in un pigro pomeriggio d’estate, potrebbe leggerne le parole di una singola pagina. Bene, L’uomo che parla ai libri va aperto con cautela perché rappresenta un vero e proprio vortice che all’improvviso ti risucchia in un panorama multidimensionale impressionante in cui la tua povera mente lineare non capisce più, non “sente” più la demarcazione tra ciò che è (sempre secondo lei ovviamente), ciò che è stato, e ciò che sarà. In queste pagine l’immagine di disperazione per una mamma inchiodata alla sedia da una tragica malattia, quando Maffìa era ancora un bambino, convive con il magmatico pulsare di tensioni innegabili (e candidamente innegate) intrise di amore, sensualità, sessualità vissuta al massimo dell’autentico e del trascendente, come trampolino verso lo spirito, verso l’assoluto.
Il diario di un uomo, prima e oltre che di un artista, di una persona sì, ma non al modo dei latini, anzi del tutto priva di qualsiasi maschera. Un uomo che ha vissuto sempre con il cuore sulle labbra e la poesia tra le dita. Un essere umano sapientemente corteggiato, svestito e poi ancora amato dall’altrettanto sapiente e sottile sentire di Marco Onofrio, che va aprendo inesorabile, una dopo l’altra, le 110 stanze di “Palazzo Maffia”, dell’imponente edificio culturale, spirituale e profondamente umano rappresentato da questo straordinario uomo d’ingegno, con la delicatezza di una colf esperta che ormai conosce tutto della famiglia che la ospita, apparentemente al mero servizio di un Maestro contemporaneo (e naturalmente della propria opera, “a cura di”), ma che in realtà svolge un ruolo indispensabile alla perfetta riuscita del libro e della sua incredibile autenticità mozzafiato. Non davanti a tutti infatti, il grande poeta, scrittore, saggista e molto, molto altro, Dante Maffìa, avrebbe messo a nudo la propria anima, la propria vita, fino ai più remoti recessi della coscienza, con un senso di relax tale che sembra proprio di partecipare a uno dei tanti convivi che Lui ama tanto.
Si provi ad immaginare un artista insignito della Medaglia d’Oro alla Cultura direttamente dal Presidente della Repubblica, un autore candidato al Premio Nobel da tutto il Consiglio Regionale (all’unanimità!) della propria Terra di origine (la Calabria) e da molte Università, Fondazioni e Comitati, in Italia e all’estero, uno scrittore tradotto in oltre venti lingue in tutto il mondo e che può vantare un’infinità di altri titoli e riconoscimenti, per non tralasciare una lunga e onorata carriera di insegnante che da sola giustificherebbe più di una vita intera. Ecco, dopo aver immaginato questo, si pregusti la sorpresa, la gioia disarmante, il sorriso beato che si schiude sulle labbra del lettore quando inizia a notare che la conversazione vira vorticosamente su… cosce femminili e sensualità! Ma anche sull’impellenza della scintilla divina alla base di qualsiasi opera, che altrimenti è pura ginnastica di polsi. Sì! Dante Maffìa, come Marco Onofrio, è “uno vero”, come si dice in questi casi. Sono entrambi ambasciatori della Luce, della Verità, della Magia! Nel senso che mai priverebbero una propria opera dello slancio, del fragore e della fragranza che solo un’esistenza profondamente calzata, gustata, leccata fino in fondo al piatto della quotidianità, può sprigionare.
Senza anticipare troppo, si legga per esempio la domanda n. 104 e la dissacrante chiusura della relativa risposta! E si pensi, inoltre, che un creativo tanto riconosciuto e acclamato si propone ancora oggi (domanda n. 108) “di far sentire i brividi di un bacio alle persone che sono state dissestate dall’aridità della carriera, del danaro, del potere”. Quei brividi si avvertono già solo a leggere una frase del genere! In epoca di mobbing, di guerre, di pandemie, in una società suicida sull’altare infame dei numeri e del soldo, ecco finalmente ergersi coraggiosa una voce che ancora osa parlare di Amore in concreta sincerità. E ancora, con affascinante candore si apprende alla risposta della domanda n. 109 che il suo più grande sogno, pure in un percorso così indiscutibilmente brillante, è ancora oggi “che qualche mio verso, che qualche mia frase o pensiero, venissero pronunciati anche senza il mio nome, come patrimonio che è stato acquisito dall’umanità.”
Si chiude l’ultima pagina di questo libro con un senso di affezione, come se si fosse trascorso un lungo weekend al mare con entrambi gli artefici di un’opera così straordinaria. Quelle di Marco Onofrio non sono domande. Sono perle di una collana magica che fin dalla prima pagina, ivi inclusa la preziosa introduzione di Rino Caputo, si ha la sensazione di indossare per prendere parte a un rito, un viaggio dentro e attraverso la vita di un interprete sublime del Libro Totale che la vita stessa rappresenta. Interprete talmente sublime che la Sua vita assurge a simbolo e metafora della vita stessa di ogni uomo. Un sentito grazie a Dante Maffìa per averci ospitato al banchetto della propria anima e del suo Mondo, moglie, figlie e nipoti inclusi, di cui traccia un quadro a dir poco commovente. E naturalmente grazie a Marco Onofrio per aver dimostrato ancora una volta che colui che si offre al servizio di un’opera con coscienza pura e devota, incarna ciò che Sting (ricordo che Marco Onofrio è anche un fine critico musicale, oltre che scrittore, poeta, saggista, ecc.) scriveva nel capolavoro dei Police, la mistica “Wrapped Around Your Finger”:
Devil and the deep blue sea behind me
Vanish in the air you’ll never find me.
I will turn your face to alabaster,
Then you’ll find your servant is your master.
(Il diavolo e il mare blu profondo dietro di me
Svaniscono nell’aria non mi troverai mai.
Trasformerò il tuo viso in alabastro,
Allora scoprirai che il tuo servo è il tuo padrone).
Valerio Mattei
“L’ingegnere del silenzio”, letto da Paolo Carlucci
C’è, nel cuore poetico dell’opera di Marco Onofrio, un pensiero cosmico che si frange in costellazioni di domande e stupori lirici nottilucenti. L’autore, come un filosofo delle origini, un presocratico, indagatore della natura, sente l’imperativo di una ricerca di sé e del mondo idealmente rappresentato in geometrie oniriche: ne è una prova eloquente, ad esempio, la lirica, “I fasti del silenzio”:
Ecco: il mondo ora è perfetto / rotondo, fulgido, maturo / frutto d’oro che io ho fatto mio / pomo che all’interno mi possiede, / svela generoso i suoi reami / i fasti del silenzio e dei misteri; / chiuso fra le braccia e le mie mani / il petto che sussulta di emozioni / sono io – mi riconosco?
Infine, in chiusa, la poesia prorompe poi un vitalismo danzante e classico di rinascita, nell’orologio dell’eterno ritorno del Tempo:
Gaia di pienezza è la mia vita: / per questo, sempre ne rinasco / e come fui domani sarò ieri.
Scrigno aforistico, ma affascinato dall’ancestrale numinoso della poesia, è davvero una prova di ingegneria del silenzio, allora, tutta la versificazione di Onofrio. Opera dopo opera, l’autore secerne modernamente domande radicali. Ma immette in questo cielo, macerie espressionistiche, bagliori d’indignazione e acri della palude dell’oggi. La terra esala miasmi che pongono graffianti domande all’ordine; e al cosmo, Onofrio lancia… quasar di versi. La poesia è anche quella “Radio amore” che racconta gioia e dolore dell’essere, nella musica atonale del tempo.
I “topoi” classici di cui Onofrio è imbevuto, si riequilibrano appunto con vertigini di stupore profondo, con la dolcezza misteriosa e sensuale dell’amore. Il richiamo all’eros tumultuoso, il pagano sacro riso dei sensi spumosi di vita e ardenti quanto più rapiti da una “brevis lux”, è un “kerigma” tipico dei classici, greci e latini. Nel nostro, che abilmente rovescia un noto verso di Sbarbaro, recupera all’inizio di “Antebe. Romanzo d’amore in versi” (la silloge è del 2007) il dionisiaco e il fremito totale della vita. Allora pare che il metafisico prenda voce e forma nella “religio” amorosa del desiderio.
Ah, miracolo di carne da godere! / Enigma di languido abbandono. / Dedalo fantastico di sensi. // Ho deciso e giuro veramente: / oggi voglio nascere alla vita, / respirando sui tuoi pomi color luna / l’odore che tu hai meraviglioso….
Il testo offre vari esempi di climax erotico di potente efficacia e così si dà sapore di natura all’atto amoroso:
Profuma il miele dentro la fessura / dove cuoci il pane della vita: / e il dolce companatico sei tu.
Da questa sensualità, che è ingegneria di vita e d’esistenza, nasce un universo d’emozioni. Una biologia del desiderio che si fa sempre conoscenza e meditazione, compone gran parte della produzione letteraria e poetica di Marco Onofrio, che ha raccolto in questa Antologia (“L’ingegnere del silenzio”, Pace Edizioni 2023, pp. 342, Euro 18) oltre vent’anni di scrittura in versi. La Prefazione di Plinio Perilli esprime bene la ricchezza e la complessità del dono poetico di un pensiero ricco di aforismi filosofici: ma nell’ombra della mente il poeta è radicato di desiderio.
Marco Onofrio, si configura quindi nel mondo poetico attuale, certo un contemporaneo e realista; nel solco però di una feconda, stellata luce della tradizione antica che, da modelli aulici, come Catullo e Lucrezio, arriva al paganesimo vitalistico di un d’Annunzio alcyonio, fino ad esiti di espressionismo linguistico pasoliniano, e aperto, oggi, a suggestioni massmediali. Poeta d’indignazione civile è Marco, nel suo poemetto “Emporium”, come pure in altre corrive ironie amare, come in “Disfunzioni” ed altri versi civili, feroci nel linguaggio vibrante di espressionismi gergali e immagini corrotte del mondo d’oggi. Un altro lacerto classico! Petronio il suo “Satyricon” e le rivisitazioni di Pasolini riaffiorano, in un codice linguistico a specchio dalla romanità neo-marginale del “coatto”, a scene di ragazze in minigonna e altre agnizioni del tempo romano in cui trova posto una vera cloaca d’umanità… Ma, per dirla appunto con l’autore, oltre la maceria c’è l’antidoto di un “azzurro esiguo”, torna la felicità pensosa del viaggio, il cielo degli affetti familiari, i versi struggenti e onirici sulla morte del padre… I momenti della nascita e della morte, si incontrano in questa galassia memoriale che apre versi di forte impatto e sentimento perché immersi nel cielo della vita.
L’opera di Onofrio quindi ha formalmente radici complesse con esiti pluristilistici. Un cosmo emozionale di parole accese a ricordi familiari, a lirismi di natura; ma si anima anche d’una terrestrità che si fa spesso occhio, mano. Il “logos” del cuore irrompe potente nella natura. Il corpo, l’eros si fa onda vagamente dannunziana, nella metafisica algida di stelle lontane… Marco Onofrio si sente poeta dell’anatomia del vuoto. E germina poesia, appunto, da quel silenzio siderale in cui cercare con le sirene del cielo, le stelle, nuovi dialoghi, ispirazioni esistenziali di una densa e radiosa luce lirica. Troviamo dunque in questa Antologia poderosa, un appello senza fine al cielo; sì, ma per leggere alfabeti di luce, serve il disincanto della storia, il rischio di un cammino nel linguaggio che muta. Nel silenzio e oltre, la poesia diviene allora l’autobiografia di una generazione. Ma nasce anche un’ingegneria ultrametafisica che si apre all’infinito delle stelle e lampeggia versi…
Vieni, cielo lampo dell’arcano
Trascendi dall’interno originale!
O nella bellissima sintesi poetica del nostro che è “A una cefeide”, e che riportiamo integralmente a conclusione della lettura dell’opera dell’autore romano, sempre in pensosa ricerca di rinascite di sé:
Cercavo quella luce dentro me / graffio di perla sul velluto nero / del suo fuoco – fontana / lontana di meraviglie / tra le polveri splendenti / dell’aurora – / due ore ho parlato a una cefeide / confidandole il mio sogno / e il mio segreto: / liberi / indomiti / impronunciabili. // Galleggiava ai bordi della notte: / cadde in pochi attimi / portando via con sé / sogno e segreto / dentro i precipizi / del silenzio. // Tornerà tra mille anni, forse:/ di me, allora, polvere neppure / ma lei, più fedele della morte / manterrà il segreto intatto / e porterà dal cielo / il sogno finalmente realizzato.
Paolo Carlucci
















