
“La memoria dell’ombra”, di Stefania Di Lino. Lettura critica
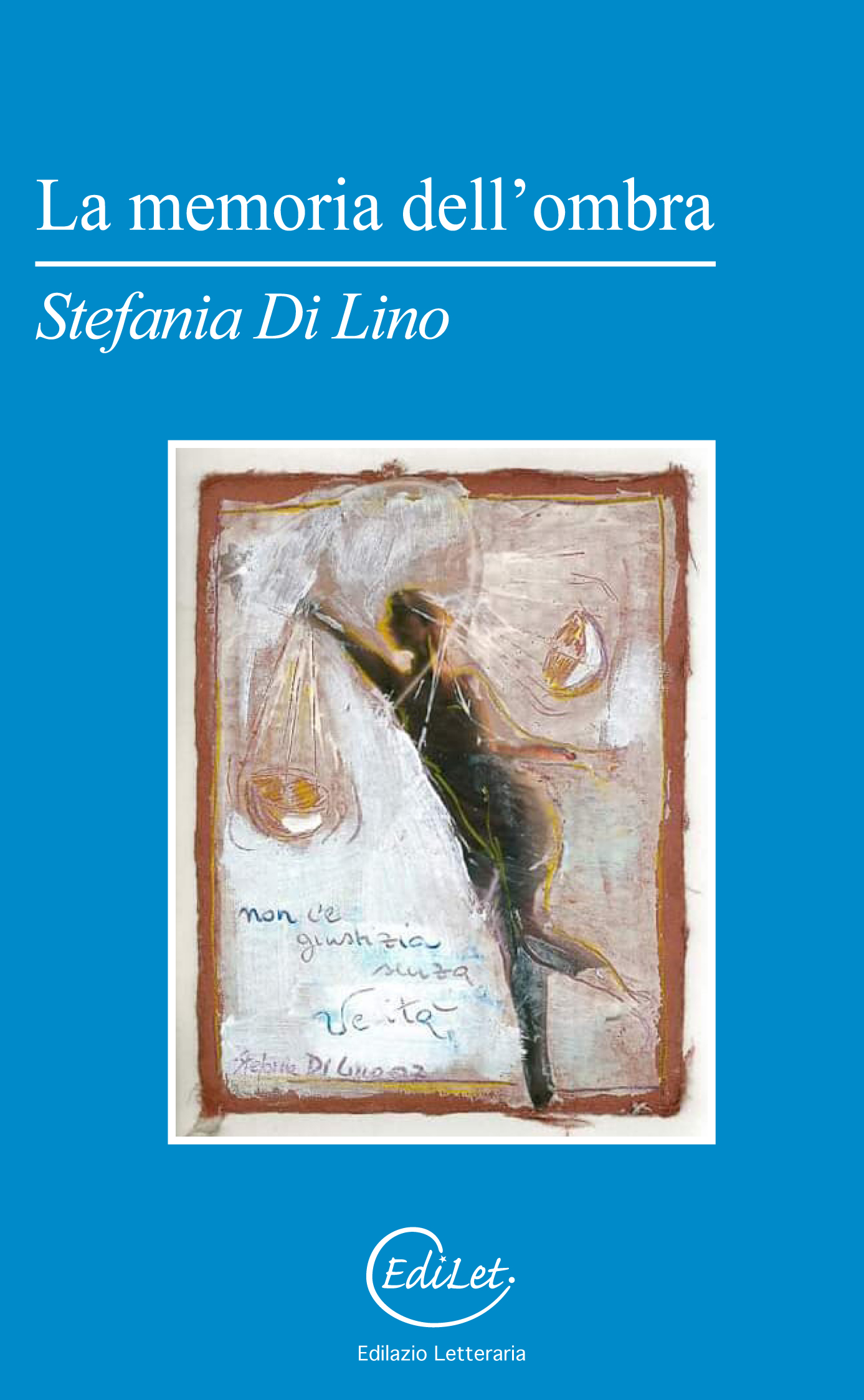
In questo suo quarto libro (La memoria dell’ombra. Poemetto, EdiLet, 2024, pp. 96, Euro 13), Stefania Di Lino accentua e acuisce la vocazione metapoetica che talvolta affiorava nei precedenti: focalizzare e definire la misura del proprio dire, diventandone l’oggetto e facendone a sua volta un possibile “correlativo soggettivo”. Il poeta può parlare di sé e del mondo anche mentre riflette sugli strumenti umani dell’espressione poetica. Una delle domande sottese in tutto il poemetto (tale è, di nome e di fatto, data la coesione che lega le singole composizioni) è infatti: che cos’è la poesia? Che cosa le è dato di poter essere e fare?
Non a caso la quarta di copertina riporta, dal testo, i seguenti versi: “la poesia nasce / dagli argini rotti della parola / è un dire cosa / che altrimenti non sapremmo”. E non sapremmo altrimenti perché solo in quel modo potremmo dirla. Pensiamo alla parola del vocabolario: essa opera un “travaso normativo” che riduce la complessità infinita delle cose. Contiene perciò il significato convenzionale, quello normale e consueto che utilizziamo per comunicare. La parola poetica nasce quando il contenitore della parola del vocabolario non basta più: è magma che cola dalle sue crepe, è luce che balugina dalla scorza del significato che si apre. Stefania Di Lino traguarda ulteriormente: ha bisogno della “parola segno”, della “parola gesto” capace di processare e performare la profondità. Infatti scrivendo cammina “sull’impervio confine liminale” (appunto limen, soglia che divide ma unisce al contempo) “tra la terra promessa e quella perduta”, vale a dire tra il non più e il non ancora; laggiù, sul bordo dell’ignoto fin troppo noto, esplora il “crinale scosceso di una lingua sconosciuta” che appunto nella poesia sa, deve, vuole dirsi.
Ecco dunque la poetica fondamentale di una scrittura che ha luogo “tra il dire e il non dire / e talvolta si mostra tacendo”, pronunciata magari “a fior di labbra”, per far conoscere cose “da sempre sapute”: ma saperle non vuol dire conoscerle, dato che l’abitudine ottunde la percezione fino ad annullarla. Qualche esempio? Il rumore continuo sfuma nel silenzio (chiunque abiti accanto ad una ferrovia, come noto, non fa più caso al passaggio dei treni). E il dolore cronico produce anestesia. E ancora: avere sempre qualcosa sotto gli occhi, lo rende invisibile, ecc. Il poeta è un sabotatore a servizio della verità. Svela gli inganni e de-automatizza gli sguardi, portandoli alla consapevolezza. Toglie polvere dagli occhi e solleva pietre dai giorni. Anche se poi resta sempre il muro della terra, la parete invalicabile dell’ultimo spessore divisorio. E “un peso / oltre la misura del cuore”, da cui non è possibile affrancarsi. La poesia è un’operazione di coscienza critica: procede attraverso l’“autopsia del cuore” nel tentativo di “trovare ragioni allo schianto”: da quello cosmico del Big Bang a quello che ci scoppia dentro ad ogni battito del cuore, e ogni volta che prendiamo contatto con la realtà dell’assurdo in cui siamo immersi. Certo, per sopravvivere occorre dimenticare la verità; ma appunto la poesia vuol farci vivere, non solo sopravvivere! Ho letto qualche giorno fa su Internet questo monito: “ti chiederanno di scegliere tra affondare o galleggiare. Tu scegli di volare!”
La poesia di Stefania Di Lino ha una vocazione civile che non appare vistosamente, dacché non la esibisce mai in “posa”; ciò le consente di restare immune dal difetto comiziale-tribunizio, tipico di molte scritture impegnate. È, semmai, autentica: nasce dal dissenso sincero, dalla ricerca eslege della verità. È un atto di disobbedienza incoercibile; non si può vietare di pensare, così come non si può bloccare l’avvento della primavera o il fiorire dei prati. Penso a Tommaso Campanella e ai 27 anni di ingiusta prigione che non gli impedirono di scrivere “La città del sole” senza disporre di carta, quindi a mente! Incidendo le parole del libro nella sua prodigiosa memoria. L’uomo è forte ed è in grado, se davvero vuole, di oltrepassare qualunque ostacolo. Stefania Di Lino parla di “libertà indomita”, cifra che approvo e in cui mi riconosco completamente. La scrittura è “spietata luce”, e deve esserlo per esercitare la sua pietas. C’è sovrapposizione simbolica di luce e lama, di ispezione conoscitiva e strumento per tagliare. Parla infatti di “bisturi affilato” e “fendente raggio laser” che purifica mentre esplora e avanza. Il poeta “incide” le cose, e la sua penna è una “punta di coltello”: anche per ferire e uccidere, se necessario. L’arte si “annida nella forma”, è segreto cuore dell’apparenza. Lo svelamento può essere esercitato come lettura in filigrana e controluce; ma anche e soprattutto come scavo: “pietre da cavare / parole dure da masticare / (…) e tutto l’indigesto da digerire”. La poesia è un digestivo, forse, ma è a sua volta indigestibile (cioè non digeribile, e insieme non gestibile). Elabora infatti gli “eoni dell’inquietudine” confrontandosi col Perturbante di certe immagini: da quella terribile ed emblematica di pag. 40 (“ho messo una testa di Medusa al posto del cuore”) alla preda “impigliata nella ragnatela” che “per poco ancora vibra”, alla ferita sempre aperta e sanguinante da cui “sgorga la parola”, all’“atroce tonfo” che chiude la rovina del corpo, ai giorni che come sangue “gocciolano graffiati”, ecc.
È un percorso accidentato e sconveniente, politicamente scorretto, che implica il coraggio di chi scrive e, di conseguenza, quello di chi legge. Non è un libro per struzzi, in attesa o in procinto di nascondere la testa nella sabbia. Stefania sfonda tutte le pareti per arrivare alle questioni fondamentali, e dunque alle domande ineludibili: ad esempio “cosa rimane di noi e dei giorni passati?”; “dove porteremo il nostro sangue?”; “in quale terra / e con quale umanità continuare?”; “dove comincerà l’incendio? / dove verrà acceso il primo fuoco?”, ecc. Ecco l’importanza dell’ombra e della sua memoria, l’identità metafisica e il doppio evanescente del nostro corpo, a ricordarci che siamo fumo di attimi in volo. Ecco perché “nell’andare” occorre “ricordare sempre la propria ombra”, l’ombra che ci riporta alla verità della nostra condizione, poiché richiama la presenza del corpo che fa schermo alla luce, ma anche la sua evanescenza.
La poesia si profila anche come terapia e cura contro “la ferocia del tempo e degli uomini”, sapendo che “quella che più duole” è “una morte non morte”, cioè la vita non vita che uccide la nostra autenticità e la nostra anima ogni giorno. Così il diavolo tortura le anime all’inferno: mantenendole in attesa, perennemente sospese nell’irrealtà. Così tirano avanti gli alienati, gli automi disumanizzati di cui l’atroce macchina della Storia ha bisogno – come di ingranaggi – per andare avanti. Il poeta attraversa l’inferno, il “buco nero chiamato dolore” per ricucire “con punti invisibili gli strappi” e le “mute lacerazioni”. È un Orfeo che cerca “il punto più alto / da cui la notte precipita”. Poesia, allora, “è fare del dolore musica”.
Stefania registra lo sconcerto dei nostri tempi, il “frantumarsi del credo” (ovvero l’impossibilità di credere a qualunque cosa, poiché tutto sembra diventato in-credibile): “tutto ora è aperto alla follia / è l’atroce delle cose esplose / sono i resti sparsi”. Siamo inetti, impotenti, disillusi, scoraggiati. Ci vede “ai posti di smarrimento”, anziché a quelli di combattimento. Al poeta non resta che scrivere sulle macerie stesse “la poesia dei ruderi”: “Scrivo come fossero tutti morti / o come fossi morta anche io”. Non solo le conseguenze, ma la loro analisi a ritroso, fino alle cause prime: non solo “la purulenza dell’odio / l’incuria mortale del disamore”, ma anche il “male nascosto nel seme che nessuno vede” perché è alla radice, e infatti aggiunge male al male, e “intacca contagia recide / lega e sporca”. Eppure Stefania Di Lino esercita la capacità eroica di “cavare energia dal niente”, di non rinunciare a “far nascere” e a “far venire alla luce”, a rispondere agli appelli del mondo, nonostante tutto, “se chiamati da una voce di madre” che sappia di origine e sorgente. Accenna talvolta a dimensioni nascoste e ancestrali, psicanalitiche del profondo, gnostiche e quasi escatologiche: una specie di “controtelaio” occulto della realtà, a cui tendono i sogni, che infatti “sono tasselli vividi / tessere lucide di un mosaico antico da ricomporre”. Parla di “spazio obliquo interstiziale” dove avvengono “minime le cose care” e le invisibili metamorfosi del tempo. È nell’ombra che dimora l’incanto, e in essa deve immergersi la mente per raggiungere i livelli della sua vita estatica. Ci sono composizioni in cui il soggetto si spersonalizza completamente, materializzandosi e vegetalizzandosi, abbracciando la frequenza inconscia della vita istintiva, il “neutro” dell’ES da cui, forse, sale il dolce richiamo delle maree, la tentazione di andare giù “fino all’origine del sangue”. Scrive allora di “tana verde”, “cuore di pietra antica”, “muschi e licheni”, “occhi di bestia” che “brillano / dello stesso luccichio della luna”. È il mondo senza di noi, al di fuori di noi, la dismisura oltre la nostra misura. La memoria stellare dialoga con la memoria animale e con la memoria cellulare: è anche questa, ritengo, la “memoria dell’ombra”.
Stefania Di Lino intesse un profondo elogio della diversità, scrive per “gli irregolari / i randagi i marginali” che incontra quando esce di notte, solitaria viandante, per vivere Roma oltre i fondali della città teatro. Lei stessa così si definisce: “ma io sono una che arriva / quando gli altri vanno via / appartengo alla genia dei fuori tema / degli inattuali”. Aleggia in tutto il libro un grande sogno di libertà, anzi di liberazione, che è spinto dal vento dell’esistenza e a sua volta si dispone a spingerlo, a soffiarlo dentro e intorno a noi per fomentarci al riscatto, alla vera evoluzione delle nostre vere energie. Tutto questo pur sapendo benissimo che la ricerca della verità è infinita e, per definizione, mai definitiva. Anche la ricerca poetica: “si cerca ancora / lungo esercizio / è la parola”. Ecco perché le poesie di Stefania dispongono i versi di seguito, in orizzontale, come una finta prosa, e soprattutto terminano sempre con la virgola, a indicare un movimento che non conclude ma rinasce sempre da se stesso. Come la vita.
Marco Onofrio
“L’uomo che parla ai libri. 110 domande a Dante Maffìa” letto da Valerio Mattei
La definizione di “introduzione al personaggio” o “all’opera di”, riferendosi a L’uomo che parla ai libri. 110 domande a Dante Maffia, a cura di Marco Onofrio (EdiLet, Roma, 2018, pp. 88, Euro 13,00), è talmente riduttiva e fuorviante che nella presente recensione non si proverà neanche ad usarla. Questo libro, miracolosamente agile, data l’enormità dei contenuti che veicola, è un prodigio di sintesi, introspezione, speranza e nostalgia, carne e spirito, eterno e quotidiano e tutta un’infinità di categorie opposte, ma tali solo alla povera percezione della nostra umile mente lineare. La stessa che non sente mai che la Terra gira a velocità inimmaginabili, che crede ancora al tempo tic-tac tic-tac, che crede ancora che le cosiddette “cose” realmente entrino in esistenza una dopo l’altra solo per il fatto che la nostra limitata percezione mentale e cosciente ci arriva sempre e solo lentissimamente, così come un moscerino, posandosi su un libro in un pigro pomeriggio d’estate, potrebbe leggerne le parole di una singola pagina. Bene, L’uomo che parla ai libri va aperto con cautela perché rappresenta un vero e proprio vortice che all’improvviso ti risucchia in un panorama multidimensionale impressionante in cui la tua povera mente lineare non capisce più, non “sente” più la demarcazione tra ciò che è (sempre secondo lei ovviamente), ciò che è stato, e ciò che sarà. In queste pagine l’immagine di disperazione per una mamma inchiodata alla sedia da una tragica malattia, quando Maffìa era ancora un bambino, convive con il magmatico pulsare di tensioni innegabili (e candidamente innegate) intrise di amore, sensualità, sessualità vissuta al massimo dell’autentico e del trascendente, come trampolino verso lo spirito, verso l’assoluto.
Il diario di un uomo, prima e oltre che di un artista, di una persona sì, ma non al modo dei latini, anzi del tutto priva di qualsiasi maschera. Un uomo che ha vissuto sempre con il cuore sulle labbra e la poesia tra le dita. Un essere umano sapientemente corteggiato, svestito e poi ancora amato dall’altrettanto sapiente e sottile sentire di Marco Onofrio, che va aprendo inesorabile, una dopo l’altra, le 110 stanze di “Palazzo Maffia”, dell’imponente edificio culturale, spirituale e profondamente umano rappresentato da questo straordinario uomo d’ingegno, con la delicatezza di una colf esperta che ormai conosce tutto della famiglia che la ospita, apparentemente al mero servizio di un Maestro contemporaneo (e naturalmente della propria opera, “a cura di”), ma che in realtà svolge un ruolo indispensabile alla perfetta riuscita del libro e della sua incredibile autenticità mozzafiato. Non davanti a tutti infatti, il grande poeta, scrittore, saggista e molto, molto altro, Dante Maffìa, avrebbe messo a nudo la propria anima, la propria vita, fino ai più remoti recessi della coscienza, con un senso di relax tale che sembra proprio di partecipare a uno dei tanti convivi che Lui ama tanto.
Si provi ad immaginare un artista insignito della Medaglia d’Oro alla Cultura direttamente dal Presidente della Repubblica, un autore candidato al Premio Nobel da tutto il Consiglio Regionale (all’unanimità!) della propria Terra di origine (la Calabria) e da molte Università, Fondazioni e Comitati, in Italia e all’estero, uno scrittore tradotto in oltre venti lingue in tutto il mondo e che può vantare un’infinità di altri titoli e riconoscimenti, per non tralasciare una lunga e onorata carriera di insegnante che da sola giustificherebbe più di una vita intera. Ecco, dopo aver immaginato questo, si pregusti la sorpresa, la gioia disarmante, il sorriso beato che si schiude sulle labbra del lettore quando inizia a notare che la conversazione vira vorticosamente su… cosce femminili e sensualità! Ma anche sull’impellenza della scintilla divina alla base di qualsiasi opera, che altrimenti è pura ginnastica di polsi. Sì! Dante Maffìa, come Marco Onofrio, è “uno vero”, come si dice in questi casi. Sono entrambi ambasciatori della Luce, della Verità, della Magia! Nel senso che mai priverebbero una propria opera dello slancio, del fragore e della fragranza che solo un’esistenza profondamente calzata, gustata, leccata fino in fondo al piatto della quotidianità, può sprigionare.
Senza anticipare troppo, si legga per esempio la domanda n. 104 e la dissacrante chiusura della relativa risposta! E si pensi, inoltre, che un creativo tanto riconosciuto e acclamato si propone ancora oggi (domanda n. 108) “di far sentire i brividi di un bacio alle persone che sono state dissestate dall’aridità della carriera, del danaro, del potere”. Quei brividi si avvertono già solo a leggere una frase del genere! In epoca di mobbing, di guerre, di pandemie, in una società suicida sull’altare infame dei numeri e del soldo, ecco finalmente ergersi coraggiosa una voce che ancora osa parlare di Amore in concreta sincerità. E ancora, con affascinante candore si apprende alla risposta della domanda n. 109 che il suo più grande sogno, pure in un percorso così indiscutibilmente brillante, è ancora oggi “che qualche mio verso, che qualche mia frase o pensiero, venissero pronunciati anche senza il mio nome, come patrimonio che è stato acquisito dall’umanità.”
Si chiude l’ultima pagina di questo libro con un senso di affezione, come se si fosse trascorso un lungo weekend al mare con entrambi gli artefici di un’opera così straordinaria. Quelle di Marco Onofrio non sono domande. Sono perle di una collana magica che fin dalla prima pagina, ivi inclusa la preziosa introduzione di Rino Caputo, si ha la sensazione di indossare per prendere parte a un rito, un viaggio dentro e attraverso la vita di un interprete sublime del Libro Totale che la vita stessa rappresenta. Interprete talmente sublime che la Sua vita assurge a simbolo e metafora della vita stessa di ogni uomo. Un sentito grazie a Dante Maffìa per averci ospitato al banchetto della propria anima e del suo Mondo, moglie, figlie e nipoti inclusi, di cui traccia un quadro a dir poco commovente. E naturalmente grazie a Marco Onofrio per aver dimostrato ancora una volta che colui che si offre al servizio di un’opera con coscienza pura e devota, incarna ciò che Sting (ricordo che Marco Onofrio è anche un fine critico musicale, oltre che scrittore, poeta, saggista, ecc.) scriveva nel capolavoro dei Police, la mistica “Wrapped Around Your Finger”:
Devil and the deep blue sea behind me
Vanish in the air you’ll never find me.
I will turn your face to alabaster,
Then you’ll find your servant is your master.
(Il diavolo e il mare blu profondo dietro di me
Svaniscono nell’aria non mi troverai mai.
Trasformerò il tuo viso in alabastro,
Allora scoprirai che il tuo servo è il tuo padrone).
Valerio Mattei
“L’ingegnere del silenzio”, letto da Paolo Carlucci
C’è, nel cuore poetico dell’opera di Marco Onofrio, un pensiero cosmico che si frange in costellazioni di domande e stupori lirici nottilucenti. L’autore, come un filosofo delle origini, un presocratico, indagatore della natura, sente l’imperativo di una ricerca di sé e del mondo idealmente rappresentato in geometrie oniriche: ne è una prova eloquente, ad esempio, la lirica, “I fasti del silenzio”:
Ecco: il mondo ora è perfetto / rotondo, fulgido, maturo / frutto d’oro che io ho fatto mio / pomo che all’interno mi possiede, / svela generoso i suoi reami / i fasti del silenzio e dei misteri; / chiuso fra le braccia e le mie mani / il petto che sussulta di emozioni / sono io – mi riconosco?
Infine, in chiusa, la poesia prorompe poi un vitalismo danzante e classico di rinascita, nell’orologio dell’eterno ritorno del Tempo:
Gaia di pienezza è la mia vita: / per questo, sempre ne rinasco / e come fui domani sarò ieri.
Scrigno aforistico, ma affascinato dall’ancestrale numinoso della poesia, è davvero una prova di ingegneria del silenzio, allora, tutta la versificazione di Onofrio. Opera dopo opera, l’autore secerne modernamente domande radicali. Ma immette in questo cielo, macerie espressionistiche, bagliori d’indignazione e acri della palude dell’oggi. La terra esala miasmi che pongono graffianti domande all’ordine; e al cosmo, Onofrio lancia… quasar di versi. La poesia è anche quella “Radio amore” che racconta gioia e dolore dell’essere, nella musica atonale del tempo.
I “topoi” classici di cui Onofrio è imbevuto, si riequilibrano appunto con vertigini di stupore profondo, con la dolcezza misteriosa e sensuale dell’amore. Il richiamo all’eros tumultuoso, il pagano sacro riso dei sensi spumosi di vita e ardenti quanto più rapiti da una “brevis lux”, è un “kerigma” tipico dei classici, greci e latini. Nel nostro, che abilmente rovescia un noto verso di Sbarbaro, recupera all’inizio di “Antebe. Romanzo d’amore in versi” (la silloge è del 2007) il dionisiaco e il fremito totale della vita. Allora pare che il metafisico prenda voce e forma nella “religio” amorosa del desiderio.
Ah, miracolo di carne da godere! / Enigma di languido abbandono. / Dedalo fantastico di sensi. // Ho deciso e giuro veramente: / oggi voglio nascere alla vita, / respirando sui tuoi pomi color luna / l’odore che tu hai meraviglioso….
Il testo offre vari esempi di climax erotico di potente efficacia e così si dà sapore di natura all’atto amoroso:
Profuma il miele dentro la fessura / dove cuoci il pane della vita: / e il dolce companatico sei tu.
Da questa sensualità, che è ingegneria di vita e d’esistenza, nasce un universo d’emozioni. Una biologia del desiderio che si fa sempre conoscenza e meditazione, compone gran parte della produzione letteraria e poetica di Marco Onofrio, che ha raccolto in questa Antologia (“L’ingegnere del silenzio”, Pace Edizioni 2023, pp. 342, Euro 18) oltre vent’anni di scrittura in versi. La Prefazione di Plinio Perilli esprime bene la ricchezza e la complessità del dono poetico di un pensiero ricco di aforismi filosofici: ma nell’ombra della mente il poeta è radicato di desiderio.
Marco Onofrio, si configura quindi nel mondo poetico attuale, certo un contemporaneo e realista; nel solco però di una feconda, stellata luce della tradizione antica che, da modelli aulici, come Catullo e Lucrezio, arriva al paganesimo vitalistico di un d’Annunzio alcyonio, fino ad esiti di espressionismo linguistico pasoliniano, e aperto, oggi, a suggestioni massmediali. Poeta d’indignazione civile è Marco, nel suo poemetto “Emporium”, come pure in altre corrive ironie amare, come in “Disfunzioni” ed altri versi civili, feroci nel linguaggio vibrante di espressionismi gergali e immagini corrotte del mondo d’oggi. Un altro lacerto classico! Petronio il suo “Satyricon” e le rivisitazioni di Pasolini riaffiorano, in un codice linguistico a specchio dalla romanità neo-marginale del “coatto”, a scene di ragazze in minigonna e altre agnizioni del tempo romano in cui trova posto una vera cloaca d’umanità… Ma, per dirla appunto con l’autore, oltre la maceria c’è l’antidoto di un “azzurro esiguo”, torna la felicità pensosa del viaggio, il cielo degli affetti familiari, i versi struggenti e onirici sulla morte del padre… I momenti della nascita e della morte, si incontrano in questa galassia memoriale che apre versi di forte impatto e sentimento perché immersi nel cielo della vita.
L’opera di Onofrio quindi ha formalmente radici complesse con esiti pluristilistici. Un cosmo emozionale di parole accese a ricordi familiari, a lirismi di natura; ma si anima anche d’una terrestrità che si fa spesso occhio, mano. Il “logos” del cuore irrompe potente nella natura. Il corpo, l’eros si fa onda vagamente dannunziana, nella metafisica algida di stelle lontane… Marco Onofrio si sente poeta dell’anatomia del vuoto. E germina poesia, appunto, da quel silenzio siderale in cui cercare con le sirene del cielo, le stelle, nuovi dialoghi, ispirazioni esistenziali di una densa e radiosa luce lirica. Troviamo dunque in questa Antologia poderosa, un appello senza fine al cielo; sì, ma per leggere alfabeti di luce, serve il disincanto della storia, il rischio di un cammino nel linguaggio che muta. Nel silenzio e oltre, la poesia diviene allora l’autobiografia di una generazione. Ma nasce anche un’ingegneria ultrametafisica che si apre all’infinito delle stelle e lampeggia versi…
Vieni, cielo lampo dell’arcano
Trascendi dall’interno originale!
O nella bellissima sintesi poetica del nostro che è “A una cefeide”, e che riportiamo integralmente a conclusione della lettura dell’opera dell’autore romano, sempre in pensosa ricerca di rinascite di sé:
Cercavo quella luce dentro me / graffio di perla sul velluto nero / del suo fuoco – fontana / lontana di meraviglie / tra le polveri splendenti / dell’aurora – / due ore ho parlato a una cefeide / confidandole il mio sogno / e il mio segreto: / liberi / indomiti / impronunciabili. // Galleggiava ai bordi della notte: / cadde in pochi attimi / portando via con sé / sogno e segreto / dentro i precipizi / del silenzio. // Tornerà tra mille anni, forse:/ di me, allora, polvere neppure / ma lei, più fedele della morte / manterrà il segreto intatto / e porterà dal cielo / il sogno finalmente realizzato.
Paolo Carlucci
“Beatle-Magia”, di Valerio Mattei. Lettura critica
“Beatle-Magia” (Jack Edizioni, 2023, pp. 196, Euro 14), il nuovo libro di Valerio Mattei, è parte di un progetto artistico che troverà la sua manifestazione a 360° veicolando in concerti ed eventi anche il libro precedente, da cui questo deriva, cioè “Lo sciamano” (2019), e altre scritture letterarie e musicali in corso o “in procinto di”. Tale dimensione di work in progress è verificabile anche nell’ottica creativa e aperta con cui “Beatle-Magia” è stato concepito da Valerio: sia per tentare nuovi sentieri interpretativi dei Beatles attraverso la sua sensibilità, sia per cercare egli stesso nuove strade artistiche attraverso la storia e, ancor meglio, l’essenza dei Beatles.
Qualcuno potrebbe obiettare: ancora un libro sui Beatles?! Che altro di nuovo si potrà mai dire? Ebbene, Valerio ci dimostra che di qualsiasi argomento, pure il più consumato, esiste sempre qualche sfaccettatura inedita; ma non è questo il punto. Non ci troviamo di fronte all’ennesimo libro sui Beatles, quanto piuttosto ad una “sinfonia” di esplorazioni sul mistero della creazione artistica che nei Fab Four ebbe modo di manifestarsi fulmineamente, segnando per sempre la cultura attraverso la loro “epifania” planetaria. Le chiavi di lettura sono storiche e sociologiche (cita tra gli altri Franco Ferrarotti ed Edgar Morin), ma soprattutto estetiche. Nella fattispecie, un’estetica a vocazione spiritualistica e messianica, escatologica e misteriosofica. Valerio sviluppa la sua ottica da una concezione provvidenziale della Storia: non l’immanenza di un divenire che trova in se stesso le proprie ragioni, ma la trascendenza di un Disegno che appunto nella Storia si attua e manifesta, per cui non esistono coincidenze e nulla di ciò che accade è per caso. L’affascinante ipotesi è che la partitura dell’esistenza si ricolleghi a una grande Matrice olografica universale che incide continuamente la realtà su “nastro” invisibile e la memorizza in archivio: il “Registro Akashico”, cioè il film del mondo. Non è dato sapere se la realtà è una tessitura che accade di attimo in attimo o una tela già tutta ricamata alla quale dobbiamo estendere il nostro sguardo, oltrepassando il singolo dettaglio.
Anyway, come si spiega l’incredibile avventura dei 4 ragazzi di Liverpool che hanno cambiato il mondo? La loro evoluzione entusiasmante, la loro rapidissima maturazione, la folgorazione creativa che ancora produce la sua fosforescenza ad ogni ascolto? Cos’è che li ha resi e li rende così speciali? Qual è il segreto dei Beatles, il loro carisma, la radice del loro magnetismo, il loro magico ingrediente segreto? Proviamo a sommare i fattori: a + b + c + d + X… E “X” è il quinto membro del gruppo, dove perciò c’è molto più che la somma di Paul, John, George e Ringo Starr. E non stiamo parlando del produttore George Martin… Riflette Valerio: “C’è qualcosa che continua a sfuggire”, qualcosa di intangibile e non riproducibile, altrimenti “quanti Beatles avremmo avuto negli ultimi 60 anni”?
Gli stessi Beatles non sapevano spiegare tutto quel successo:
In una conferenza stampa dei primi anni Sessanta, qualcuno chiese ai Beatles: «Cos’è che fa impazzire i vostri fans?» Paul McCartney rispose con un umile quanto onesto: «Non lo sappiamo». John Lennon invece, geniale e tagliente come sempre, fece esplodere una risata corale dicendo: «Se lo sapessimo formeremmo un altro gruppo e ne saremmo i manager!»
Ma, al di là della Beatle-Mania, da cui a un certo punto ebbero necessità di difendersi, lo sconcerto nasce dal salto evolutivo: da “Love me do” (1963) ad “Across the universe” (1969) c’è un abisso difficilmente spiegabile, oltretutto in così breve tempo! Furono rapiti da una nebulosa creativa che li portò a produrre tanto e a cogliere tesori musicali in rapida sequenza: nella breve ma titanica storia dei Beatles i mesi valgono come anni, tutto è rapidissimo e dà il capogiro.
Valerio chiama in causa la connessione con una Energia superiore che li avrebbe canalizzati: non è altrimenti possibile “conseguire in un arco temporale così ristretto una evoluzione artistica di tale portata (…). Sembra davvero che i Beatles siano stati infusi letteralmente di una qualche saggezza cosmica”. E ancora: “Non scrivi Yesterday, Imagine, Let it be, Strawberry Fields Forever, Lucy in the sky e altri capolavori perché hai deciso di sfondare nella musica”. Non basta il talento e neppure il genio… (fra l’altro i Beatles non sapevano leggere la musica, erano musicisti istintivi). Per spiegare quanto accaduto occorre la Grazia del trascendente, e questa arriva se è necessaria. Nel caso dei Beatles occorreva al mondo per sincronicità con il momento storico: ebbero semplicemente il “merito” e la “fortuna” di trovarsi al posto giusto nel momento giusto per rivelarsi come risposta planetaria alle istanze dei tempi: speranza, emancipazione, giustizia, pace, amore, libertà, felicità. La loro musica consuona con la rivoluzione giovanile, il Concilio Vaticano II, la Nuova Frontiera di Kennedy, lo spirito beat degli anni ‘60. L’intelligenza cosmica li scelse per incarnare tutto questo e affermarlo simultaneamente in tutto il pianeta. La luce che li accese è una sorta di Big Bang da cui scaturisce il rock e il pop che ascoltiamo ancora oggi. Due esempi: “Helter Skelter” all’origine dell’Heavy Metal, e “Tomorrow never knows” della musica elettronica.
Chiaramente Valerio non tralascia – per cenni rapidi e spigliati che presuppongono vaste conoscenze – la storia dei Beatles, anzi riesce a farcela sfilare davanti agli occhi come un videoclip: gli inizi difficili, tra Liverpool e Amburgo, poi l’esplosione del successo, l’Ed Sullivan Show, il Portale Magico che innesca il vortice planetario, la Comedy Song (per esempio Norwegian Wood o Eleanor Rigby), e infine il rifiuto dello show-businnes, la ribellione salvifica alla standardizzazione commerciale, al consumo distratto, alla cultura come oppiaceo. Succede così che nel 1965, soffocati dalla prigione dorata del successo, i Beatles obbediscano al richiamo dello Spirito che bussa alle loro porte: aprono appunto le “porte della percezione” e accolgono i doni della trascendenza, del sogno, delle visioni psichedeliche. Ecco la spiritualità, la meditazione, i testi metafisici, la coscienza cosmica, le culture orientali, l’utilizzo del sitar e il viaggio in India. I Beatles muoiono alle proprie “maschere” e così diventano davvero immortali. Ma restano fedeli alla propria natura, ora più che mai: si tratta di evoluzione organica, benché per certi versi inspiegabile su un piano umano. Il loro sound resta immediatamente riconoscibile anche in questa fase sperimentale. Bellezza e semplicità: melodie indimenticabili che nascondono diversi livelli d’ascolto e tentazioni sinfoniche, già ispirate a suo tempo da George Martin. I Beatles seppero ampiamente dimostrare la possibilità di conciliare qualità e popolarità, cultura alta e cultura di massa, spessore di contenuti e accessibilità di forme.
Il cuore di questo libro è, ripeto, l’ipotesi trascendente di creatività canalizzata: canzoni come gemme sfavillanti ricevute in sogno. Ecco come John Lennon descrive il processo creativo:
È come essere posseduti, come un medium. La cosa deve saltare fuori. Non ti lascerà dormire, così devi svegliarti, trasformarla in qualcosa, e a quel punto avrai il permesso di dormire.
Anche Bono degli U2 nel suo recente libro autobiografico “Surrender” descrive il momento sciamanico in cui sente che la canzone sta cantando lui, non viceversa. E così accade allo scrittore quando viene scritto dalla pagina che scrive. L’artista, nella visione alta di Valerio, è sciamano e sacerdote dell’assoluto, è colui che risveglia e rivela. Come lo shammàs del candelabro ebraico, il nono lume, posto più in alto degli altri 8 per accenderli. Questo è l’artista: un “servitore della Luce” che apre in noi una potente connessione con la scintilla divina e ci sintonizza sul fatto che siamo “esperienze naturali ispirate da Dio” (che tradotto in inglese forma non a caso l’acronimo della parola IMAGINE).
Il libro di Valerio “vuole essere principalmente un omaggio all’insondabilità della materia artistica” e del mistero creativo, per cui non solo i Beatles racchiudono in sé esperienze mitiche millenarie come quelle di Icaro (si sciolsero all’apice del successo), Proteo (erano in metamorfosi costante) e Prometeo (donavano un nuovo fuoco agli uomini), ma la stessa Beatle-Magia si configura come un principio creativo metastorico che opera negli abissi dell’Inconscio collettivo, manifestandosi attraverso i talenti più disparati, alcuni dei quali, evocati da Valerio, si affollano attorno alla potenza magnetica dei Beatles, come in un doppione ideale della copertina del loro album più iconico, il Sergeant Pepper.
Un libro molto ispirato e gestito benissimo, con grande lucidità e maestria comunicativa, che non solo è illuminante perché toglie un po’ di veli agli sguardi opachi di chi legge, ma si lascia fruire come un racconto piacevole, di ottima divulgazione e non comune profondità.
Marco Onofrio
“La rivolta del corpo”, di Lina Raus. Lettura critica

Lina Raus incarna il prototipo dell’operatore umanistico che, coniugando arte e scienza nella comune matrice psicanalitica, si fa scrittore per elaborare dal vissuto, proprio e altrui, la narrazione interna ed esterna della nostra epoca. I suoi romanzi ispezionano le connessioni che annodano o sciolgono la psicologia dei gruppi sociali in tessuto comunitario, articolando i campi di forze e i rapporti in macro-sintesi attraverso cui, successivamente, la cronaca si cristallizza in storia. È un discorso indirettamente civile: la penna affonda la sua lama nella crisi, perscrutandone l’anatomia, l’estensione, i confini, le ferite, le suture, le putrefazioni, le possibilità di cicatrizzazione.
La scrittura di Lina Raus non persegue finalità precipuamente estetiche – l’arte per l’arte esula dai suoi interessi – ma assolve a un compito gnoseologico e terapeutico, di chiarificazione interiore e benessere sociale. Storie tragiche di dolore, certo, ma anche di guarigione, di rinascita, di emancipazione. La psicoterapeuta e scrittrice originaria di Minturno ha sempre provato un “bisogno particolare di essere vicina ai più deboli, ai sofferenti, ai bisognosi”, forse perché lei per prima ha conosciuto la sofferenza “a causa della guerra, delle malattie, e soprattutto della spiccata sensibilità” che la portava a soffrire anche per cose che le altre bambine non avrebbero neppure notato. La scrittura è un modo efficace per proiettare il dolore fuori di sé, oggettivandolo in una sintesi conoscitiva e come spurgandolo nella bile nera dell’inchiostro. È uno strumento di “ecologia della mente” che mette in contatto e in equilibrio i due emisferi, consentendo a chi scrive e a chi legge di ricomporre le fratture tra soggetto e oggetto, mente e corpo, spirito e materia, io e altro, conscio e inconscio, silenzio e suono, presenza e assenza, menzogna e verità.
L’obiettivo è comprendere e riprogettare continuamente se stessi, attingere al profondo, attivare le potenzialità latenti – contattare insomma il mistero del proprio essere, vivo benché sepolto dalle alienanti sovrastrutture del mondo contemporaneo e quasi consunto dalle ipnotiche strettoie percettive imposte, sin dall’infanzia, per mezzo delle nuove tecnologie di massa. La luce erompe attraverso le crepe delle zone d’ombra dove si annida maggiore l’inquietudine. Ora la “trilogia” inaugurata nel 2012, come l’ho definita in un mio saggio monografico, diventa tetralogia con il romanzo La rivolta del corpo (EdiLet 2021, pp. 148, Euro 14), pubblicato in piena crisi pandemica. Una nuova sintesi logomitica di sentimento e ragione, eloquenza e cura dell’anima, libertà creatrice e disciplina di autocontrollo, grazie a cui Lina Raus continua a convocare e convogliare temi e sentimenti universali – quanto mai validi e attuali, nella loro eternità – come il disagio psichico, la nevrosi, l’identità di genere, il pregiudizio sessuale, la famiglia, l’amore, l’amicizia, l’abbandono, il lutto, l’angoscia, la solitudine, ecc. La narrativa si fa carico delle risposte antropologiche fondamentali agli eventi e ai traumi dell’esistenza, e manifesta la dicibilità delle cose come se l’unità umanistica dei saperi non fosse stata ancora frantumata dall’età moderna e postmoderna, incarnando il “bisogno di una scienza della religione e dell’arte, di una religione dell’arte e della scienza, di un’arte della scienza e della religione”, cioè di una circolazione fluida e osmotica tra le pulsioni conoscitive basilari dell’uomo tout court.
“Chi sono io, e come sono?” si chiede la protagonista de La rivolta del corpo, Sara Effe, e vi risuona (come non percepirlo?) lo “γνῶθι σεαυτόν” dell’Apollo delfico. Ecco la scrittura come strumento di conoscenza ed auto-terapia di “un dolore che gli altri, sconosciuti che lo leggeranno, ti aiuteranno a scaricare portando via ciascuno la sua piccola parte di angoscia”. Sara Effe è il tipico personaggio di Lina Raus: una vittima del “disagio della civiltà” concretizzatosi, per lei come per molti, in una famiglia retrograda e repressiva che ne ha segnato l’infanzia e, quindi, il proseguo dell’esistenza. Depressione bipolare, nevrosi, coazione a contare oggetti e situazioni, insoddisfazione, ricerca infinita, atavica mancanza di fiducia, incapacità di chiedere, paura di dare fastidio, solitudine, sensazione di “non essere mai capita”, di sentirsi sempre “sbagliata” e di avere o essere sempre qualcosa di mancante, ecc. l’hanno indotta a un percorso psicanalitico. Ma il romanzo comincia nel modo più atroce: Sara Effe ha scoperto di avere un cancro al rene e deve operarsi. La sua corazza difensiva rivela improvvisamente l’intrinseca vulnerabilità: “Sembro forte perché ho una volontà di ferro? È vero, sembro una kamikaze, ma faccio conto solo sulle mie forze: non ho mai potuto o saputo contare su nessun altro. Faccio fatica ad ammetterlo ancora oggi, ma è lì la prova della mia solitudine in continua ricerca: corro, sempre corro, per inseguire qualcosa di molto importante che mi sfugge. Mi sento come una farfalla che gira intorno ad una lampada accesa, allucinata dalla incandescenza della luce, senza sapere che quella potrebbe essere causa della sua morte”.
Lina Raus ci fa vivere l’angoscia della notte prima dell’intervento, la paura della morte, il salto nel buio. Poi l’anestesia, l’operazione, il risveglio. Sara Effe intrappolata fra tubi e tubicini di flebo, ma soprattutto in un labirinto psicotico dato dal terribile anagramma di “cosa”, “caos” e “caso” tra cui si sente sballottata come un guscio di noce in mezzo a una tempesta. La “cosa” è il male, l’intruso da estirpare con devastante violazione del corpo, e ovviamente anche della psiche. La malattia ha però qualcosa di prezioso: rende straordinaria la cosiddetta “normalità”, fa cioè in modo che venga percepita straordinaria, come in realtà è, malgrado l’abitudine ci impedisca di viverla nella sua vera natura. Il responso dell’esame istologico è confortante: per Sara Effe rappresenta una rinascita, un “nuovo inizio”. Sa da sempre che le piace l’inizio delle cose, e allora giura a se stessa che il grande scoglio superato non potrà mancare di imporle un’esistenza programmata su basi nuove. Avere un’affettività sana e imparare finalmente a vivere, cioè a difendere la gioia, a godere senza rimorsi o rimpianti le tante cose belle che ci sono.
Una delle domande implicite che emerge dal libro è: siamo un corpo o semplicemente lo abbiamo? L’esperienza spirituale ci rivela di continuo che siamo anime incarnate, cioè intrappolate in una forma carnale che ci consente di esperire la materia, ma d’altro canto non risponde a pensieri e desideri così alti come quelli che ci abitano nel profondo. Ecco la sofferenza di una vita! Da qui il bisogno potente e originario di spezzare le catene invisibili: combattere la paura, i pregiudizi, le ipocrisie, riscattando la sofferenza nella libertà. Tutto il romanzo raccoglie questo grande slancio della coscienza per la conoscenza, e viceversa, verso l’ignota pace interiore, altrimenti definibile armonia. “Ma l’armonia non può essere intorno a noi, se prima non è dentro di noi”, leggiamo a un certo punto della storia. Ecco il lavoro su se stessi, l’autoanalisi, la ricerca delle cause prime: le ragioni intime della sofferenza. “Tutto mi riporta sempre alla mia infanzia”, riflette Sara Effe. Ha subìto una educazione rigida e piena di tabù. “I miei erano la causa del mio male… Spesso non mi sentivo trattata come una persona ma come una cosa… Non ricordo carezze, abbracci, sorrisi, considerazione”, ma solo nervosismo, urla e scatti di rabbia. Un clima inquisitorio di sospetto e di peccato che non le ha consentito un rapporto equilibrato e positivo con la natura delle opere e dei giorni. Era la “figlia della colpa” solo perché concepita prima del matrimonio! Si immagini già da questo il livello di arretratezza mentale e culturale che ha scolpito la purezza del suo diamante originario…
La repressione infantile e adolescenziale le ha procurato un “caratteraccio” indomabile e ribelle, intriso di rabbia pur nella tristezza e nella solitudine. Ma la repressione produce ribellione e desiderio di trasgressione: “è legge di natura che dove c’è l’oppressione nasce l’opposizione”. La psicanalisi prima e la malattia poi le hanno consentito di sentirsi paralizzata nelle contraddizioni: un passo avanti e due indietro, preda di forze ambivalenti. “Sono sempre stata in contraddizione: la parte di me che voleva uscire per manifestarsi rimaneva poi bloccata nell’ombra”. Ecco la paura di alzare la testa e tenere la schiena dritta per affrontare di petto i problemi, e la fretta nel vivere le situazioni favorevoli, come in apnea: l’incapacità di prendersi il tempo necessario per godere del bello e del buono, le volte rare e preziose in cui sono disponibili. E ancora: le resistenze, gli escamotages, i nascondigli infiniti per impedire di conoscersi veramente. Meglio non alzare la pietra, meglio non scoprire i vermi brulicanti che nasconde!
Ma ecco la crisi come opportunità. Sara Effe capisce grazie alla malattia che “non ne può più di controllarsi”, schiacciata dal peso del Superio che le hanno imposto i suoi fin da quando era bambina per negarle il “principio di piacere” con proibizioni e punizioni di ogni tipo. E capisce anche le cause della malattia stessa come somatizzazione del malessere psicologico, cioè come rivolta del corpo trascurato e mai amato abbastanza. “Il corpo sopporta tutto, ma non per sempre. Il corpo, a un certo punto, si ribella; sembra che voglia vendicare tutto ciò che la mente ha sofferto senza cedere”. Ecco la malattia! Sara Effe ha vissuto per decenni la “sindrome della spugna”, assorbendo ingiustizie e sofferenze da cui non è riuscita a depurarsi: non a caso il cancro le è venuto a un rene! La scienza ha ampiamente dimostrato la connessione tra ambiente psicofisico e risposta immunitaria delle cellule: segnalo a tal proposito, fra gli altri, un bel libro di Bruce Lipton, “La Biologia delle Credenze”. Pensiero e stato d’animo influenzano il DNA e la salute delle cellule: depressione, insoddisfazione permanente o un grande dolore (come accadde al povero Enzo Tortora, dopo l’abominio giudiziario) possono portarle ad impazzire, innescando malattie gravi come il tumore. Il vero nutrimento della nostra vita – come afferma Massimo Recalcati in un colophon apposto dall’autrice alla Seconda Parte del romanzo – è il “desiderio”: nutre più del cibo! Senza l’entusiasmo del desiderio, cioè “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, tutto è destinato a cadere, a chiudersi, a incenerirsi.
Grazie al cancro sconfitto, Sara Effe evolve a un livello superiore di coscienza. Impara a non farsi più condizionare dalle voci interiorizzate della famiglia d’origine. Impara ad amarsi, finalmente, per lasciarsi finalmente amare. Impara a “osare vivere” e “osare nascere” ogni giorno. Impara a smettere di sopportare e resistere senza tregua, rinunciando al fine della irraggiungibile perfezione per accettare infine il mezzo della nostra condizione umana così com’è, “imperfetta e provvisoria”. La malattia ha fatto nuove tutte le cose: il “tempo regalato”, cioè strappato alle unghie della morte, impone d’ora in poi il sano godimento d’ogni singolo istante, con la “sua gioia per rimettere in equilibrio il corpo con la mente”. Il libro si offre dunque come “testimonianza di dolore” dall’effetto catartico e liberatorio: veicolo di guarigione e invito al riscatto dal disagio che la vita e il mondo ci infliggono, per fare del bene a noi stessi e, di conseguenza, alle persone che abbiamo intorno e che non di rado contribuiscono a farci stare male. Un libro piacevole da leggere, con le sue gioconde e ironiche digressioni, e anche utile da riflettere per capire che noi non siamo la nostra eventuale malattia, ma tutto ciò che essa indica con urgenza, invitandoci a salvaguardia del bene, della vita, in una parola: dell’amore. Appunto questo ci urla da dentro la malattia: che la morte è l’opposto dell’amore, e che dunque per vivere è indispensabile amare, il più possibile e il prima possibile, perché già domani potrebbe non bastare o essere troppo tardi.
Marco Onofrio
“Con altra voce”, di Sabino Caronia. Lettura critica

La silloge “Con altra voce” (Edizioni Nemapress, 2019), di Sabino Caronia, raccoglie 30 poesie che paiono scritte con la bocca amara, le labbra deformate nella smorfia di un gusto aspro che tenta di nascondersi sotto il velo brillante dell’ironia ma che in altri momenti, al colmo del malincuore, può lasciarsi andare apertamente nel sarcasmo. L’opera si dipana tra “diario di assenze”, giocate tra non più e non ancora, e “naufragio di amori” mai consumati, soltanto sognati, finiti sul nascere o al primo apparire della loro potenzialità. Dalla “ferita del possibile” qui si passa alla “ferita nell’esistere”, giacché l’esistere stesso è e produce una ferita che langue in silenzio e «tutt’a un tratto» può risanguinare. Caronia guarda da spettatore passivo al destino che muove da dentro l’evoluzione delle cose, governandone e determinandone gli incontri, gli scontri, le separazioni, fino alla chimerica «forma segreta» della loro essenza. Ad esempio il vento che «corre all’appuntamento con le foglie», o le nubi che passano in cielo «messaggere di lutto», oppure la cometa che fugge «chissà dove / da chissà quale terribile dove / e silenziosa nella notte» va «sempre obbediente ai calcoli del cuore». La voce “altra” della poesia scaturisce dalle crepe sul muro compatto dei sogni, fratturato dalle esperienze, dalle delusioni, dai dolori. Da cui, conseguente, la constatazione del nulla in cui siamo immersi e a cui siamo destinati, a dispetto del nostro inutile sforzo, e quindi anche l’incomunicabilità, «la coscienza d’essere vivi in un mondo di morti» e, talvolta, la vergogna «d’essere un uomo».
Cosa resta di noi, di queste nostre
vite senza memoria, cosa resta
di questa solitudine infinita?
Soli, come Franz Kafka, dentro un treno
che corre per deserti alti di neve.
La vita è come un viaggio in un mattino
freddo, nebbioso, triste, senza luce
che ci conforti e ci riscaldi il cuore.
Infatti il cuore è freddo, ed è freddo perché troppo ha compreso, facendo di persone, cose e situazioni «specchio di me vivo e profondo» fino alla vertigine dell’inesistente. L’intelligenza (intus legere) è in certi casi una condanna, si vorrebbe avere meno consapevolezza – o almeno un senso meno vivo e straziante – di ciò che accade dentro e intorno a dove siamo.
Questo è morire, sai: guardare dentro.
L’esistenza è il dolore sconsolato di capire che «dietro quella finestra c’è la notte» e che siamo tanto fragili: «Domani il vento ci porterà via». A questo freddo, che in ultima ipotesi può anche essere eterno («quando i vermi un freddo pasto / faranno alfine del mio corpo»), Caronia oppone il potere consolatorio offerto – soprattutto nella prospettiva malinconica del post factum – da lacerti episodici di vita, attimi irripetibili, rare luminose epifanie, attraverso la mediazione salvifica della Donna: le sue mani sulle mani innamorate, il «calore delle dolci labbra» che scalda ancora le sue, gli occhi grandi «dove amore fa nido», gli «occhi di cielo» dove ritrova la «fuggiasca fecondità», i pensieri dove vorrebbe vivere, la «promessa di futuro / che ritorna da un tempo ormai lontano / e il cuore scalda e l’anima innamora», ecc. L’amore che nutre i frutti della vita e la poesia che li raccoglie possono opporre un argine di salvezza al baratro eterno in cui tutto prima o dopo è destinato a dissolversi. Lo scrittore è come colui che «accende fiori di solarità» posandoli in offerta votiva «sul nero del dolore», e Caronia ricorda il girasole che Plinio Perilli portò in dono al funerale del caro Elio Fiore. Si tratta insomma di poesie pervase da un disperato bisogno di felicità, in attesa di un appuntamento «dove non c’è miseria né dolore» (come quello sospirato da Don Fabrizio Salina quasi alla fine del Gattopardo, “un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria regione di perenne certezza”), qualcosa che dunque ci liberi dal gioco trito e tristo dei giorni in cui siamo impelagati. L’opzione di un’altra voce (che è, infine, la poesia stessa) apre universi alternativi, scenari che si affacciano su dimensioni diverse da quelle ordinarie, per limpidezza, lucidità ed intensità percettive, benché ad esse parallele e in qualche modo adese, forse concentriche. Un esempio di questa realtà poeticamente rinnovata e “salva” è nella bella composizione “Sotto diverso cielo”:
SOTTO DIVERSO CIELO
Il vivissimo fuoco
dei tuoi verdi occhi chiari
come lama sottile
mi ha frugato nel cuore,
sotto diversa luce,
sotto diverso cielo,
su prati di smeraldo,
dentro una pioggia d’oro.
Il mondo visto con gli occhi di un trapassato, che finalmente ha visto svelata “sotto diversa luce” la verità del mistero, implica la salvezza ultima della fede religiosa, del credere in ciò che non si è visto e del sapere con tutta l’anima che «Cristo è Cristo», ossia che fedele e saldo come Lui al mondo non c’è e non ci sarà mai nessun altro. Cristo infatti è «infinita speranza che non muore» ed è Lui lo scoglio sicuro che può offrirci l’«appiglio» dove resistere al naufragio ininterrotto delle cose. La ricerca del divino che è in noi non deve languire nell’abitudine dei fatti scontati, ma essere pungolata dalla sete viva dell’assoluto, ed è ciò che si afferma nella prima composizione – quasi un segnavia, una stella cometa deposta a splendere proprio all’incipit del cammino – che peraltro ritengo la migliore, anzi la più memorabile delle trenta:
COME L’ACQUA
Poiché l’acqua è insegnata dalla sete
non ci resta che prendere la sete,
per maestra, per guida d’assoluto,
nei cammini dell’anima inquieta.
Marco Onofrio
“Tesori inestimabili”. Poesia inedita

TESORI INESTIMABILI
Lo scopo senza nome
della vita:
incessante rinascita
dalle ceneri,
tra le sue macerie.
Tesori inestimabili
nel tempo
emergono, dalla marea
del mondo.
Oltre la soglia di questa
tenebra infinita,
l’alba non è poi
così lontana.
Marco Onofrio
«L’incanto e la paura». La parola, l’immagine e la Vita, tra “strazio” sublime e dolce “struggimento”. Conversazione con Chiara Mutti

Oggi faremo insieme un viaggio nel mondo creativo di Chiara Mutti. Cercando di “sentire” e “comprendere” i luoghi “fin dove giungono le parole”, ma anche oltre, e quindi ciò che considero il cuore della sua poetica, ovvero il rapporto problematico tra la realtà delle parole e la realtà delle cose, ma anche tra le rispettive e reciproche irrealtà. Da un lato il Logos riduzionistico, l’esperienza dicibile con gli strumenti umani della ragione; dall’altro il Mythos senza confini, l’altrove perturbante dell’indicibile. Ebbene, il pensiero annoda i suoi ricami nella zona franca tra il silenzio delle cose, ricco di tutte le parole che vorremmo, e il suono delle parole, povero di tutto il silenzio che non parla. Per questo la poesia è, per dirla con Robert Frost, il “suono del senso”, che afferra, racchiude e produce il senso non convenzionale delle cose, la loro realtà ultima e prima, la radice originaria della loro forma apparente.
Ma andiamo con ordine, muovendo i passi dal più recente alloro che la poesia di Chiara Mutti ha ricevuto, poco più di un anno fa…
– Dunque, Chiara, hai vinto la prima edizione del Premio Nazionale “Moby Dick”, Sezione Poesia: che ricordi hai della premiazione avvenuta nella Sala Consiliare di Palazzo Colonna a Marino (RM) il 26 settembre 2022? Che cosa distingue questo premio, secondo te, dagli altri a cui hai partecipato o che hai vinto?
– È stata un’esperienza felice! Vincere un premio è senz’altro sempre gratificante, ma questo premio ha una marcia in più… non solo per la perfetta organizzazione, ma anche per l’accoglienza e l’attenzione che mi è stata riservata. Insomma, posso dirlo: mi sono sentita coccolata e in perfetta armonia con l’ambiente per corrispondenze elettive. Sono cose che, almeno a me, accadono raramente.

– Che cos’è che ti spinge a scrivere? Che cosa ti proponi pubblicando le tue pagine?
– Credo che sia stato il mio modo spontaneo di esprimermi sin dall’infanzia, non essendo particolarmente portata ad esprimermi con le parole. Volendo fare la psicologa di me stessa, aggiungerei che è un disperato tentativo di fissare il tempo, di contenere lo straziante e continuo dissolvimento di tutte le cose. Mentre scrivo non penso ad altro che a scrivere; soltanto dopo, una volta concluso un determinato percorso, ho bisogno di metterci un punto, di chiudere un cerchio. Pubblicare significa chiudere quel cerchio, fino a un nuovo inizio.
– Puoi azzardare una “definizione” della Poesia?
– Alla Poesia sono state attribuite, nel corso del tempo, innumerevoli definizioni, e giustamente, perché infinite sono le sfumature di senso che implica e i concetti con cui la si può identificare ma, proprio per questo, sempre parziali. Per me la Poesia è e resta, in realtà, indefinibile. Penso sia un modo di vedere, anzi che sia essa stessa Sguardo: un modo particolare di percepire la vita e le cose del mondo.
– La Poesia è per te più “serbatoio del meraviglioso” o “incubatrice d’ombre”?
– Per me è senz’altro “serbatoio del meraviglioso”, le ombre sono dentro me… sono io la mia “incubatrice d’ombre”. Il miracolo è tradurle in qualcosa di luminoso e la poesia è lo strumento che mi permette di farlo.
– Perché, a costo di perdere lettori, non hai paura di sollevare la pietra delle ipocrisie e di affrontare il dolore viso a viso?
– Perché non conosco altro modo di scrivere! Se non lo facessi non solo non sarei fedele a me stessa ma non sarei fedele nemmeno alla Poesia.
– Che sentimenti provi quando scrivi? Più gioia o più sofferenza? È per te un gesto catartico, di autoconoscenza e liberazione?
– Quando scrivo provo più sofferenza che gioia, anche perché la parola è uno strumento limitato che non basta mai comunicare tutto quel che vorremmo esprimere e contro cui ci si scontra continuamente. Peraltro è uno splendido strumento di autoconoscenza e posso dire quindi che è tutte queste cose insieme. Ma non si scrive per liberarsi; non ci si libera mai completamente. Solo dopo, quando si è concluso un percorso e si pubblica, allora sì, allora se hai avuto coraggio e sei davvero disceso negli ‘inferi’, allora può avere un effetto catartico.
Il percorso di Chiara comincia, dopo alcune composizioni giovanili inedite, che probabilmente riprenderà tra qualche tempo, con il primo libro pubblicato: “La fanciulla muta”, del 2012, che segna la sua sofferente conquista della voce. La fanciulla muta è lei stessa da bambina, chiusa nel mutismo come unica maniera per rispondere all’enormità dei fatti spiacevoli che la vita la costringeva prematuramente ad accettare, ma è anche la neve, la coltre del silenzio puro che porta la realtà a scarnificarsi fino all’essenza, al cuore metafisico dell’esperienza e della sua memoria.

LA FANCIULLA MUTA
Hanno chinato la cima
i cipressi
ad annusare l’odore dei prati
un odore bianco
un nonnulla
un marmoreo affiorare
di gigli
e il silenzio
è un richiamo del cielo
un sorriso stupito
un fantasma
la fanciulla muta.
CANCELLI
Osservo dalle dune
un filo d’erba
agitarsi lieve
alla salsedine
lontano
una vela va
oltre il mio dito alluce
serena
tra gli ombrelloni e il mare
biancoverde biancoverdeblu
sfocato
nel tremulo calore della sabbia
l’alta marea tace
dei rumori dell’anima
spezzati
sull’orlo della spiaggia.
NIN-TU
Sorella MadreTerra
infausta nelle mie mani
lasciasti il dono
dissipato
alfine come topi in massa
nell’innato istinto
correremo giù dalla tua rupe
ciechi come falene
rese cieche dalla luce
folli come scimmie
rese folli dalla prigionia
gravidi come cagne
sciuperemo il seme
prosciugheremo il mare
e il miracolo dei pesci
non si ripeterà
la spiga brucerà l’asfalto
landa di nessuno.
Solo ci sarà dato
il respiro degli eroi
che seppero cantarti
benevola e terribile
vulcano d’Islanda
lapilli e cenere
l’incanto e la paura
l’inesplicabile bellezza
tanto che ingrata torno
a consegnarti un intimo vagito
IL DOLORE DELLA SOLITUDINE
È il dolore della solitudine
uno stesso dolore per tutti
un dolore a tonfo sordo
che scuote il cuore
rosso e azzurro di vene
gonfio che trattiene
si accartoccia e stride
come un freno a mano
tirato
nell’universo del ricordo.

A SILVIA
Madre
che abbandonai
alle tortuose vie della follia
troppo presto, per non serbarne colpa
non fosti mai
mamma, sorella, amica
ma forse figlia.
Mi irrigidii
serbando nei ricordi i tuoi fantasmi
lontana, eppur commossa
dalla tua vita
solitaria e stolta.
D’amor non fosti amata
spietato il senso della sorte
e mi sorprendo, ora
a ricordarti nel tuo affetto infante.
Io, adulta
non seppi mai dirti che t’amo
neanche l’ultima volta che ti vidi
terribile, eppur bella
nella rigidità eterea della morte
E VOLTO PAGINA
E volto pagina
sono colei che volge
lo sguardo indietro
ma non torna
ed i vestiti smessi
non mi stanno
pure
vi riconosco
il peso del mio corpo
e lì dove ho sostato a lungo
l’anima si è consumata nella fibra
e lì dove ho mangiato
il cuore si è nutrito nella macchia
e lì dove ho ceduto
lo strappo si è allargato nel dolore.
Il respiro poetico di Chiara si accorda col respiro cosmico dell’essere. La sua voce domina con grande naturalezza il solfeggio delle pause, cioè il rapporto metasemantico che regola l’avvicendarsi di parola e silenzio. Con questo libro impara appunto a scolpire il silenzio in un movimento di scavo e ricapitolazione dell’esperienza. Anche come studio archeologico del sé: la faticosa costruzione della persona, le ere geologiche e geometriche assimilate nella propria crescita.
– Parlaci della tua passione per l’archeologia. Che rapporto hai con il passato? Fra l’altro uno dei tuoi libri di poesia ha un titolo bellissimo, “Archeologie del cielo”…
– Grazie! Ho sempre avuto un forte legame con le radici, che siano intese come origine personale o in senso antropologico, cioè estese a tutto il genere umano. Ho sempre provato un senso di stupore e di meraviglia nel venire a contatto con i manufatti antichi, con i resti archeologici, e in parte anche un senso di gratitudine; forse la mancanza del senso di appartenenza a una famiglia mi ha portato ad aver bisogno di sostituirlo con un senso di appartenenza più esteso.

Il secondo libro, “Scatola nera”, giunge quattro anni dopo la “Fanciulla” a, come dire? sporcare di realtà gli esiti sublimati di quell’esordio. È lo spleen pumbleo dell’esperienza con il suo ingombro, è il “muro della terra” di dantesca e caproniana memoria. Di che cosa è metafora “Scatola nera”? della memoria automatica di bordo, come quella degli aerei? dell’inconscio? dell’anima profonda e immemoriale? dello spessore opaco del mistero? Le risposte ovviamente restano sospese.
COSTELLAZIONI
I
Eravamo sulle labbra della luna
un soffio di polvere bianca,
squame argentee di salmoni
risaliti alla corrente.
Il coro d’inermi fanciulli
emise qualche nota stonata,
un’uggia di rauchi conati.
Duro il sangue pulsò
corrompendo ogni desiderio:
tracciavamo i punti alla cometa
una domanda, una domanda, una domanda
nascevamo sopraggiungendo al giorno
tutto il resto sembrava sera
e la notte era già il tempo del dopo.
II
Dall’emisfero boreale
il vento soffiava gelido di ghiaccio,
pavidi e tremanti
riparammo sotto l’apparenza
seguendo traiettorie
perpendicolari: al nulla
immobile, piombando il sonno
suggeriva sistemi in divenire,
non sapevamo che il nostro
era solo un vagare in tondo?
Un suono di sirena fissa
accanto all’ultima luce.
Il futuro è rimasto irrivelato
come un pianeta dissolto.
III
Prima che piede
ci spingesse al passo
milioni di zampette confuse
segnarono orme di galassia,
solo ali di libellula astrale
ci liberarono dall’orda
distinguendoci l’un l’altro,
vennero a portarci
una nuova forma di confine.
Il margine era acqua
e non era finito, oltre la sostanza,
che potesse quietare
l’ansia del crescere.
Pure il ventre, così vuoto e scarno,
sembrava ora estendersi al pleroma.
Mani d’ossa tintinnanti
musicarono il vuoto.
IV
Perché mai questa scia
di detriti alla deriva?
Questo nulla che ci attrae
più dell’atomo scomposto?
Cambierò la tua fede
in un carro,
un pavone, un cavallo,
una capra bianca.
Puoi frenare il volo del cigno?
Incalzare la risposta del corvo?
Domani, domani.
Forse la materia è madre
strappata agli abissi:
per questo siamo nati.
Forse non siamo che forma.
V
Oh! come tutto muove
e muta, e segue:
solo noi sembriamo
eternamente in atto di finire.
Sempre con occhi vani
ci appressiamo alla vista
pure un giorno dura,
ogni sole, un giorno
e una notte, una notte
basta
per tutte le stelle.
LA LUNA ASSENTE
Sembrava, il brusio, salisse dai fondali
dall’argano, geniali intricati
artifici umani
o forse proveniva da un dio irredento
condannato per la sua vile assenza.
Di ora in ora avanzava sugli spalti
più su, sulle mura
le grida roche
spossate alla calura, alla fame, all’attesa.
La notte, inesorabile, è giunta.
Il pollice verso, la luna assente.
Non adirarti con me!
L’uomo che siede al di là della luce
ha intonato un canto
i fiumi scorrono sotto.
IL LUME
Era forse la tua voce
quel lontano lamento?
O era il vento?
La mano non raggiunse
il mento
che tremava.
Oh lacrima!
rimasta impigliata alla falce.
Tu non hai che parole d’ossa
– i miseri resti –
non gridi, non corri,
non sai
quale mistero ti ha visto.
Chi ti ha riconosciuto?
Chi ha divelto la porta?
Oh! restituitele gli occhi
ridatele il sonno:
la palla è caduta lontano.
Solo un velo di terra
è rimasto
tra la ciotola e il lume.
“Scatola nera” è il suo libro più psicanalitico, rappresenta la catabasi necessaria al raggiungimento della luce, la discesa agli inferi della memoria per fare i conti con se stessa e la verità della propria storia nel mondo. È un’opera molto densa e coesa, che aspira alla dimensione unitaria del poema sinfonico disteso sul “basso continuo” di una musicalità poco cantabile che definirei “dark”, in cui si innestano slanci verticali da cui vengono episodicamente illuminate le atmosfere, come feritoie di una galleria. A proposito di musica…
– Che rapporto hai, in genere, con le altre espressioni artistiche? Di che cosa nutri la tua immaginazione?
– Amo tutte le espressioni artistiche: pittura, scultura, architettura, musica… ma anche grafica e naturalmente fotografia. Posso dire di avere un trasporto particolare con la pittura, avendo avuto modo di respirare quest’arte già in famiglia: mia madre Silvia, il prozio Adolfo Mutti (pittore affermato, in particolare a Brescia e in Lombardia) e il bisnonno Giacomo Mutti erano pittori. Mi piacerebbe approfondire meglio cinema e teatro, ma tutto non si può fare, soprattutto lavorando, però, d’altra parte, proprio il mio lavoro mi dà la possibilità di vivere a stretto contatto con l’arte e oggi posso dire che non potrei più farne a meno. L’arte nutre costantemente la mia anima prima ancora della mia immaginazione.

– Sappiamo che sei anche una bravissima fotografa. Hai anche esposto in mostre fotografiche. Che rapporto c’è, secondo te, fra scrittura e immagine fotografica?
– Diciamo che mi diletto e ho un buon occhio fotografico, ma non sono una professionista. Questo però, e in parte è voluto, mi consente di sperimentare e di spaziare verso soggetti diversi in piena libertà. Poesia e fotografia sono due forme espressive molto diverse e apparentemente contrastanti, ma hanno entrambe un potere evocativo fortissimo e, in questo senso, diventano due vasi comunicanti. Il rapporto tra fotografia e poesia, infatti, per me è molto stretto e posso dire che amo creare immagini con le parole così come fare poesia con le immagini. Può sembrare un’utopia, ma rappresenta una grande sfida e come tutte le sfide mi affascina.




Infatti alcune splendide fotografie entrano in dialogo con le composizioni poetiche del suo terzo libro, “Archeologie del cielo”. C’è un rapporto paritario tra le due forme espressive, per cui le poesie finiscono per essere come fotografie senza immagine, e le fotografie come poesie senza parole. È un libro di trascendenza immanente, di sublimazione concreta, di assalto carnale del mistero. Infatti assomma gli esiti dei due libri precedenti: la poesia è un lievito che ri-anima le cose del loro brivido ancestrale, ricongiungendo lo spirito alle radici del sacro e risvegliando l’atteggiamento di adorazione degli antenati. E questo le consente di esplorare labirinti enigmatici di incanto e paura, ai bordi dell’indicibile complessità.

*
Io vivo. Ma se fossi sogno?
L’allegoria sarebbe il giorno
e la luce tempo.
I colori brillerebbero di una tale infamia
che la notte sarebbe
l’unico porto sicuro.
Il porto in cui la quiete
ha sepolto il giorno.
Ma i ricordi, i ricordi
le fluttuazioni
chi spegnerebbe loro il lume fioco?
Anche il cielo,
il più nero di stelle,
ha le sue prigioni.
*
Noi siamo la continuazione
di quanto è stato prima
e ci sarà domani.
Apparenza e realtà
in una sola dimensione.
Ed è cosa piccola, così piccola
così impossibile da contenere!
Un raggio di luce che danza
qui, ora lì, oltre,
fin dove la penombra può arretrare.
Forse eravamo qui da sempre.
Lo siamo già nei ricordi del Golgota
e nelle valli scoscese,
lo siamo nelle case di pietra,
nelle finestre
diventate azzurre.
Anche loro riflettono cielo,
come noi
che di cielo abbiamo avuto le mani
e quanto abbiamo toccato
è diventato pianta, acqua, animale, dio
Universo
potremmo già essere santi
o dannati per sempre:
chi può decidere il destino?
Guardami, è l’alba,
io sono stata in questa luce
e sono ancora
il principio del mondo.
*
Illuminata dal basso
si ergeva, alta, la rupe.
Era il silenzio immobile
sacro come la croce
su cui muoiono gli uomini
e Dio.
– Un rosso sangue
languente nel cielo –
Più in basso scorreva la vita
infinitamente più in basso
nel fiume scorreva
l’ora precipitava
nel buio profondo
pur continuando a errare.
*
Il cielo ha molti segreti
ma alla vista
si aprono chiare le nuvole.
Nei petali hanno raccolti di nettare
e producono un suono strano:
a volte scoppi di risa
oppure un borbottare
fitto fitto.
Ascolto e aspetto
la replica dei rami
che le foglie persistano o cadano
o se ne vadano
con lo stesso struggente rumore
della mano che si allontana.
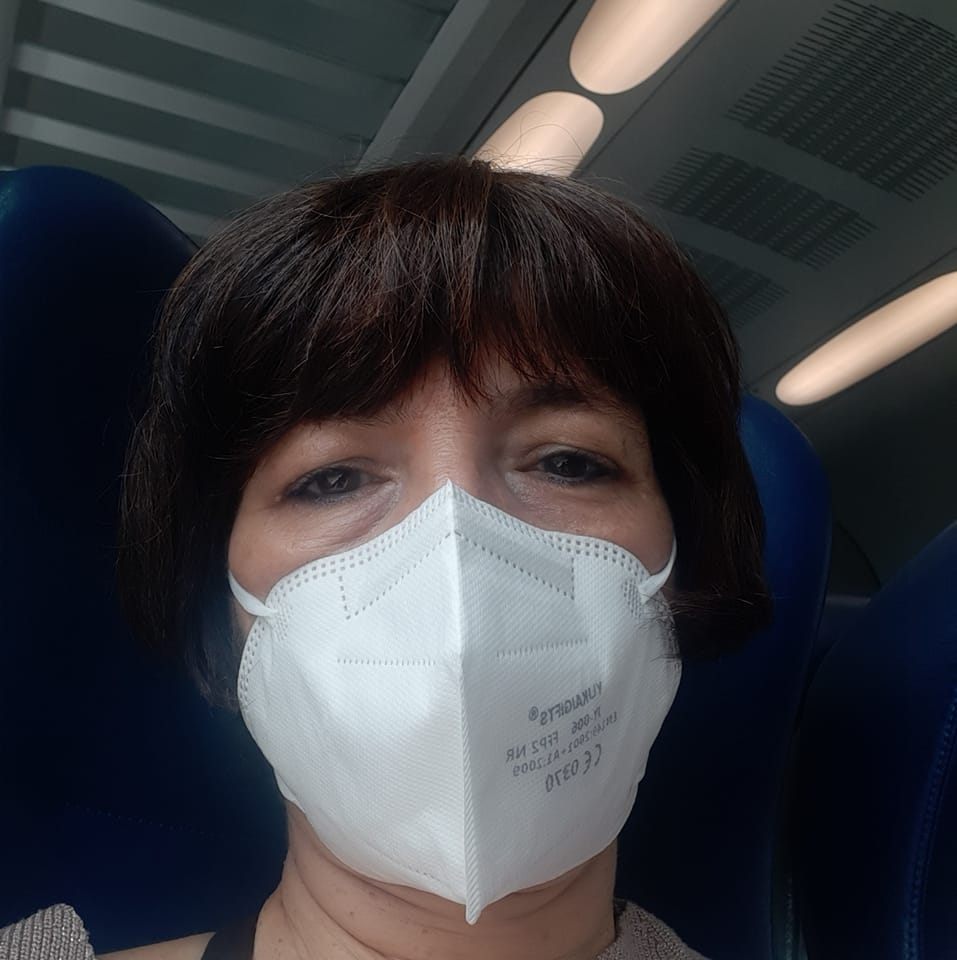
E arriviamo così al quarto libro, le prose liriche di “Amen” in cui Chiara immagina che Giulia, la protagonista autobiografica delle vicende narrate, faccia i conti con una infanzia traumatica e dolorosa, segnata dalla malattia psichiatrica della madre e dalle conseguenti fughe familiari del padre. Ho avuto il piacere di scrivere la Prefazione del libro, in cui fra l’altro dichiaro che «Amen è lo stadio finale di una conquista: significa scendere a patti col passato, con l’annosa e mai del tutto superata “paura di vivere”. Significa imparare a perdonare, abbracciare, amare, benedire e lasciare andare. Significa guardare nello spavento del buio con una fiducia e una forza tali da vederci una luce che brilla». “Amen” è notevole anche perché, grazie all’intensità dello sguardo e dello stile, riesce a intessere la consonanza di due dimensioni estetiche generalmente difficili da accordare, se non inconciliabili: l’umano e il sublime.
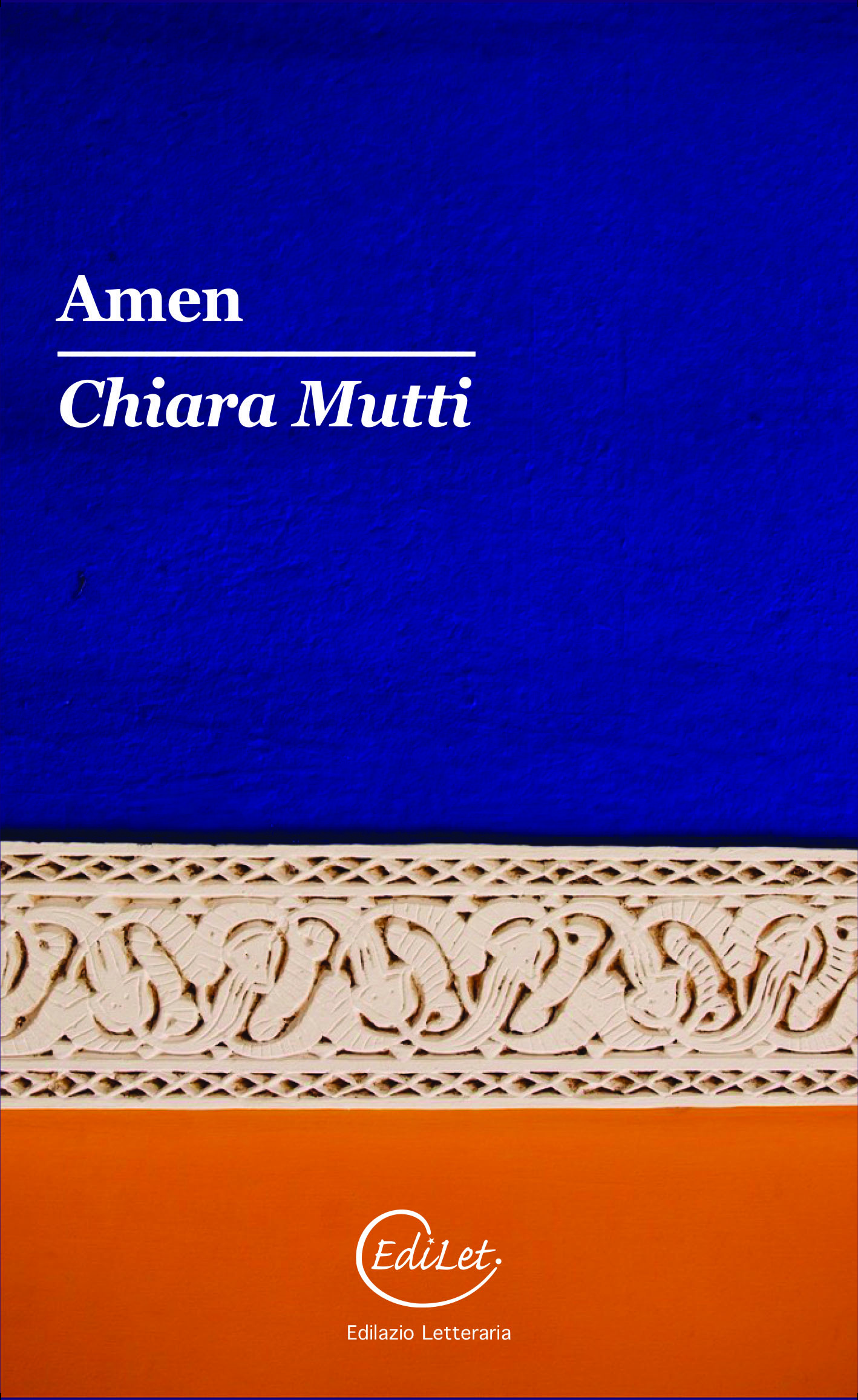
*
Quando suo padre morì, vent’anni dopo, si era già imposta di precludersi alla sua vista, alle sue mani, alla sua voce per il resto della sua vita. Si rifiutò di andare al suo funerale ma gli concesse una corona di fiori. Era consolatorio, pensava, che quella corona fosse lì in sua assenza, era consolatorio e vendicativo. Ma così facendo lo tratteneva con sé. Le ci vollero altri dieci anni per risolversi a lasciarlo andare: “Ora sediamoci qui, uno di fronte all’altro, come non siamo mai stati in grado di fare. Potremmo scegliere il muretto del noce, ricordi?”
“Attorno al noce” diceva suo padre, “metti le pietre una sull’altra” e lei le faceva combaciare scegliendole una per una, che combaciassero perfettamente. Una per una, perché rivelassero la loro parte migliore. Anche lei, come quelle pietre, avrebbe voluto mostrare la sua parte migliore! Aveva sempre la capacità di stimolare il suo orgoglio: era bravo a elargire consigli, a dare la direzione, a sollecitare, a indurre, a manipolare il suo bisogno di piacergli. Aveva nella sua bella voce, bassa, con una elegante francesissima pronuncia della erre moscia, qualcosa che l’attraeva, che la convinceva, come se rivelasse una particolare sapienza; una padronanza del mondo, pensava, capace di svelarne i misteri.
“Anch’io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura”…“ma chi ascolta me vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male.”
Giulia immaginò di sedersi proprio attorno a quel noce, sul muretto di sassi che aveva tanto amorevolmente costruito, e finalmente aprì gli argini dando libero sfogo al fiume delle sue parole:
“Ora sono io che faccio i conti con te, sono qui a fare i conti perché non avanzi niente, a rinfacciarti i dolcetti di marzapane e l’amore sprecato per la tua persona, i tuoi monologhi ascoltati come fossero oro colato, e tutte le volte che li hai smentiti con la tua condotta, gli sforzi per aderirti e la sensazione di non valere mai abbastanza, il rifiuto e il senso di colpa per il rifiuto, la delusione e la rabbia e la rabbia e la rabbia.
Sono qui per dimenticare la paura del buio, per perdonare l’abbandono, per vincere il senso di colpa, per onorare la furia della rivolta, per abbracciare me stessa.
Sono qui a dirti che ho smesso di essere te e il contrario di te, e qualsiasi persona tu abbia voluto che fossi.
Sotto l’albero mi sono seduta, ho liberato dal laccio il mio piede, posso vedere l’istante prima e tutti gli istanti dopo quel primo istante, anche se posso comprendere solo una parte del tutto.
Ora che sono libera sono ancora una volta sola, ma posso essere cielo, vento, terra, albero e sono acqua che scorre.”
Non è dato sapere come abbia reagito il padre di Giulia a queste parole, né se si sia mai posto domande, in vita, a questo proposito, né se le sia poste dopo la morte. Non sappiamo d’altronde se esista vita dopo la morte, o meglio in che modo e in che forma la nostra energia si riunisca al cosmo.
Sappiamo solo che un padre non è altro che un uomo, pertanto fallibile. Non è il superuomo che avremmo desiderato che fosse! E allora prendiamo la nostra vita e lasciamo che scorra: nessuna diga, per quanto robusta, potrà rallentarne il corso, e quella diga che abbiamo tanto attentamente costruito, con gli errori degli altri, non è altro che la nostra paura di vivere.
A quell’uomo che Giulia ha tanto amato e odiato io oggi dico: “Va’! Riposa in pace.”
Amen

– Uno dei temi principali ravvisabili in “Amen” è quello del perdono. Come lo intendi? Come lo hai affrontato nel corso del libro?
– Non parlerei propriamente di perdono, non nell’accezione cristiana del termine. Si tratta di accogliere e accettare la realtà dei fatti per quelli che sono e di superare il proprio rancore. Diciamo che è qualcosa che, prima di tutto, concediamo a noi stessi per crescere ed essere liberi, e così raggiungere uno stato di pace e consapevolezza. La chiamerei più poeticamente un’epifania.
– Sostanzialmente sei conosciuta come poetessa. Com’è stato passare dai versi alla prosa? C’è un rapporto possibile tra la Poesia e la Narrativa?
– Senz’altro nasco poetessa e, a mio avviso, continuo ad esserlo. Nel senso che si tratta comunque di prosa poetica. Il romanzo segue altre vie, ha delle regole ben precise e nasce da altri presupposti ed io temo di essere troppo indisciplinata per seguire delle regole, finisco per seguire il mio impulso creativo, che è sostanzialmente di natura poetica. Per contro la prosa dà sicuramente maggiore libertà formale e questo mi ha permesso di esprimermi maggiormente.
– Sei stata già tradotta in Romania e hai in preparazione un libro di poesie in Francia, in edizione bilingue. Qual è il titolo? Che emozione provi nell’essere tradotta?
– Sì, il libro è ancora in fase di lavorazione ma dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno con il titolo Murmures (Sussurri). Essere tradotti in un’altra lingua dà una grande emozione: significa portare i propri versi in un’altra dimensione, varcare i propri confini, non solo geografici ma anche umani. Provo una grande riconoscenza per chi si adopera nell’arte della traduzione, per la difficoltà che comporta e per la grande cura, l’attenzione che offre ai nostri versi. Il francese è una lingua che amo anche per le sue sonorità.
Ora vorrei tentare di portarmi alle radici dello sguardo poetico di Chiara: “strazio” e “struggimento”, secondo me, rappresentano le parole-chiave. È la temperie autunnale dell’anima, il cammino della caducità che segna d’ombre-luci il trascolorare inesorabile della decadenza. Percepisce così la fine ininterrotta delle cose, attimo dopo attimo, ma questo non le impedisce di adorare la realtà, anzi l’aiuta ad estrarne il sacro e ad abbracciarne la bellezza attraverso un manto di malinconia, di dolce tristezza che rende sostenibile e quasi caro il dolore che prova.
– Quanto influiscono le tue origini lombarde nel tuo modo di guardare e sentire le cose? Per esempio nel tuo modo di descrivere il paesaggio… E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– Influiscono molto, non solo nel mio modo di descrivere il paesaggio: contribuiscono a creare un mio personale paesaggio interiore e influiscono, anche se parzialmente, nel mio modo di intendere la vita, pur non avendo mai vissuto stabilmente in quei luoghi. Forse le nostre origini sono inscritte nel nostro DNA e in qualche modo costituiscono un nostro patrimonio etico, oltre che genetico. Ho molto caro quel senso di lontananza che provocano i grandi spazi della pianura padana, i cieli rosa nell’aria gelida e limpida dell’inverno che fanno da sfondo ai filari di pioppi, le imperscrutabili nebbie e la bruma gelida che risale i canali, il senso di dolce, struggente malinconia e le tante suggestioni che ne derivano.
– E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– C’è tanto anche di romano e di laziale, Roma è la città dove sono nata e dove lavoro, dove quindi vivo gran parte della giornata. È una signora zozza e un po’ cafona che non smette mai di sorprenderti, di commuoverti con la sua sconvolgente bellezza e di sfiancarti con i suoi perenni contrasti. Ad ogni angolo trovi qualcosa che non avevi ancora visto o che, pur avendolo visto, ti sorprende ancora e ancora. E la luce che si riflette sui muri rossi e giallo ocra dei vicoli di Roma… una luce diafana trasparente… E i rumori, i suoni più prossimi che, in certe strade, ti giungono come da infinite lontananze, echi di rumori. A Tivoli vivo, o per meglio dire dormo, ormai da molti anni. È una cittadina bellissima, ricca di vestigia e di ville patrimonio Unesco. Senz’altro diversi miei componimenti sono ispirati ai suoi panorami ed alle atmosfere che li animano. Mi piacerebbe però che i tiburtini imparassero ad amare di più la propria città, a rispettare e far rispettare il bene comune. In questi ultimi anni ho visto dei progressi per quel che riguarda il turismo, ma ci sarebbe ancora da fare molto! Poi ho vissuto in altri luoghi, e infine ci sono le città d’elezione, le città simbolo, le città sogno. Un poeta ha un forte legame immaginifico con le proprie città, le mie sono tante ma non mi sento legata a nessuna in particolare, pur amando Roma sopra ogni altra.

– Che cosa bolle in pentola? Quale sarà il tuo prossimo libro?
– Non faccio quasi mai programmi, vivo la letteratura e la poesia per ispirazione e per quel che viene giorno per giorno, leggo molto, scrivo poco, o comunque con delle lunghe pause tra una pubblicazione e l’altra. Se volessi però dare una risposta un po’ più concreta, e svelare un mio vecchio sogno nel cassetto: mi piacerebbe realizzare un libro di fotografie. Poi l’idea di rimettere mano alle mie poesie giovanili, già da qualche tempo mi ‘frulla in testa’, chissà che prima o poi non la realizzi.
– Lavori al Ministero della Cultura. Non voglio metterti in imbarazzo, ma secondo te dove sta andando la cultura italiana?
– Ehm… c’è una domanda di riserva?! Sarò sincera, non mi sento molto positiva al riguardo: immagino stia andando lì dove sta andando l’Italia. Ma forse in questo momento, dopo l’ennesima riforma del Ministero, sono un po’ contrariata. La missione principale, a mio avviso, resta sostanzialmente la tutela e la conservazione del bene e questo, checché se ne dica, comporta essenzialmente costi, oltre che grandissimo impegno e competenza. Potremmo diventarne ricchi? È un’attività che non dà ricavi: è un servizio atto a preservare il bene e a impedirne la distruzione. Poi sì, c’è la valorizzazione e la promozione, che, a mio avviso, dovrebbero garantirne la conoscenza e l’accesso da parte di tutti i cittadini. Ma anche questo aspetto non può diventare un business, perché altrimenti vorrebbe dire rendere la cultura un privilegio per pochi. Quello che ho trovato, invece, positivo nell’evoluzione del concetto di bene culturale in questi ultimi anni è stato il modo di ripensare lo spazio culturale, renderlo interattivo, cioè coinvolgere il cittadino nelle attività culturali… ché poi renderlo partecipe significa anche renderlo corresponsabile del bene stesso, quindi contribuire alla sua tutela, e così il cerchio si chiude.
(a cura di Marco Onofrio)

Chiara Mutti, autrice di origini lombarde (bresciane e mantovane, per l’esattezza), è nata a Roma, vive da 30 anni a Tivoli e lavora al Ministero della Cultura in qualità di funzionario per le tecnologie. È appassionata di archeologia, antropologia e fotografia. Ha pubblicato tre raccolte poetiche – “La fanciulla muta” (Lepisma Edizioni, 2013), “Scatola nera” (Fusibilia Edizioni, 2016), “Archeologie del cielo” (Terra d’ulivi Edizioni, 2019) – con le quali ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Con “Amen” (EdiLet, 2023) ha pubblicato il suo primo libro di narrativa.
16 dicembre 2023: su Paconline.it il report di Maurizio Aversa sulla splendida serata al Bibliopop, con Vittorio Nocenzi, Marco Onofrio e Chiara Mutti
Marino. A Bibliopop: è Banco! E’ Nocenzi! E’ Premio Letterario! E’ Onofrio! E’ Mutti! Insomma è proprio la grande storia di “Moby Dick”
Sabato 16 dicembre Bibliopop ha toccato uno dei vertici della sua bellissima storia con una serata davvero memorabile. L’evento, ideato e organizzato dallo scrittore Marco Onofrio come 1° appuntamento con i vincitori del Premio Nazionale “Moby Dick”, si è concluso con il racconto in musica della celebre canzone “Moby Dick”, ispiratrice del Premio, dalla viva voce del presidente onorario dello stesso, il M° Vittorio Nocenzi, accompagnato dal chitarrista Filippo Marcheggiani. Dunque il Banco del Mutuo Soccorso, storica band della musica italiana e internazionale, si è esibito al Bibliopop, sia pure in sintesi rappresentativa ma con il suo padre musicale!
Andiamo con ordine. La serata viveva un preludio gradevolissimo con Nocenzi “mattatore”, il quale dopo alcuni dei suoi arpeggi mirabili per provare la tastiera – tra cui accenni alla canzone di cui sopra – intratteneva il pubblico in entrata con uno dei suoi leggendari monologhi culturali a ruota libera in cui, da autentico Maestro d’Arte a 360°, si dimostra ogni volta in grado di parlare dell’universo-mondo, affascinando l’uditorio. All’entrata in scena del Presidente di ACAB/Bibliopop, Sergio Santinelli, per il canonico saluto introduttivo, Nocenzi si diceva onorato di donare alla biblioteca due volumi sulla storia del Banco, consegnandoli pubblicamente: “Sguardi dall’estremo Occidente”, con CD musicale, e “Siamo nati liberi”. Santinelli ringraziava, a nome di tutti, dopodiché procedeva con il suo breve intervento per poi lasciare spazio a Marco Onofrio, il quale prima illustrava il senso ideale del Premio, da lui ideato e giunto con successo nazionale alla sua terza edizione, e poi – ringraziato anche l’altro presidente, Roberto Pallocca, titolare della Sezione Narrativa – chiamava la vincitrice assoluta della Sezione Poesia del “Moby Dick” 2022, Chiara Mutti, con cui intavolava una piacevole conversazione culturale.
Era il momento del “focus” sull’itinerario artistico dell’autrice di Tivoli, nata a Roma ma originaria della Lombardia, attraverso i suoi libri, le sue traduzioni all’estero, le sue fotografie (alcune delle quali proiettate e commentale sul fondo absidale del Bibliopop). L’approfondimento, condotto brillantemente da Onofrio tra notazioni critiche e domande ad ampio raggio, trovava i suoi esiti naturali nelle letture dei testi, performate dai due ottimi dicitori, Gianni Pittiglio e Roberta De Angelis, che anche grazie al fascino indubbio delle loro voci consentivano a tutti i presenti di percepire la grandezza e la profondità dei versi (in particolare la splendida poesia “Costellazioni”), molto apprezzati e lodati pubblicamente dallo stesso Nocenzi. Onofrio ha peraltro suggellato le sue immersioni nell’universo poetico di Chiara Mutti con la seguente definizione globale della sua poetica: «Voglio portarmi alle radici dello sguardo poetico di Chiara: “strazio” e “struggimento” sono le parole-chiave. È la temperie autunnale dell’anima, il cammino che segna d’ombre-luci il trascolorare inesorabile della decadenza. Percepisce così la fine ininterrotta delle cose, attimo dopo attimo, ma questo non le impedisce di adorare la realtà, anzi l’aiuta ad estrarne il sacro e ad abbracciarne la bellezza attraverso un manto di malinconia, di dolce tristezza che rende sostenibile e quasi caro il dolore che prova». Il “focus” si è concluso con la consegna di un regalo a sorpresa per l’autrice, da parte del Premio “Moby Dick” e di tutto l’entourage di ACAB/Bibliopop: il CD del recente album del Banco, ispirato all’immortale capolavoro di Ludovico Ariosto, “Orlando. Le forme dell’amore”, che Nocenzi e Marcheggiani avevano preventivamente impreziosito con dedica e autografi. Era il ponte perfetto per la terza parte della serata, il “clou” in musica.
Vittorio Nocenzi raccontava da par suo la genesi e la costruzione della canzone “Moby Dick” (1983), dai primissimi accordi al confronto creativo con Francesco Di Giacomo, dalle difficoltà di collocare in musica una visione “ingombrante” come quella della balena bianca e un testo di tale meravigliosa apertura simbolica, poi superate anche attraverso la struttura ritmica del pezzo, all’arduo compito di accordare la strofa “malinconica” e l’inciso “solare”… insomma, tutti i segreti nascosti nella storia del capolavoro e della sua composizione, svelati e condivisi con la massima naturalezza, come in una riunione di amici (e questo era in realtà l’incontro, generatosi nella sua calda atmosfera malgrado il freddo della giornata). La progressione dei frammenti, montati “in progress” tipo gioco del meccano, trovava il suo degno e divertente trionfo con l’esecuzione integrale della canzone, tastiera e chitarra, cantata all’unisono da tutti i presenti. L’emozione si scioglieva infine in un lunghissimo e commosso applauso di ringraziamento per l’autentica meraviglia a cui si era assistito.
Prima del gioioso brindisi finale, a spumante e panettone, c’era anche modo di consegnare l’attestato di finalista – per la poesia “C’era una volta” – a Luigi Brasili, anch’egli di Tivoli, che non aveva potuto ritirarlo in sede di premiazione, alla Sala Consiliare di Palazzo Colonna lo scorso 21 ottobre. Anche Brasili, ringraziando Nocenzi, Onofrio e la giuria tutta, ha voluto donare a Bibliopop la copia di un suo romanzo.
Maurizio Aversa
10 dicembre 2023: l’intervento di Marco Onofrio alla Sala “Aldus” de La Nuvola di Roma (“Più libri più liberi”) per i 25 anni della Casa Editrice Edilazio

Celebrare i 5 lustri della magnifica casa editrice fondata dal compianto Willy Pocino nell’ottobre 1998, implica una complessità tale – di aspetti e problemi su cui riflettere – che è estremamente riduttivo sintetizzarla nei pochi minuti a disposizione. Si accendono tante idee in contemporanea, come finestre collegate in dialogo. Ad esempio il rapporto tra la pagina e il mondo: come ne viene condizionata, quasi scritta dalle mani stesse del tempo in cui viene alla luce, e quali margini di intervento le sono ancora concessi, tanto più oggi, per contribuire a trasformarlo. Oppure il grande tema della memoria, e della memorabilità di cose, fatti e persone, in una società consumatrice che la globalizzazione ha trasformato in lavagna magnetica per cui tutto diventa continuamente obsoleto ed effimero, non lascia traccia, e allora finisce per essere anacronistico chi, come una casa editrice seria, lavora e lotta per valorizzare il senso della differenza, della irripetibile unicità di ogni reperto o documento, dello spessore prospettico che consente di opporsi all’appiattimento della omologazione generalista, ai margini del cosiddetto mainstream.
Una volta si aveva il tempo necessario per la sedimentazione e la metabolizzazione del prodotto. Oggi ad un autore non bastano 3 libri l’anno per essere ricordato: la macchina culturale è un frullatore che divora e consuma tutto in pochi giorni. Anche i decani sono messi nelle condizioni di eterni esordienti, devono dimostrare continuamente chi sono e cosa hanno conseguito. È un mondo ad alte prestazioni performative, dominato dallo spirito manageriale e dai consuntivi economici, dove si dà per sottintesa la fine dei valori “alti”, delle parole maiuscole, degli ideali. Anche la letteratura deve conformarsi a questo trend commerciale: prevale il minimalismo, lo scetticismo blasé di chi, per fare la figura del furbo che la sa lunga, non prende più niente sul serio, tranne i soldi. E così via.
Alla fine il problema si riduce solo a questo: credere o non credere nell’umanesimo. La sua eternità, e dunque malgrado tutto il suo futuro. Ebbene, la verità è che solo gli editori “piccoli” e indipendenti come Edilazio possono permettersi di farlo! Per questo sono, di fatto, oasi di ristoro nel deserto più assetato e desolato. Mi viene in mente una famosa pubblicità degli anni ’70: “per dipingere una grande parete non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello”. Ovvero: per dipingere la parete del tempo – questo fa da sempre la cultura, svelando chi siamo stati, chi siamo e chi saremo – non occorre un editore grande, ma un grande editore! Gli editori grandi spesso sono piccoli piccoli… Sono costretti ad esserlo: in quanto aziende strutturate, devono far quadrare i conti della loro organizzazione industriale. Non possono permettersi esperimenti rischiosi, e allora vanno sempre sul sicuro conformando e confermando il gusto del largo pubblico, plasmandolo man mano verso il basso in un perverso circolo vizioso. Come la formalizzazione di un movimento sbagliato, che accentua il danno ortopedico e il conseguente dolore. Le major editoriali diventano quindi gli altari dove si celebra la “cosa stabilita”, il politicamente corretto, il luogo comune, il suono della maggioranza, il brusio dei pappagalli del “si dice”. Sono mass media generalisti che, come i giornali e le radiotelevisioni, obbediscono alle agende della politica e della finanza: forni a microonde dove viene semplicemente scaldata la pappa pronta, precotta e surgelata da chi decide nelle segrete stanze.
D’altra parte, se non pubblichi con l’editore grande non vieni preso sul serio. I recensori e i critici, per fare carriera e mantenere le posizioni conquistate, si occupano solo delle opere e degli autori di potere, e questo rafforza il sistema per cui anche il fruitore culturale medio pensa, in automatico, che se l’autore x è pubblicato dall’editore grande lo è per merito, e gran parte di questo merito alla fin fine è – con spettacolare contorsione tautologica – l’essere stato pubblicato da un marchio così prestigioso! Ignorano o fingono di ignorare che in Italia chi c’è e appare a livelli “ufficiali”, c’è e appare quasi sempre perché “deve” starci – come da agenda concordata – e insomma perché “vuolsi così dove si puote ciò che si vuole, e più non dimandare” ché se invece continui a dimandare, avrai le tue brave rogne e forse è meglio se vai a far danni altrove. E poi si lamentano, ipocriti, della fuga dei cervelli che dissangua le nostre risorse! Le cose autorevoli e ufficiali sono in gran parte decise a tavolino secondo un sistema di convenienze – gestito da poteri più o meno occulti, e i partiti politici sono soltanto la punta dell’iceberg – per cui chi è fuori dai giochi resta escluso dal grande giro e viene bloccato dai muri di gomma, se poi si ostina a volerci essere. Tutto questo, si badi bene, a prescindere dal merito, ché anzi il merito – in un sistema dove il potere stesso è valore da esibire – finisce per essere una colpa che si ritorce contro il guastafeste di turno che lo rivendica. Lo stesso trattamento viene riservato alle case editrici fuori dal coro che non mettono in vendita la propria libertà, e allora finiscono per pagarne il prezzo.
L’ottundimento culturale deriva anzitutto da un problema: la gente non legge, non approfondisce, ha una fruizione distratta e ipnotica delle cose, plasmata dal consumo quotidiano dei social e dall’abuso dell’i-phone. Drizza le antenne solo quando c’è il personaggio, il nome di successo, il cantattore. Sarebbe interessante sperimentare le differenze di ricezione che ai testi vengono concesse se di autore sconosciuto o viceversa affermato: cambia completamente il modo di percepire le stesse parole. E che dire del differente credito concesso all’autore, quando viene finalmente riconosciuto per le opere che prima venivano ignorate? Allora spuntano come funghi i profeti del giorno dopo: “lo avevo sempre detto, io!” E guarda caso parlano sempre a risultato acquisito… Si rilegga a tal proposito un romanzo emblematico come “Martin Eden”, di Jack London, che mette in luce fin dai primi del ‘900 le storture dell’industria culturale. È su questo orizzonte di attesa che vanno ad innestarsi i condizionamenti del mainstream. Le matrici della codificazione sono inquinate all’origine. Anche persone di cultura medio-alta sembrano aver smarrito il coraggio e gli strumenti critici per elaborare giudizi autonomi. In Italia, poi, ci sono più scrittori o sedicenti tali, che lettori! La cultura diventa così una vetrina di mistificazioni e uno strumento di autopromozione sociale: basti vedere le presentazioni dei libri, ormai nient’altro che passerelle di narcisi che smaniano per fare la ruota del pavone…
Ecco, date queste premesse, Edilazio è una casa editrice di sostanza autentica, non di forma vuota. Infatti, lungo il percorso dei suoi 25 anni di ammirevole attività e dei suoi circa 350 volumi pubblicati, ha saputo spezzare la catena perversa dell’autore valutato non per il valore dei libri che scrive, ma per l’autorevolezza dell’editore che lo pubblica e il carisma del potere che lo sostiene. A Willy non interessava “chi mandava chi” ma semplicemente la qualità e il rigore delle opere proposte. L’autore poteva anche essere completamente privo di “santi in paradiso”: se era bravo, otteneva udienza, attenzione e riscontro. Questo fattore umanistico in primo piano ha improntato da sempre e per sempre la “mission” della casa editrice, e cioè che la cultura ha in sé un mandato imprescindibile: esplorare il tessuto infinito dell’esistenza per riconoscervi l’universale. Ciò che ci rende Uno attraverso i secoli: l’umano condivisibile, l’uguale nel diverso e insieme il diverso nell’uguale, in un gioco di rispecchiamenti tra identità e alterità che dà sostanza alla storia, all’esperienza, al vivere civile. Edilazio non ha mai derogato al concetto che dell’editoria sviluppò Aldo Manuzio da Bassiano, a cui questa sala è dedicata: “mercanzia d’onore”, non solo d’utile. E quindi appello a tutto ciò che di alto e nobile abita nella natura umana. Verità, bellezza, etica, spazio di resistenza e condivisione. La cultura plagiata dai valori utilitaristici e dall’ipocrisia finisce invece per scavare abissi tra le persone, armandole l’una contro l’altra.
La lezione inesauribile di Roma come oceano di conoscenza ha insegnato alla casa editrice di Pocino la dialettica creativa tra particolare e universale, l’infinita ricchezza dei dettagli, le stratificazioni della complessità. Ogni collana è stata pensata come sottoinsieme autonomo della casa madre, e in certi casi nutrita a tal punto da potersi estrapolare come casa editrice a sé: ad esempio la fortunatissima “Studi e documenti” giunta alla sua cinquantacinquesima pubblicazione. Insomma Edilazio ha raggiunto e mantenuto il difficile equilibrio fra ragione e sentimento, come dimostra ancora una volta il volume “Roma nel cuore” appena pubblicato in onore di Willy. E proprio a lui penso per concludere, mutuando una definizione che Eugenio Montale diede del romanista Pietro Paolo Trompeo: “superstite esemplare di umanista di vecchio stampo, alieno da borie professorali, instancabilmente curioso, aperto a tutte le forme dell’arte e della vita”. La casa editrice Edilazio è come l’abbiamo descritta poiché assomiglia molto al suo fondatore, a colui che le ha dato l’impronta e l’ha sostenuta anche a costo di importanti sacrifici. Per questo è una casa editrice speciale e per certi versi unica.
Marco Onofrio
“Più libri più liberi”, 10 dicembre 2023: intervento di Marco Onofrio per i 25 anni della Casa Editrice Edilazio

Intervengono: Ricardo De Mambro Santos (scrittore e storico dell’arte), Marco Onofrio (scrittore e critico letterario), Giuseppe Sanzotta (giornalista)
Modera l’incontro: Mariarita Pocino, direttrice Edilazio
domenica 10 dicembre 2023, ore 17
Sala Aldus, Centro Congressi La Nuvola – Roma
“L’ingegnere del silenzio”, letto da Dante Maffìa

Qualche maligno credeva, quando affermavo che Marco Onofrio è un grande poeta, che erano sparate, esagerazioni mosse dalla profonda amicizia che ci lega, e non da una lettura oggettiva dei suoi versi. Sono felice che, a distanza di anni, anche un critico colto e competente come Plinio Perilli, a sua volta poeta, sia giunto alle stesse conclusioni, perché è notorio che Plinio non è mai sceso a patti con la mediocrità, con i faccendieri della poesia. Ha sempre volato fior da fiore e ha dato il suo consenso solo quando si è reso conto di avere davanti scritti sostanziali e sintetici di lavoro, di letture, di emozioni, di tecnica e di accensioni che vanno oltre la pagina e accendono le sfere del sentire profondo, della poesia alta.
Perilli, nel suo puntiglioso, dotto e largo studio introduttivo ha saputo condensare, con una lucidità e una profondità inaudite, tutti gli aspetti della poesia di Onofrio, e ne ha evidenziato il valore e la possanza espressiva, riequilibrando “tra forza e semplicità, vitalità e sano, istintivo turgore esistenziale”. Basterebbero queste parole per capire che ci troviamo di fronte a poesie che hanno saputo scavare nell’essenza di una liricità che ha trovato la luce con colpi di accetta nella cultura, nelle esperienze della vita quotidiana, nelle emozioni, nelle esaltazioni e negli scontri con i mondi che l’hanno preceduto, per poter essere voce libera e autonoma, ferma nel suo dettato, armonioso pentagramma di una conquista complessiva che ha qualcosa di pantagruelico ma senza mai cadere nello strafare.
Ho seguito Marco Onofrio libro dopo libro e ho potuto vedere, concretamente, non come impressione superficiale, lo spessore della sua crescita umana che è diventata spinta stilistica di primissimo piano. Ogni suo verso è distillazione di una verità che lo tormenta e lo porta all’interno del senso per estrarne il fuoco che servirà ad accendere le sublimi verità del non risaputo. Voglio dire che nella poesia di Onofrio si è sviluppata di pari passo la tensione linguistica e l’immersione nel pensiero, al punto che ogni poesia esprime una visione della vita e suggerisce accensioni dialettiche che entrano ed escono dalla filosofia però senza mai incastonarsi in teorema. Lui non si è improvvisato piccolo scrivano del minimalismo o del qualunquismo letterario. Un solo esempio, eccezionale, in “Sapienza e natura” per dimostrare che la mia lettura è frutto dell’impatto coi testi:
Arde dall’interno la visione
cosa tra le cose auto-cosciente
corpo di presenza è la scrittura
voce che rimbalza tra la gente
elicoidale immagine, fattura
sensitiva, magica, animale
sintesi: a regole di numeri e alfabeti
a spazi articolati vocazioni
sedimenti suoni ordinazioni
dentro fuochi di agglutinazioni
io chiamo questa voce che non sa
l’ultimo verso a dire l’impostura
se dice il primo verso verità…
ché più della sapienza può natura.
Potremmo discutere a lungo su questi versi che si muovono come il suono d’una orchestra che passa rapidamente dal liscio al rock, ma l’intento del poeta era soltanto dimostrare che le parole sono magie che si aprono all’infinito e che comunque alla fine è il dono che conta, è nel saper raccogliere la freschezza del senso rubato alle stelle e ai “sedimenti”, ai “suoni”, alle “ordinazioni”. Sono le parole d’ordine di una visione del vivere, del fare quotidiano che dimostrano come Onofrio abbia raggiunto una dimestichezza straordinaria con le visioni e con le coordinazioni tra pensiero e scrittura. Problema che fu molto acceso sia dopo l’esperienza della poesia romantica e sia dopo l’esperienza della poesia ermetica. Onofrio ne prende atto e poi si crea una sua misura che vuole sciogliere gli stilemi abusati in abbandoni e corteggiare il senso che arriva a valanga e fugge, lasciando però la traccia necessaria a ricomporre la verità del divenire.
Questo modo di porsi davanti alla realtà e alla scrittura ha messo Onofrio nella condizione di diventare angelo e demone di ciò che afferra e palpa, permettendogli di leggere “L’alfabeto della luce”, e di constatare che “Eterno è solamente / il dileguare”. Non bisogna comunque dimenticare le tante poesie nate dagli affetti familiari e dall’amore. Marco, anche nei versi dedicati alla morte del padre (ma le citazioni dovrebbero essere molte), alla donna amata, ai miti, a Roma, insomma agli aspetti della vita quotidiana, non ha mai spento il suo ardore che sa appropriarsi degli aspetti di ciò di cui parla e farli diventare impasto azzurro esiguo, cioè piuma di senso, approdo “oltre la maceria”, perché “La nostra casa è lo sguardo / il canto, l’amore, il senso / la disperata, ultima parola”.
Un’antologia preziosa che dà magnificamente il ritratto di una personalità poetica fuori dal comune, di un poeta che scalpita e brucia senza sosta cogliendo avvertitamente gli ori delle parole che, in un momento di estrema consapevolezza gli fanno scrivere:
Saprò bene di vivere, non solo
di esistere natura, fin quando
uomo, di senso umano, serberò
la forza della gioia nelle mani
per costruire amore
e intatto nei miei occhi lo stupore
dato in ogni cosa quando aperta,
seppure la più esigua e più “normale”:
e dentro quella dolce meraviglia
per il nuovissimo e sempre
più importante miracolo di vita.
È morto chi si abitua al suo respiro.
Dante Maffìa
“Ricordi futuri”: intervista su Canale TV 81
“Lettera aperta a Willy Pocino, in memoriam”, letta da Marco Onofrio in occasione dell’Omaggio dell’11 novembre 2023, a tre mesi dalla scomparsa

E così, caro Willy, non ti possiamo più toccare. Non vediamo più il lampo dei tuoi occhi sorridenti. Non ascoltiamo più il suono della tua voce. Ma tu davvero te ne sei andato? O non, piuttosto, ti sei semplicemente trasferito nella stanza accanto, per cui ora ci vedi, ci ascolti, cammini invisibile in mezzo a noi?
L’estate giocoforza travagliata, la tua condizione sempre più fragile, l’urgenza che, implacabile, bussava sempre più spesso alla porta. Ero partito per una breve tregua, qualche giorno di mare in Calabria, con il conforto di una piccola speranza. La dialisi peritoneale non aveva funzionato, ma l’emodialisi completa ti aveva prontamente ristabilito, sia pure per poche ore. “Finalmente mi sento bene” mi avevi detto in un sospiro l’ultima volta che ci siamo visti, dal letto dove eri ricoverato, all’ospedale S. Giovanni di Roma, più per rassicurare me che per esprimere una tua sicura convinzione. Pareva insomma che si fosse imboccata la strada buona… e invece, di lì a poco, l’atroce notizia. Ero in spiaggia quella mattina, stavo facendo il bagno nelle acque blu di Scilla mentre tu nascevi al mondo della Luce che non tramonta mai. 11 agosto 2023. Eri libero dal grumo dolorante della carne, che tanto ti aveva fatto penare nell’ultimo anno della tua lunga vita. Chissà se il tuo spirito, trasumanato dall’immensità della scoperta che ci attende dopo l’ultimo respiro, spinto dalla sapienza inconcepibile della Grazia o guidato dalla voce delle Sirene mediterranee, è venuto a salutarmi subito dopo, nel grido fuggitivo di un gabbiano, nello scroscio di un’onda, nel guizzo lampeggiante di un riflesso.
Che mistero terribile è la morte! La persona cara se ne va e noi, se siamo lontani, in quel momento non ne sappiamo nulla, restiamo esclusi dal percepire quanto accade o è appena accaduto, immersi nel torrente della nostra esistenza che invece prosegue. E così arriva la “telefonata” che non vorremo mai ricevere: Mariarita, distrutta dal dolore, singhiozza al telefono e io capisco subito. In un attimo, mentre le lacrime scendevano da sole, irrefrenabili, ho rivissuto tutti gli attimi trascorsi insieme a te: i pranzi, le cene, le gite, le vacanze, i discorsi, i ragionamenti, le riflessioni comuni, le storie e le storielle che mi raccontavi e che a un certo punto sapevo e ricordavo meglio di te, quei deliziosi aneddoti con cui, affabulando, sapevi affascinare chiunque ti ascoltasse, anche perfetti sconosciuti, e poi i casi incredibili di cui ancora ti stupivi dopo anni, le barzellette, quelle piccanti e quelle più castigate, e le risate, le risate e le risate… Quante me ne avevi fatte fare! Con te si stava in semplice armonia, creavi ovunque un clima di festa, di dolcezza, di calda bellezza umana. Mettevi pace, scioglievi le tensioni, rinfrancavi i cuori. Era uno dei tuoi carismi. Mi avevi accolto come un figlio, con tenerezza immediata, e poi eravamo diventati complici e confidenti, come amici di vecchia data.
Ah, le estati indimenticabili nelle Marche, a Pievebovigliana, trascorse al fresco di quella casa che il terremoto del 2016, vissuto in diretta proprio lì, ha reso temporaneamente inagibile e dove entrambi ci portavamo per le vacanze cataste di libri da leggere e almeno un’opera da continuare a scrivere nella concentrazione assoluta di un silenzio confortato dalla dolce musica scrosciante della cascata che spumeggia al lato della strada! E poi le bozze infinite da correggere, nelle quali ti vedevo sempre impelagato con la tua penna rossa e i tuoi segni minuscoli, come la grafia con cui scrivevi. E l’impaginazione della tua, della nostra amata rivista, “Lazio ieri e oggi”, la tua primogenita creatura. E gli eventi culturali da organizzare e svolgere, i libri da presentare, e le fatiche della Fiera all’Eur in cui ogni anno a dicembre, fin dalla prima edizione, misuravi con soddisfazione i frutti del lavoro svolto.
Non ti è stato semplice fare l’editore. Gli editori devono avere i peli sul cuore, e infatti sono quasi sempre spietati, opportunisti, indifferenti: l’esatto contrario di te! Edilazio, la casa editrice che hai sviluppato dalla rivista 25 anni fa, ti ha dato forse più dolori che gioie, talvolta esponendoti alla ferocia e alla rapacità di personaggi da dimenticare, e non aggiungo altro… Ma tu molto hai perdonato e capito, fornendomi con l’esempio diretto grandiose lezioni di vita su quella che amavi chiamare “cristiana rassegnazione”: la forza umile e gentile che ti faceva superare qualunque ostacolo senza mai perdere il filo della speranza, della fede in un futuro migliore per te e per tutti. Eri un inguaribile ottimista, e questo certe volte finiva per diventare un difetto poiché vedevi cose e persone migliori di quanto lo fossero realmente, e allora ti donavi – inerme di eccessiva fragilità – anche a chi non meritava, anche quando non avresti dovuto…
Sei stato fin troppo generoso, aiutando tutti e spesso avendone in cambio, com’è tipico di questo mondo, solo amarezze, torti e irriconoscenza. “Ci rimasi malissimo”, non a caso, è una frase ricorrente nelle memorie autobiografiche che hai scritto qualche anno fa – un libro che letto oggi, dopo la tua scomparsa fisica, ha ancora più valore poiché racchiude tutta la rara preziosità del percorso che hai sviluppato, così amabilmente, nella giungla delle vicende umane. Vorrei sottacere, ma non posso non ricordare, la stretta al cuore da me provata nel vederti più volte tornare a casa come un passerotto arruffato, stanco e deluso dopo lunghissime riunioni inconcludenti con politicanti della Regione Lazio o del Comune di Roma che ti palleggiavano da un ufficio all’altro, senza alcun rispetto per la tua anzianità, per capire se eri davvero ingenuo come sembravi o invece eri disposto, in cambio di qualche sovvenzione, a fare della tua rivista un organo utile alla loro volgare e implacabile ricerca del consenso. Tu venivi da un’altra Italia, quella dove la parola data aveva più valore di una firma scritta: sulla base di quale codice avresti potuto intenderti con certi squali, privi di ogni scrupolo elementare? E poi, perdonami l’appunto, non avresti dovuto sentirti umiliato, come peraltro accadeva, poiché l’umiliazione – a ben vedere – l’avevi inferta, non patita: non tu ma loro, i cialtroni in doppio petto, erano stati umiliati dalla tua nobiltà d’animo, dalla tua dignità, dalla tua libertà di piccolo gigante della Cultura, con l’iniziale maiuscola, tutt’altro che presunto galoppino delle cosiddette “politiche culturali”. E ciononostante ti rifiutavi di prendere atto della sporcizia del mondo, di capire cioè che prebende e benefici sono decisi a monte per questioni di opportunità e scambio di convenienze, non elargiti per motivi ideali o per la gloria dell’umanità.
Bando alle amarezze, voglio farti sorridere un po’. Provo a raccontarti una storiella, perdona se non so farlo bene come avresti fatto tu. Ascolta dunque. Un re voleva sapere cosa fosse peggio, l’invidia o la meschinità. Per saperlo fece chiamare l’uomo più invidioso e quello più meschino di tutto il regno. Il re disse loro: “Chiedetemi ciò che volete, ma ad una condizione; darò all’altro il doppio di ciò che ciascuno di voi chiederà per se stesso”. L’invidioso e il meschino ebbero un giorno per pensarci e decidere. Entrambi passarono la notte insonne, ad arrovellarsi. L’indomani il meschino decise di non chiedere nulla, pur di lasciare l’invidioso a bocca asciutta. L’invidioso chiese che gli venisse tolto un occhio, pur di accecare il meschino. E ascolta ora questa battuta fulminante di Bette Midler: “Ora basta parlare di me, parliamo un po’ di voi. Cosa ne pensate di me?”. Ecco, ti ho appena illustrato il mondo della cultura: egocentrismo patologico, invidia, meschinità. Ma tu eri altro da tutto questo. Come tutti gli eccellenti eri umile, non sbandieravi mai i tuoi 40 libri su Roma, i tuoi innumerevoli premi, i titoli ufficiali acquisiti per merito (eri Cavaliere della Repubblica e Commendatore, ma nessuno lo sapeva), poiché avevi da sempre consapevolezza che dinanzi alla morte siamo tutti uguali e che quando arriviamo dove tu sei ora non ci portiamo dietro nulla di nulla, se non l’anima. E quella, tu, l’avevi grande. Infatti non cercavi ossessivamente il tuo tornaconto, non ti anteponevi agli altri, non adoravi il potere per inseguire il successo. Disse un’altra anima grande, Mahatma Gandhi: “Il giorno in cui il potere dell’amore supererà l’amore per il potere, il mondo potrà scoprire la pace”.
Direi per concludere che tu eri semplicemente questo: un uomo d’amore. Amavi gli altri, cioè desideravi il loro bene, godevi della loro felicità. Tenevi a farli essere liberi di essere se stessi: se non è amore questo, cos’altro lo è? Hai avuto in sorte un’anima speciale, da mago buono, e il tuo compito terreno era con ogni probabilità: sciogliere i nodi, costruire pace, aiutare gli altri. Ed è ciò che probabilmente continui a fare nella Luce, ora, alle radici eterne dell’invisibile. Noi siamo testimoni e memori del tuo insegnamento di vita e di cultura, e quando dico “noi” penso anzitutto alla tua amata, unica nipote: Valentina. Ti ricorderemo in ogni articolo che scriveremo, in ogni pagina che leggeremo, in ogni sguardo che poseremo sulla tua amata città. E avremo “Roma nel cuore” ogni volta che sarai nelle cose che vivremo. Un grande abbraccio, ovunque tu sia.
Marco Onofrio
Note di riflessione sul Premio “Moby Dick-Gruppo H24”, a pochi giorni dalla Cerimonia di Premiazione a Palazzo Colonna. Intervista di Maurizio Aversa all’ideatore e presidente, Marco Onofrio
Come hai partorito l’idea del Premio “Moby Dick”?
Mi è balenata in testa grazie a un fortunato “filotto” di intuizioni che si sono accese e illuminate a vicenda. Tra l’Associazione culturale di Bibliopop/ACAB (Associazione Comune Autonomo Boville) e il capitano Achab dell’immortale capolavoro di H. Melville (1851), si è accesa all’improvviso una scintilla. Il passo successivo, subito dopo, è stato evocare la celebre canzone del Banco del Mutuo Soccorso (1983), e quindi l’attuale leader della band, il M° Vittorio Nocenzi. Marinese Doc, Nocenzi vive e compone musica a Genzano, da cui parte e a cui ritorna prima e dopo i numerosi concerti in tutta Italia: era dunque la figura iconica perfetta per rappresentare un premio letterario nazionale, sì, ma nato e contestualizzato nei Colli Albani. Contattato da un “certo” Maurizio Aversa [ride, n. d. R.], Nocenzi ha accolto con entusiasmo la proposta della presidenza onoraria del Premio. Da lì, è partito tutto.
Qual è il significato del Premio?
La celebrazione umanistica dell’Ideale. L’iniziativa è dedicata a tutti i sognatori, a chi non abbassa lo sguardo davanti alla realtà, a chi cerca e cattura visioni oltre l’orizzonte. I grandi temi irradiati dalla sua “mission” e sintetizzati per sempre dal mito della balena bianca sono: il sogno, l’utopia, l’immaginazione, la trasfigurazione, la ricerca e l’inseguimento senza fine di un mondo migliore. Il Premio obbedisce alla necessità sempre più urgente di seminare e raccogliere umanesimo per contrastare la deriva di questa disumana e alienante società tecnocratica globalizzata, che sta producendo un arretramento dell’evoluzione umana e un generale degrado dell’intelligenza. Viviamo le estreme propaggini dell’epoca che H. Hesse – nel romanzo “Il giuoco delle perle di vetro” (1943) – chiama “appendicistica”, cioè di fatua banalizzazione divulgativa, di perdita del centro in grado di unificare le più svariate esperienze e prospettive, e insomma: di fine dell’umanesimo. Abbiamo assistito impotenti alla meccanizzazione e alla mercificazione dell’esistenza; all’incredulità dei popoli, disorientati da informazioni contraddittorie e massacrati da decenni di disillusioni, ma per altri versi fin troppo ingenui o indifferenti; alla falsità istituzionale assurta al comando del pianeta. La menzogna viene creduta sulla parola, mentre per la verità non bastano neppure le prove! Ci sentiamo tutti stranieri, anzi: esuli.
Conoscendoti, hai sicuramente scrittori da citare in proposito…
Certo! Penso subito alle parole profetiche di Pasolini, quando scrive del desiderio nostalgico di “qualcosa che contraddica la vita come si va configurando all’uomo moderno, la sua grigia orgia di cinismo, ironia, brutalità pratica, compromesso, conformismo, glorificazione della propria identità nei connotati della massa, odio per ogni diversità, rancore teologico senza religione…” Noi ci chiediamo inutilmente: quando finirà questa discesa nell’abisso? Questa insipienza che raccoglie consensi e suscita applausi? Questo vuoto pneumatico generalizzato? La guerra comincia nella testa delle persone, anche quelle comuni, prima che nei campi di battaglia. Vorremmo poter aderire alle parole pronunciate da E. Montale mentre riceveva il Nobel, nel dicembre 1975: “Ma non è credibile che la cultura di massa per il suo carattere effimero e fatiscente non produca, per necessario contraccolpo, una cultura che sia anche argine e riflessione”. Eppure, quale possibilità ha l’individuo in un mondo di inaudita e indicibile complessità, in cui i condizionamenti esterni sono diventati così schiaccianti che i moventi interni non hanno più alcun peso?
Che risposte ti dài?
Una sola risposta auspicabile: svegliandosi e cominciando ad agire bene, cioè nel modo giusto, fin dalle minime cose. Abbinando quantità a qualità. Costruendo cultura autentica “dal basso”, con un movimento ascensionale come quando la balena riemerge dagli abissi dell’oceano. Citerò un altro scrittore, l’americano R. Pirsig: “Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere diventato per gli altri una persona interessante e non un oggetto”. Questione di qualità, cioè di adesione profonda tra forma e sostanza: a tal fine mira il discorso di Pirsig. Così fa anche l’artista quando opera all’altezza del suo appello interiore, esprimendo valori mediante simboli in vicendevole rapporto, come le onde di uno stesso mare. E appunto la qualità è assimilabile a un’onda. Continua Pirsig: “quel lavoro di Qualità che pensavi nessuno avrebbe notato viene notato eccome, e chi lo vede si sente un poco meglio: probabilmente trasferirà negli altri questa sua sensazione e in tal modo la Qualità continua a diffondersi. È così che il mondo può migliorare”.
In questo si possono rintracciare le radici del cosiddetto “impegno”?
Sì, attraverso strade più o meno programmatiche, ma ciò che conta è l’attitudine, il pensiero che muove il percorso, il ritmo del suo andamento. Ci sono equilibri invisibili e sottili che maturano in silenzio attorno a noi. Abbiamo il potere di spostarli, sia pure impercettibilmente, con i pensieri, le parole, le scelte e le azioni di ogni giorno. Dice un adagio popolare: “fai bene le cose ordinarie, e per magia ti ritroverai a fare cose straordinarie”.
Impegno, popoli, sviluppo e non progresso, alienazione e non partecipazione, declinati con uno degli aspetti umani che finalizzano tutto ciò alla gestione del potere, la lotta delle classi e la politica: come li affronta/risolve lo spirito di Moby Dick/Marco Onofrio?
Con la consapevolezza che cultura “è” politica, nella misura di una implicazione totale nelle memorie, nelle vicissitudini e nei destini di tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Così come noi votiamo anche decidendo di acquistare o no un prodotto commerciale, facciamo politica anche leggendo un libro o vedendo un film che ci aprono la mente, ci rendono più consapevoli, lucidi, combattivi. Il potere della gente è maggiore di quello della gente di potere: se solo si unissero le forze, passando indenni attraverso le reti di contenzione che le oligarchie tessono per mantenere lo status quo di ingiustizia, il futuro del mondo potrebbe davvero essere migliore.
Che cos’è infine, per te, la cultura?
Uno spazio di condivisione e resistenza umana al pericolo incombente della barbarie. Abbiamo la speranza e la convinzione che le tenebre non prevarranno: noi lottiamo per la luce! È anche questo il significato profondo del Premio “Moby Dick”…
“Ricordi futuri”, letto da Maria Teresa Armentano
Questo saggio di Marco Onofrio, con i suoi trenta articoli e le sue dieci letture critiche, si impone nel settore editoriale come protagonista sia per l’ossimoro del titolo, sia per l’opportunità di riflettere sulla realtà offerta ai lettori che, confusi dalla nebbia del vivere quotidiano e da un’esistenza che si trascina senza interrogativi, preferiscono invece escluderla dai loro pensieri. Ogni articolo del libro pone domande che inquietano perché senza risposte e, nella loro singolarità, ne generano altre che moltiplicano i dubbi, solo in parte attenuati dalla saggezza delle citazioni che opportunamente si intrecciano con le considerazioni del saggista.
L’analisi della società contemporanea che Onofrio presenta è sconcertante ma puntuale e autentica, guarda con gli occhi di dentro ciò che è visibile ai molti che colgono la superficie di un magma ribollente: la società senza punti di riferimento, senza obiettivi comuni che potrebbero innestare il cambiamento. La parola Comunità, il senso profondo di una collettività che persegue fini non commerciali, non utilitaristici, non è più nel DNA di un mondo sempre più disumano, senza più compassione, incapace di guardare ai bisogni altrui, che si arrende ogni giorno avvicinandosi all’orlo del baratro. Il saggio di Onofrio offre una doppia lettura. La prima è quella del ricordare, infatti i suoi scritti sono un colloquio con se stesso come nei Ricordi dell’Imperatore Marco Aurelio; lo scrittore guarda con disincanto l’agire umano e trae forza dai suoi convincimenti persuadendo anche i lettori che esiste salvezza nella cultura, nell’educazione al bello, perché la bellezza è un ponte verso il mistero delle cose, nella lotta per cambiare noi stessi prima che il mondo. La seconda scandaglia la contemporaneità, sviscerandone gli aspetti peggiori che, diventati spesso abitudini inveterate, ci tolgono il fiato con un’ansia che si placa solo, quando si placa, con i tranquillanti. La passione insita nelle parole del saggista valica i confini della oggettività quando lo scrittore, generalizzando un modello, trasforma una minoranza di donne in maggioranza. Sì, moltissime donne concorderebbero sull’idea che esse assumono il ruolo di consolatrici credendo di poter redimere e trasformare un uomo, ma in realtà cambiano solo se stesse. Il motore di questo cambiamento è il mistero dell’amore che, insondabile, angoscia l’essere che non sa risalire dalla profondità del pozzo in cui le domande senza senso lo hanno respinto. Negli ultimi articoli, concernenti gli anni più recenti, Onofrio disegna uno scenario apocalittico davanti a cui il singolo e anche i popoli sono impotenti, presi come sono in un ingranaggio che li stritola. In questa analisi il “modus rebus” non c’è perché si sono superati i sunt certi denique fines, quos ultra citraque nequit consistere rectum di oraziana memoria. In quel secolo prima di Cristo si rafforzavano gli stravolgimenti causati dal potere e dalla tirannide, ma erano presenti valori come la bellezza della poesia, l’amicizia e il desiderio di una vita semplice che combattevano la deriva verso cui la civiltà del tempo si avviava. Nel periodo in cui viviamo, non resta che un Recede in te ipsum che mi sembra anche la conclusione a cui giunge Onofrio quando scrive di desiderio come movimento della volontà verso qualcosa che non c’è ma potrebbe esserci se ognuno di noi, nel ritrovare se stesso, diventasse motore della Storia.
Non posso evitare di soffermarmi sulle letture critiche, quasi una summa che amplia lo sguardo nell’incontro non casuale di pagine letterarie spesso meno conosciute o dimenticate. È merito di Marco Onofrio affascinare il lettore con le sue pagine critiche e la sua bella, incisiva scrittura: non un’appendice ma saggi all’interno di un saggio che offrono ritratti pieni di un’epoca, di un popolo e di uno scrittore. Non ultimo pregio di questo testo la possibilità di scegliersi argomenti diversi e di ritrovare un filo comune, che è la schiena dell’autore diritta dinanzi al potere, il suo dire senza retorica, lo squarciare il velo dell’apparenza per consentirci di intravedere la verità di una realtà che ci è tanto estranea umanamente da desiderare di respingerla e annullarla. Alla fine di una delle sue letture critiche l’autore riporta queste parole, degna conclusione ideale del suo testo: “Porto con me la certezza che l’uomo ha ancora la possibilità di guardarsi allo specchio e ritrovarvi un essere gioioso e speranzoso se è cosciente di chi è e di che cosa deve fare insieme agli altri” (da “(H)ombre(s) migranti”, di Andrea Cantaluppi).
Maria Teresa Armentano































































