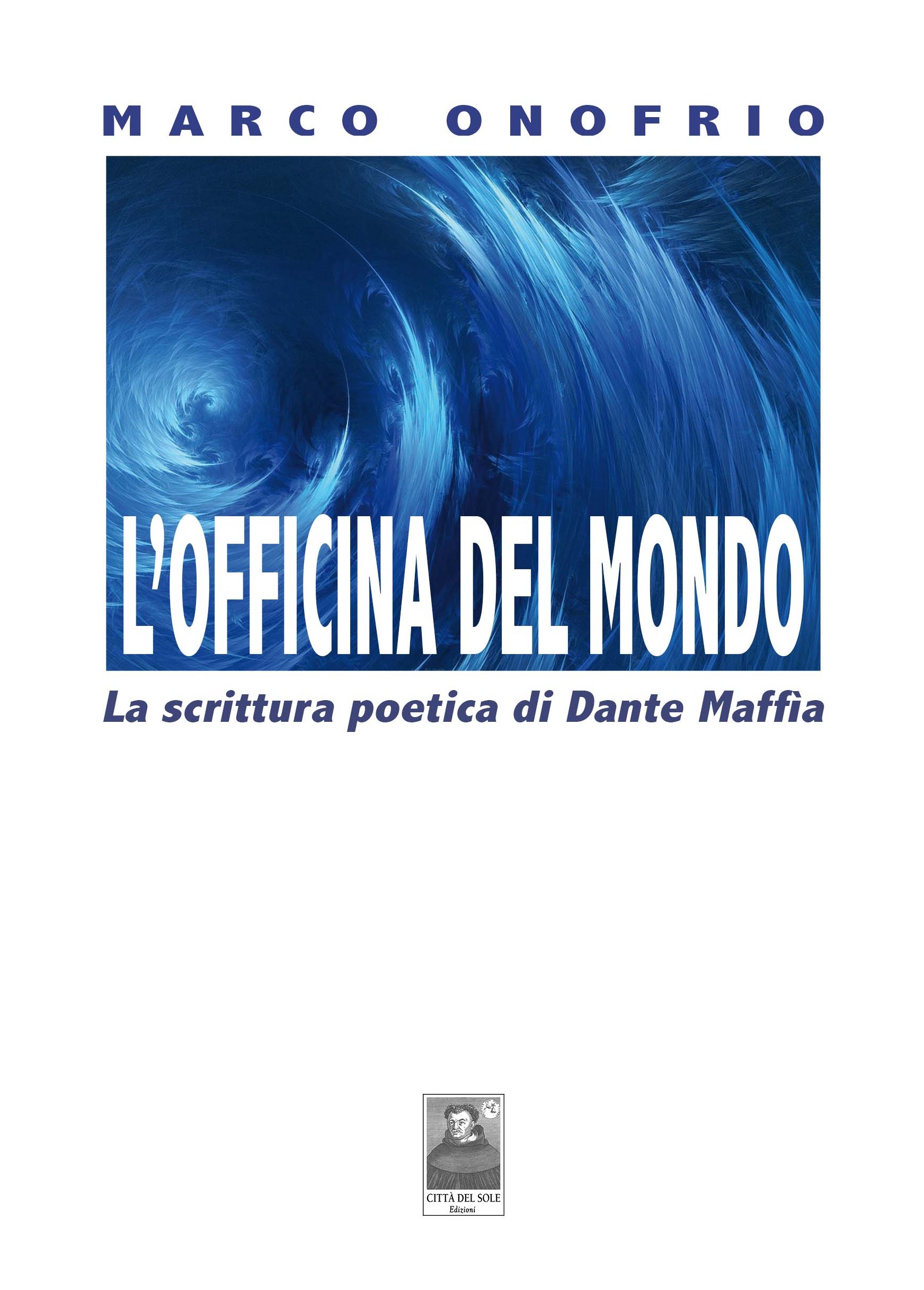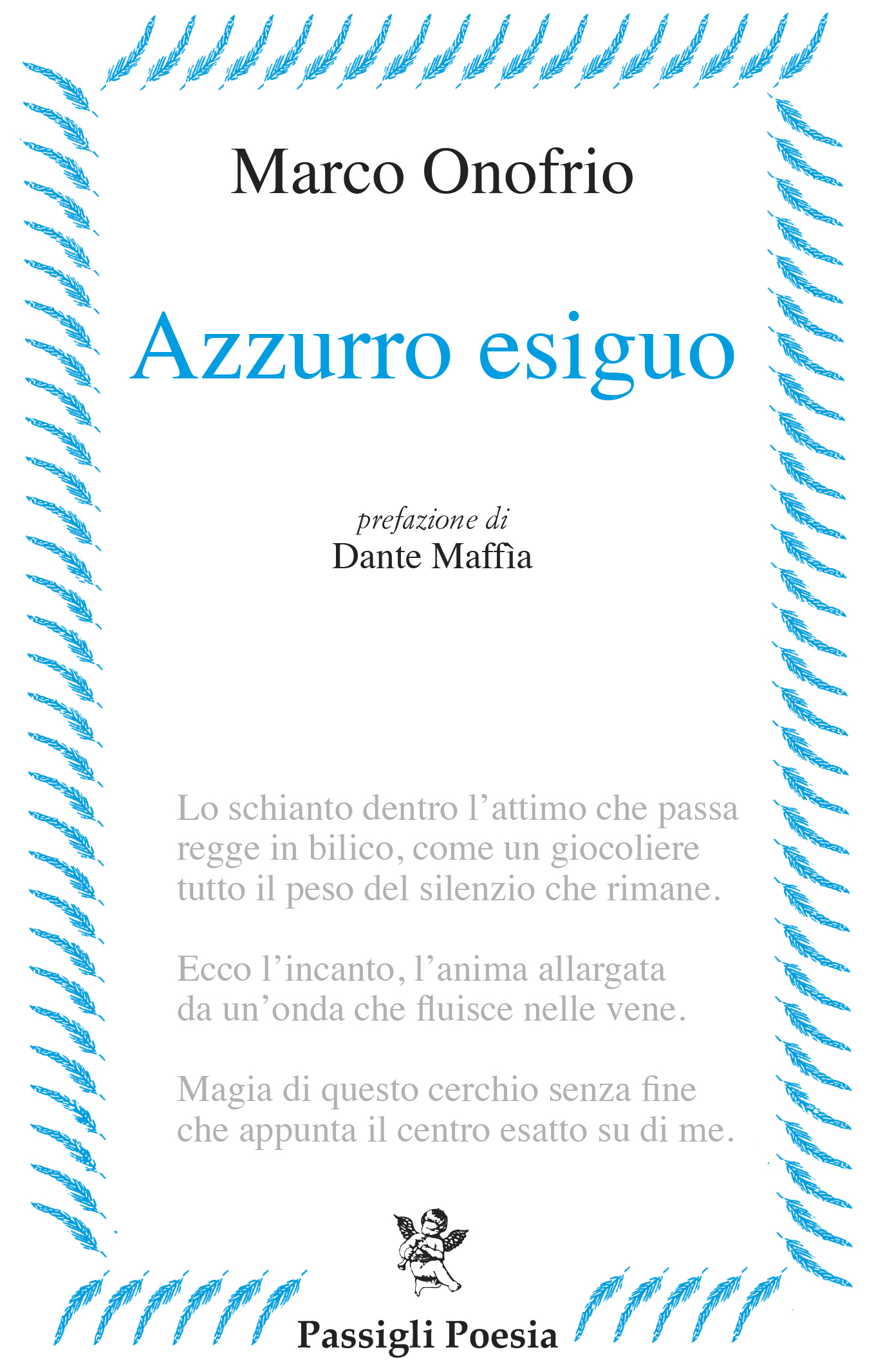La silloge “Con altra voce” (Edizioni Nemapress, 2019), di Sabino Caronia, raccoglie 30 poesie che paiono scritte con la bocca amara, le labbra deformate nella smorfia di un gusto aspro che tenta di nascondersi sotto il velo brillante dell’ironia ma che in altri momenti, al colmo del malincuore, può lasciarsi andare apertamente nel sarcasmo. L’opera si dipana tra “diario di assenze”, giocate tra non più e non ancora, e “naufragio di amori” mai consumati, soltanto sognati, finiti sul nascere o al primo apparire della loro potenzialità. Dalla “ferita del possibile” qui si passa alla “ferita nell’esistere”, giacché l’esistere stesso è e produce una ferita che langue in silenzio e «tutt’a un tratto» può risanguinare. Caronia guarda da spettatore passivo al destino che muove da dentro l’evoluzione delle cose, governandone e determinandone gli incontri, gli scontri, le separazioni, fino alla chimerica «forma segreta» della loro essenza. Ad esempio il vento che «corre all’appuntamento con le foglie», o le nubi che passano in cielo «messaggere di lutto», oppure la cometa che fugge «chissà dove / da chissà quale terribile dove / e silenziosa nella notte» va «sempre obbediente ai calcoli del cuore». La voce “altra” della poesia scaturisce dalle crepe sul muro compatto dei sogni, fratturato dalle esperienze, dalle delusioni, dai dolori. Da cui, conseguente, la constatazione del nulla in cui siamo immersi e a cui siamo destinati, a dispetto del nostro inutile sforzo, e quindi anche l’incomunicabilità, «la coscienza d’essere vivi in un mondo di morti» e, talvolta, la vergogna «d’essere un uomo».
Cosa resta di noi, di queste nostre
vite senza memoria, cosa resta
di questa solitudine infinita?
Soli, come Franz Kafka, dentro un treno
che corre per deserti alti di neve.
La vita è come un viaggio in un mattino
freddo, nebbioso, triste, senza luce
che ci conforti e ci riscaldi il cuore.
Infatti il cuore è freddo, ed è freddo perché troppo ha compreso, facendo di persone, cose e situazioni «specchio di me vivo e profondo» fino alla vertigine dell’inesistente. L’intelligenza (intus legere) è in certi casi una condanna, si vorrebbe avere meno consapevolezza – o almeno un senso meno vivo e straziante – di ciò che accade dentro e intorno a dove siamo.
Questo è morire, sai: guardare dentro.
L’esistenza è il dolore sconsolato di capire che «dietro quella finestra c’è la notte» e che siamo tanto fragili: «Domani il vento ci porterà via». A questo freddo, che in ultima ipotesi può anche essere eterno («quando i vermi un freddo pasto / faranno alfine del mio corpo»), Caronia oppone il potere consolatorio offerto – soprattutto nella prospettiva malinconica del post factum – da lacerti episodici di vita, attimi irripetibili, rare luminose epifanie, attraverso la mediazione salvifica della Donna: le sue mani sulle mani innamorate, il «calore delle dolci labbra» che scalda ancora le sue, gli occhi grandi «dove amore fa nido», gli «occhi di cielo» dove ritrova la «fuggiasca fecondità», i pensieri dove vorrebbe vivere, la «promessa di futuro / che ritorna da un tempo ormai lontano / e il cuore scalda e l’anima innamora», ecc. L’amore che nutre i frutti della vita e la poesia che li raccoglie possono opporre un argine di salvezza al baratro eterno in cui tutto prima o dopo è destinato a dissolversi. Lo scrittore è come colui che «accende fiori di solarità» posandoli in offerta votiva «sul nero del dolore», e Caronia ricorda il girasole che Plinio Perilli portò in dono al funerale del caro Elio Fiore. Si tratta insomma di poesie pervase da un disperato bisogno di felicità, in attesa di un appuntamento «dove non c’è miseria né dolore» (come quello sospirato da Don Fabrizio Salina quasi alla fine del Gattopardo, “un appuntamento meno effimero, lontano dai torsoli e dal sangue, nella propria regione di perenne certezza”), qualcosa che dunque ci liberi dal gioco trito e tristo dei giorni in cui siamo impelagati. L’opzione di un’altra voce (che è, infine, la poesia stessa) apre universi alternativi, scenari che si affacciano su dimensioni diverse da quelle ordinarie, per limpidezza, lucidità ed intensità percettive, benché ad esse parallele e in qualche modo adese, forse concentriche. Un esempio di questa realtà poeticamente rinnovata e “salva” è nella bella composizione “Sotto diverso cielo”:
SOTTO DIVERSO CIELO
Il vivissimo fuoco
dei tuoi verdi occhi chiari
come lama sottile
mi ha frugato nel cuore,
sotto diversa luce,
sotto diverso cielo,
su prati di smeraldo,
dentro una pioggia d’oro.
Il mondo visto con gli occhi di un trapassato, che finalmente ha visto svelata “sotto diversa luce” la verità del mistero, implica la salvezza ultima della fede religiosa, del credere in ciò che non si è visto e del sapere con tutta l’anima che «Cristo è Cristo», ossia che fedele e saldo come Lui al mondo non c’è e non ci sarà mai nessun altro. Cristo infatti è «infinita speranza che non muore» ed è Lui lo scoglio sicuro che può offrirci l’«appiglio» dove resistere al naufragio ininterrotto delle cose. La ricerca del divino che è in noi non deve languire nell’abitudine dei fatti scontati, ma essere pungolata dalla sete viva dell’assoluto, ed è ciò che si afferma nella prima composizione – quasi un segnavia, una stella cometa deposta a splendere proprio all’incipit del cammino – che peraltro ritengo la migliore, anzi la più memorabile delle trenta:
COME L’ACQUA
Poiché l’acqua è insegnata dalla sete
non ci resta che prendere la sete,
per maestra, per guida d’assoluto,
nei cammini dell’anima inquieta.
Marco Onofrio