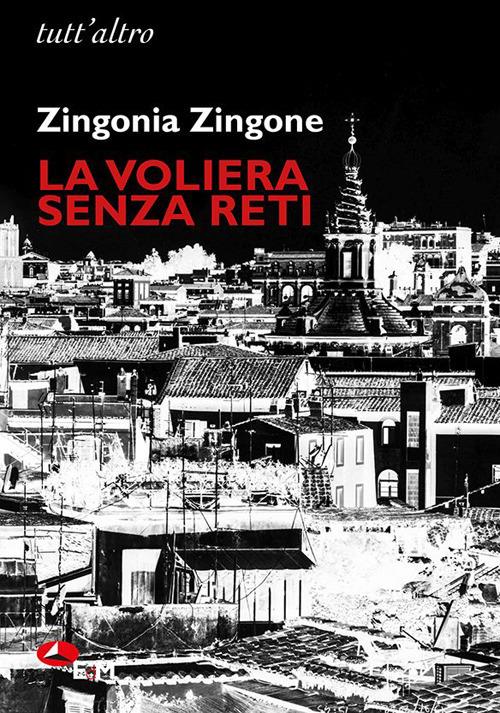La definizione di “introduzione al personaggio” o “all’opera di”, riferendosi a L’uomo che parla ai libri. 110 domande a Dante Maffia, a cura di Marco Onofrio (EdiLet, Roma, 2018, pp. 88, Euro 13,00), è talmente riduttiva e fuorviante che nella presente recensione non si proverà neanche ad usarla. Questo libro, miracolosamente agile, data l’enormità dei contenuti che veicola, è un prodigio di sintesi, introspezione, speranza e nostalgia, carne e spirito, eterno e quotidiano e tutta un’infinità di categorie opposte, ma tali solo alla povera percezione della nostra umile mente lineare. La stessa che non sente mai che la Terra gira a velocità inimmaginabili, che crede ancora al tempo tic-tac tic-tac, che crede ancora che le cosiddette “cose” realmente entrino in esistenza una dopo l’altra solo per il fatto che la nostra limitata percezione mentale e cosciente ci arriva sempre e solo lentissimamente, così come un moscerino, posandosi su un libro in un pigro pomeriggio d’estate, potrebbe leggerne le parole di una singola pagina. Bene, L’uomo che parla ai libri va aperto con cautela perché rappresenta un vero e proprio vortice che all’improvviso ti risucchia in un panorama multidimensionale impressionante in cui la tua povera mente lineare non capisce più, non “sente” più la demarcazione tra ciò che è (sempre secondo lei ovviamente), ciò che è stato, e ciò che sarà. In queste pagine l’immagine di disperazione per una mamma inchiodata alla sedia da una tragica malattia, quando Maffìa era ancora un bambino, convive con il magmatico pulsare di tensioni innegabili (e candidamente innegate) intrise di amore, sensualità, sessualità vissuta al massimo dell’autentico e del trascendente, come trampolino verso lo spirito, verso l’assoluto.
Il diario di un uomo, prima e oltre che di un artista, di una persona sì, ma non al modo dei latini, anzi del tutto priva di qualsiasi maschera. Un uomo che ha vissuto sempre con il cuore sulle labbra e la poesia tra le dita. Un essere umano sapientemente corteggiato, svestito e poi ancora amato dall’altrettanto sapiente e sottile sentire di Marco Onofrio, che va aprendo inesorabile, una dopo l’altra, le 110 stanze di “Palazzo Maffia”, dell’imponente edificio culturale, spirituale e profondamente umano rappresentato da questo straordinario uomo d’ingegno, con la delicatezza di una colf esperta che ormai conosce tutto della famiglia che la ospita, apparentemente al mero servizio di un Maestro contemporaneo (e naturalmente della propria opera, “a cura di”), ma che in realtà svolge un ruolo indispensabile alla perfetta riuscita del libro e della sua incredibile autenticità mozzafiato. Non davanti a tutti infatti, il grande poeta, scrittore, saggista e molto, molto altro, Dante Maffìa, avrebbe messo a nudo la propria anima, la propria vita, fino ai più remoti recessi della coscienza, con un senso di relax tale che sembra proprio di partecipare a uno dei tanti convivi che Lui ama tanto.
Si provi ad immaginare un artista insignito della Medaglia d’Oro alla Cultura direttamente dal Presidente della Repubblica, un autore candidato al Premio Nobel da tutto il Consiglio Regionale (all’unanimità!) della propria Terra di origine (la Calabria) e da molte Università, Fondazioni e Comitati, in Italia e all’estero, uno scrittore tradotto in oltre venti lingue in tutto il mondo e che può vantare un’infinità di altri titoli e riconoscimenti, per non tralasciare una lunga e onorata carriera di insegnante che da sola giustificherebbe più di una vita intera. Ecco, dopo aver immaginato questo, si pregusti la sorpresa, la gioia disarmante, il sorriso beato che si schiude sulle labbra del lettore quando inizia a notare che la conversazione vira vorticosamente su… cosce femminili e sensualità! Ma anche sull’impellenza della scintilla divina alla base di qualsiasi opera, che altrimenti è pura ginnastica di polsi. Sì! Dante Maffìa, come Marco Onofrio, è “uno vero”, come si dice in questi casi. Sono entrambi ambasciatori della Luce, della Verità, della Magia! Nel senso che mai priverebbero una propria opera dello slancio, del fragore e della fragranza che solo un’esistenza profondamente calzata, gustata, leccata fino in fondo al piatto della quotidianità, può sprigionare.
Senza anticipare troppo, si legga per esempio la domanda n. 104 e la dissacrante chiusura della relativa risposta! E si pensi, inoltre, che un creativo tanto riconosciuto e acclamato si propone ancora oggi (domanda n. 108) “di far sentire i brividi di un bacio alle persone che sono state dissestate dall’aridità della carriera, del danaro, del potere”. Quei brividi si avvertono già solo a leggere una frase del genere! In epoca di mobbing, di guerre, di pandemie, in una società suicida sull’altare infame dei numeri e del soldo, ecco finalmente ergersi coraggiosa una voce che ancora osa parlare di Amore in concreta sincerità. E ancora, con affascinante candore si apprende alla risposta della domanda n. 109 che il suo più grande sogno, pure in un percorso così indiscutibilmente brillante, è ancora oggi “che qualche mio verso, che qualche mia frase o pensiero, venissero pronunciati anche senza il mio nome, come patrimonio che è stato acquisito dall’umanità.”
Si chiude l’ultima pagina di questo libro con un senso di affezione, come se si fosse trascorso un lungo weekend al mare con entrambi gli artefici di un’opera così straordinaria. Quelle di Marco Onofrio non sono domande. Sono perle di una collana magica che fin dalla prima pagina, ivi inclusa la preziosa introduzione di Rino Caputo, si ha la sensazione di indossare per prendere parte a un rito, un viaggio dentro e attraverso la vita di un interprete sublime del Libro Totale che la vita stessa rappresenta. Interprete talmente sublime che la Sua vita assurge a simbolo e metafora della vita stessa di ogni uomo. Un sentito grazie a Dante Maffìa per averci ospitato al banchetto della propria anima e del suo Mondo, moglie, figlie e nipoti inclusi, di cui traccia un quadro a dir poco commovente. E naturalmente grazie a Marco Onofrio per aver dimostrato ancora una volta che colui che si offre al servizio di un’opera con coscienza pura e devota, incarna ciò che Sting (ricordo che Marco Onofrio è anche un fine critico musicale, oltre che scrittore, poeta, saggista, ecc.) scriveva nel capolavoro dei Police, la mistica “Wrapped Around Your Finger”:
Devil and the deep blue sea behind me
Vanish in the air you’ll never find me.
I will turn your face to alabaster,
Then you’ll find your servant is your master.
(Il diavolo e il mare blu profondo dietro di me
Svaniscono nell’aria non mi troverai mai.
Trasformerò il tuo viso in alabastro,
Allora scoprirai che il tuo servo è il tuo padrone).
Valerio Mattei