
Categoria: Narrativa
“Beatle-Magia”, di Valerio Mattei. Lettura critica
“Beatle-Magia” (Jack Edizioni, 2023, pp. 196, Euro 14), il nuovo libro di Valerio Mattei, è parte di un progetto artistico che troverà la sua manifestazione a 360° veicolando in concerti ed eventi anche il libro precedente, da cui questo deriva, cioè “Lo sciamano” (2019), e altre scritture letterarie e musicali in corso o “in procinto di”. Tale dimensione di work in progress è verificabile anche nell’ottica creativa e aperta con cui “Beatle-Magia” è stato concepito da Valerio: sia per tentare nuovi sentieri interpretativi dei Beatles attraverso la sua sensibilità, sia per cercare egli stesso nuove strade artistiche attraverso la storia e, ancor meglio, l’essenza dei Beatles.
Qualcuno potrebbe obiettare: ancora un libro sui Beatles?! Che altro di nuovo si potrà mai dire? Ebbene, Valerio ci dimostra che di qualsiasi argomento, pure il più consumato, esiste sempre qualche sfaccettatura inedita; ma non è questo il punto. Non ci troviamo di fronte all’ennesimo libro sui Beatles, quanto piuttosto ad una “sinfonia” di esplorazioni sul mistero della creazione artistica che nei Fab Four ebbe modo di manifestarsi fulmineamente, segnando per sempre la cultura attraverso la loro “epifania” planetaria. Le chiavi di lettura sono storiche e sociologiche (cita tra gli altri Franco Ferrarotti ed Edgar Morin), ma soprattutto estetiche. Nella fattispecie, un’estetica a vocazione spiritualistica e messianica, escatologica e misteriosofica. Valerio sviluppa la sua ottica da una concezione provvidenziale della Storia: non l’immanenza di un divenire che trova in se stesso le proprie ragioni, ma la trascendenza di un Disegno che appunto nella Storia si attua e manifesta, per cui non esistono coincidenze e nulla di ciò che accade è per caso. L’affascinante ipotesi è che la partitura dell’esistenza si ricolleghi a una grande Matrice olografica universale che incide continuamente la realtà su “nastro” invisibile e la memorizza in archivio: il “Registro Akashico”, cioè il film del mondo. Non è dato sapere se la realtà è una tessitura che accade di attimo in attimo o una tela già tutta ricamata alla quale dobbiamo estendere il nostro sguardo, oltrepassando il singolo dettaglio.
Anyway, come si spiega l’incredibile avventura dei 4 ragazzi di Liverpool che hanno cambiato il mondo? La loro evoluzione entusiasmante, la loro rapidissima maturazione, la folgorazione creativa che ancora produce la sua fosforescenza ad ogni ascolto? Cos’è che li ha resi e li rende così speciali? Qual è il segreto dei Beatles, il loro carisma, la radice del loro magnetismo, il loro magico ingrediente segreto? Proviamo a sommare i fattori: a + b + c + d + X… E “X” è il quinto membro del gruppo, dove perciò c’è molto più che la somma di Paul, John, George e Ringo Starr. E non stiamo parlando del produttore George Martin… Riflette Valerio: “C’è qualcosa che continua a sfuggire”, qualcosa di intangibile e non riproducibile, altrimenti “quanti Beatles avremmo avuto negli ultimi 60 anni”?
Gli stessi Beatles non sapevano spiegare tutto quel successo:
In una conferenza stampa dei primi anni Sessanta, qualcuno chiese ai Beatles: «Cos’è che fa impazzire i vostri fans?» Paul McCartney rispose con un umile quanto onesto: «Non lo sappiamo». John Lennon invece, geniale e tagliente come sempre, fece esplodere una risata corale dicendo: «Se lo sapessimo formeremmo un altro gruppo e ne saremmo i manager!»
Ma, al di là della Beatle-Mania, da cui a un certo punto ebbero necessità di difendersi, lo sconcerto nasce dal salto evolutivo: da “Love me do” (1963) ad “Across the universe” (1969) c’è un abisso difficilmente spiegabile, oltretutto in così breve tempo! Furono rapiti da una nebulosa creativa che li portò a produrre tanto e a cogliere tesori musicali in rapida sequenza: nella breve ma titanica storia dei Beatles i mesi valgono come anni, tutto è rapidissimo e dà il capogiro.
Valerio chiama in causa la connessione con una Energia superiore che li avrebbe canalizzati: non è altrimenti possibile “conseguire in un arco temporale così ristretto una evoluzione artistica di tale portata (…). Sembra davvero che i Beatles siano stati infusi letteralmente di una qualche saggezza cosmica”. E ancora: “Non scrivi Yesterday, Imagine, Let it be, Strawberry Fields Forever, Lucy in the sky e altri capolavori perché hai deciso di sfondare nella musica”. Non basta il talento e neppure il genio… (fra l’altro i Beatles non sapevano leggere la musica, erano musicisti istintivi). Per spiegare quanto accaduto occorre la Grazia del trascendente, e questa arriva se è necessaria. Nel caso dei Beatles occorreva al mondo per sincronicità con il momento storico: ebbero semplicemente il “merito” e la “fortuna” di trovarsi al posto giusto nel momento giusto per rivelarsi come risposta planetaria alle istanze dei tempi: speranza, emancipazione, giustizia, pace, amore, libertà, felicità. La loro musica consuona con la rivoluzione giovanile, il Concilio Vaticano II, la Nuova Frontiera di Kennedy, lo spirito beat degli anni ‘60. L’intelligenza cosmica li scelse per incarnare tutto questo e affermarlo simultaneamente in tutto il pianeta. La luce che li accese è una sorta di Big Bang da cui scaturisce il rock e il pop che ascoltiamo ancora oggi. Due esempi: “Helter Skelter” all’origine dell’Heavy Metal, e “Tomorrow never knows” della musica elettronica.
Chiaramente Valerio non tralascia – per cenni rapidi e spigliati che presuppongono vaste conoscenze – la storia dei Beatles, anzi riesce a farcela sfilare davanti agli occhi come un videoclip: gli inizi difficili, tra Liverpool e Amburgo, poi l’esplosione del successo, l’Ed Sullivan Show, il Portale Magico che innesca il vortice planetario, la Comedy Song (per esempio Norwegian Wood o Eleanor Rigby), e infine il rifiuto dello show-businnes, la ribellione salvifica alla standardizzazione commerciale, al consumo distratto, alla cultura come oppiaceo. Succede così che nel 1965, soffocati dalla prigione dorata del successo, i Beatles obbediscano al richiamo dello Spirito che bussa alle loro porte: aprono appunto le “porte della percezione” e accolgono i doni della trascendenza, del sogno, delle visioni psichedeliche. Ecco la spiritualità, la meditazione, i testi metafisici, la coscienza cosmica, le culture orientali, l’utilizzo del sitar e il viaggio in India. I Beatles muoiono alle proprie “maschere” e così diventano davvero immortali. Ma restano fedeli alla propria natura, ora più che mai: si tratta di evoluzione organica, benché per certi versi inspiegabile su un piano umano. Il loro sound resta immediatamente riconoscibile anche in questa fase sperimentale. Bellezza e semplicità: melodie indimenticabili che nascondono diversi livelli d’ascolto e tentazioni sinfoniche, già ispirate a suo tempo da George Martin. I Beatles seppero ampiamente dimostrare la possibilità di conciliare qualità e popolarità, cultura alta e cultura di massa, spessore di contenuti e accessibilità di forme.
Il cuore di questo libro è, ripeto, l’ipotesi trascendente di creatività canalizzata: canzoni come gemme sfavillanti ricevute in sogno. Ecco come John Lennon descrive il processo creativo:
È come essere posseduti, come un medium. La cosa deve saltare fuori. Non ti lascerà dormire, così devi svegliarti, trasformarla in qualcosa, e a quel punto avrai il permesso di dormire.
Anche Bono degli U2 nel suo recente libro autobiografico “Surrender” descrive il momento sciamanico in cui sente che la canzone sta cantando lui, non viceversa. E così accade allo scrittore quando viene scritto dalla pagina che scrive. L’artista, nella visione alta di Valerio, è sciamano e sacerdote dell’assoluto, è colui che risveglia e rivela. Come lo shammàs del candelabro ebraico, il nono lume, posto più in alto degli altri 8 per accenderli. Questo è l’artista: un “servitore della Luce” che apre in noi una potente connessione con la scintilla divina e ci sintonizza sul fatto che siamo “esperienze naturali ispirate da Dio” (che tradotto in inglese forma non a caso l’acronimo della parola IMAGINE).
Il libro di Valerio “vuole essere principalmente un omaggio all’insondabilità della materia artistica” e del mistero creativo, per cui non solo i Beatles racchiudono in sé esperienze mitiche millenarie come quelle di Icaro (si sciolsero all’apice del successo), Proteo (erano in metamorfosi costante) e Prometeo (donavano un nuovo fuoco agli uomini), ma la stessa Beatle-Magia si configura come un principio creativo metastorico che opera negli abissi dell’Inconscio collettivo, manifestandosi attraverso i talenti più disparati, alcuni dei quali, evocati da Valerio, si affollano attorno alla potenza magnetica dei Beatles, come in un doppione ideale della copertina del loro album più iconico, il Sergeant Pepper.
Un libro molto ispirato e gestito benissimo, con grande lucidità e maestria comunicativa, che non solo è illuminante perché toglie un po’ di veli agli sguardi opachi di chi legge, ma si lascia fruire come un racconto piacevole, di ottima divulgazione e non comune profondità.
Marco Onofrio
«L’incanto e la paura». La parola, l’immagine e la Vita, tra “strazio” sublime e dolce “struggimento”. Conversazione con Chiara Mutti

Oggi faremo insieme un viaggio nel mondo creativo di Chiara Mutti. Cercando di “sentire” e “comprendere” i luoghi “fin dove giungono le parole”, ma anche oltre, e quindi ciò che considero il cuore della sua poetica, ovvero il rapporto problematico tra la realtà delle parole e la realtà delle cose, ma anche tra le rispettive e reciproche irrealtà. Da un lato il Logos riduzionistico, l’esperienza dicibile con gli strumenti umani della ragione; dall’altro il Mythos senza confini, l’altrove perturbante dell’indicibile. Ebbene, il pensiero annoda i suoi ricami nella zona franca tra il silenzio delle cose, ricco di tutte le parole che vorremmo, e il suono delle parole, povero di tutto il silenzio che non parla. Per questo la poesia è, per dirla con Robert Frost, il “suono del senso”, che afferra, racchiude e produce il senso non convenzionale delle cose, la loro realtà ultima e prima, la radice originaria della loro forma apparente.
Ma andiamo con ordine, muovendo i passi dal più recente alloro che la poesia di Chiara Mutti ha ricevuto, poco più di un anno fa…
– Dunque, Chiara, hai vinto la prima edizione del Premio Nazionale “Moby Dick”, Sezione Poesia: che ricordi hai della premiazione avvenuta nella Sala Consiliare di Palazzo Colonna a Marino (RM) il 26 settembre 2022? Che cosa distingue questo premio, secondo te, dagli altri a cui hai partecipato o che hai vinto?
– È stata un’esperienza felice! Vincere un premio è senz’altro sempre gratificante, ma questo premio ha una marcia in più… non solo per la perfetta organizzazione, ma anche per l’accoglienza e l’attenzione che mi è stata riservata. Insomma, posso dirlo: mi sono sentita coccolata e in perfetta armonia con l’ambiente per corrispondenze elettive. Sono cose che, almeno a me, accadono raramente.

– Che cos’è che ti spinge a scrivere? Che cosa ti proponi pubblicando le tue pagine?
– Credo che sia stato il mio modo spontaneo di esprimermi sin dall’infanzia, non essendo particolarmente portata ad esprimermi con le parole. Volendo fare la psicologa di me stessa, aggiungerei che è un disperato tentativo di fissare il tempo, di contenere lo straziante e continuo dissolvimento di tutte le cose. Mentre scrivo non penso ad altro che a scrivere; soltanto dopo, una volta concluso un determinato percorso, ho bisogno di metterci un punto, di chiudere un cerchio. Pubblicare significa chiudere quel cerchio, fino a un nuovo inizio.
– Puoi azzardare una “definizione” della Poesia?
– Alla Poesia sono state attribuite, nel corso del tempo, innumerevoli definizioni, e giustamente, perché infinite sono le sfumature di senso che implica e i concetti con cui la si può identificare ma, proprio per questo, sempre parziali. Per me la Poesia è e resta, in realtà, indefinibile. Penso sia un modo di vedere, anzi che sia essa stessa Sguardo: un modo particolare di percepire la vita e le cose del mondo.
– La Poesia è per te più “serbatoio del meraviglioso” o “incubatrice d’ombre”?
– Per me è senz’altro “serbatoio del meraviglioso”, le ombre sono dentro me… sono io la mia “incubatrice d’ombre”. Il miracolo è tradurle in qualcosa di luminoso e la poesia è lo strumento che mi permette di farlo.
– Perché, a costo di perdere lettori, non hai paura di sollevare la pietra delle ipocrisie e di affrontare il dolore viso a viso?
– Perché non conosco altro modo di scrivere! Se non lo facessi non solo non sarei fedele a me stessa ma non sarei fedele nemmeno alla Poesia.
– Che sentimenti provi quando scrivi? Più gioia o più sofferenza? È per te un gesto catartico, di autoconoscenza e liberazione?
– Quando scrivo provo più sofferenza che gioia, anche perché la parola è uno strumento limitato che non basta mai comunicare tutto quel che vorremmo esprimere e contro cui ci si scontra continuamente. Peraltro è uno splendido strumento di autoconoscenza e posso dire quindi che è tutte queste cose insieme. Ma non si scrive per liberarsi; non ci si libera mai completamente. Solo dopo, quando si è concluso un percorso e si pubblica, allora sì, allora se hai avuto coraggio e sei davvero disceso negli ‘inferi’, allora può avere un effetto catartico.
Il percorso di Chiara comincia, dopo alcune composizioni giovanili inedite, che probabilmente riprenderà tra qualche tempo, con il primo libro pubblicato: “La fanciulla muta”, del 2012, che segna la sua sofferente conquista della voce. La fanciulla muta è lei stessa da bambina, chiusa nel mutismo come unica maniera per rispondere all’enormità dei fatti spiacevoli che la vita la costringeva prematuramente ad accettare, ma è anche la neve, la coltre del silenzio puro che porta la realtà a scarnificarsi fino all’essenza, al cuore metafisico dell’esperienza e della sua memoria.

LA FANCIULLA MUTA
Hanno chinato la cima
i cipressi
ad annusare l’odore dei prati
un odore bianco
un nonnulla
un marmoreo affiorare
di gigli
e il silenzio
è un richiamo del cielo
un sorriso stupito
un fantasma
la fanciulla muta.
CANCELLI
Osservo dalle dune
un filo d’erba
agitarsi lieve
alla salsedine
lontano
una vela va
oltre il mio dito alluce
serena
tra gli ombrelloni e il mare
biancoverde biancoverdeblu
sfocato
nel tremulo calore della sabbia
l’alta marea tace
dei rumori dell’anima
spezzati
sull’orlo della spiaggia.
NIN-TU
Sorella MadreTerra
infausta nelle mie mani
lasciasti il dono
dissipato
alfine come topi in massa
nell’innato istinto
correremo giù dalla tua rupe
ciechi come falene
rese cieche dalla luce
folli come scimmie
rese folli dalla prigionia
gravidi come cagne
sciuperemo il seme
prosciugheremo il mare
e il miracolo dei pesci
non si ripeterà
la spiga brucerà l’asfalto
landa di nessuno.
Solo ci sarà dato
il respiro degli eroi
che seppero cantarti
benevola e terribile
vulcano d’Islanda
lapilli e cenere
l’incanto e la paura
l’inesplicabile bellezza
tanto che ingrata torno
a consegnarti un intimo vagito
IL DOLORE DELLA SOLITUDINE
È il dolore della solitudine
uno stesso dolore per tutti
un dolore a tonfo sordo
che scuote il cuore
rosso e azzurro di vene
gonfio che trattiene
si accartoccia e stride
come un freno a mano
tirato
nell’universo del ricordo.

A SILVIA
Madre
che abbandonai
alle tortuose vie della follia
troppo presto, per non serbarne colpa
non fosti mai
mamma, sorella, amica
ma forse figlia.
Mi irrigidii
serbando nei ricordi i tuoi fantasmi
lontana, eppur commossa
dalla tua vita
solitaria e stolta.
D’amor non fosti amata
spietato il senso della sorte
e mi sorprendo, ora
a ricordarti nel tuo affetto infante.
Io, adulta
non seppi mai dirti che t’amo
neanche l’ultima volta che ti vidi
terribile, eppur bella
nella rigidità eterea della morte
E VOLTO PAGINA
E volto pagina
sono colei che volge
lo sguardo indietro
ma non torna
ed i vestiti smessi
non mi stanno
pure
vi riconosco
il peso del mio corpo
e lì dove ho sostato a lungo
l’anima si è consumata nella fibra
e lì dove ho mangiato
il cuore si è nutrito nella macchia
e lì dove ho ceduto
lo strappo si è allargato nel dolore.
Il respiro poetico di Chiara si accorda col respiro cosmico dell’essere. La sua voce domina con grande naturalezza il solfeggio delle pause, cioè il rapporto metasemantico che regola l’avvicendarsi di parola e silenzio. Con questo libro impara appunto a scolpire il silenzio in un movimento di scavo e ricapitolazione dell’esperienza. Anche come studio archeologico del sé: la faticosa costruzione della persona, le ere geologiche e geometriche assimilate nella propria crescita.
– Parlaci della tua passione per l’archeologia. Che rapporto hai con il passato? Fra l’altro uno dei tuoi libri di poesia ha un titolo bellissimo, “Archeologie del cielo”…
– Grazie! Ho sempre avuto un forte legame con le radici, che siano intese come origine personale o in senso antropologico, cioè estese a tutto il genere umano. Ho sempre provato un senso di stupore e di meraviglia nel venire a contatto con i manufatti antichi, con i resti archeologici, e in parte anche un senso di gratitudine; forse la mancanza del senso di appartenenza a una famiglia mi ha portato ad aver bisogno di sostituirlo con un senso di appartenenza più esteso.

Il secondo libro, “Scatola nera”, giunge quattro anni dopo la “Fanciulla” a, come dire? sporcare di realtà gli esiti sublimati di quell’esordio. È lo spleen pumbleo dell’esperienza con il suo ingombro, è il “muro della terra” di dantesca e caproniana memoria. Di che cosa è metafora “Scatola nera”? della memoria automatica di bordo, come quella degli aerei? dell’inconscio? dell’anima profonda e immemoriale? dello spessore opaco del mistero? Le risposte ovviamente restano sospese.
COSTELLAZIONI
I
Eravamo sulle labbra della luna
un soffio di polvere bianca,
squame argentee di salmoni
risaliti alla corrente.
Il coro d’inermi fanciulli
emise qualche nota stonata,
un’uggia di rauchi conati.
Duro il sangue pulsò
corrompendo ogni desiderio:
tracciavamo i punti alla cometa
una domanda, una domanda, una domanda
nascevamo sopraggiungendo al giorno
tutto il resto sembrava sera
e la notte era già il tempo del dopo.
II
Dall’emisfero boreale
il vento soffiava gelido di ghiaccio,
pavidi e tremanti
riparammo sotto l’apparenza
seguendo traiettorie
perpendicolari: al nulla
immobile, piombando il sonno
suggeriva sistemi in divenire,
non sapevamo che il nostro
era solo un vagare in tondo?
Un suono di sirena fissa
accanto all’ultima luce.
Il futuro è rimasto irrivelato
come un pianeta dissolto.
III
Prima che piede
ci spingesse al passo
milioni di zampette confuse
segnarono orme di galassia,
solo ali di libellula astrale
ci liberarono dall’orda
distinguendoci l’un l’altro,
vennero a portarci
una nuova forma di confine.
Il margine era acqua
e non era finito, oltre la sostanza,
che potesse quietare
l’ansia del crescere.
Pure il ventre, così vuoto e scarno,
sembrava ora estendersi al pleroma.
Mani d’ossa tintinnanti
musicarono il vuoto.
IV
Perché mai questa scia
di detriti alla deriva?
Questo nulla che ci attrae
più dell’atomo scomposto?
Cambierò la tua fede
in un carro,
un pavone, un cavallo,
una capra bianca.
Puoi frenare il volo del cigno?
Incalzare la risposta del corvo?
Domani, domani.
Forse la materia è madre
strappata agli abissi:
per questo siamo nati.
Forse non siamo che forma.
V
Oh! come tutto muove
e muta, e segue:
solo noi sembriamo
eternamente in atto di finire.
Sempre con occhi vani
ci appressiamo alla vista
pure un giorno dura,
ogni sole, un giorno
e una notte, una notte
basta
per tutte le stelle.
LA LUNA ASSENTE
Sembrava, il brusio, salisse dai fondali
dall’argano, geniali intricati
artifici umani
o forse proveniva da un dio irredento
condannato per la sua vile assenza.
Di ora in ora avanzava sugli spalti
più su, sulle mura
le grida roche
spossate alla calura, alla fame, all’attesa.
La notte, inesorabile, è giunta.
Il pollice verso, la luna assente.
Non adirarti con me!
L’uomo che siede al di là della luce
ha intonato un canto
i fiumi scorrono sotto.
IL LUME
Era forse la tua voce
quel lontano lamento?
O era il vento?
La mano non raggiunse
il mento
che tremava.
Oh lacrima!
rimasta impigliata alla falce.
Tu non hai che parole d’ossa
– i miseri resti –
non gridi, non corri,
non sai
quale mistero ti ha visto.
Chi ti ha riconosciuto?
Chi ha divelto la porta?
Oh! restituitele gli occhi
ridatele il sonno:
la palla è caduta lontano.
Solo un velo di terra
è rimasto
tra la ciotola e il lume.
“Scatola nera” è il suo libro più psicanalitico, rappresenta la catabasi necessaria al raggiungimento della luce, la discesa agli inferi della memoria per fare i conti con se stessa e la verità della propria storia nel mondo. È un’opera molto densa e coesa, che aspira alla dimensione unitaria del poema sinfonico disteso sul “basso continuo” di una musicalità poco cantabile che definirei “dark”, in cui si innestano slanci verticali da cui vengono episodicamente illuminate le atmosfere, come feritoie di una galleria. A proposito di musica…
– Che rapporto hai, in genere, con le altre espressioni artistiche? Di che cosa nutri la tua immaginazione?
– Amo tutte le espressioni artistiche: pittura, scultura, architettura, musica… ma anche grafica e naturalmente fotografia. Posso dire di avere un trasporto particolare con la pittura, avendo avuto modo di respirare quest’arte già in famiglia: mia madre Silvia, il prozio Adolfo Mutti (pittore affermato, in particolare a Brescia e in Lombardia) e il bisnonno Giacomo Mutti erano pittori. Mi piacerebbe approfondire meglio cinema e teatro, ma tutto non si può fare, soprattutto lavorando, però, d’altra parte, proprio il mio lavoro mi dà la possibilità di vivere a stretto contatto con l’arte e oggi posso dire che non potrei più farne a meno. L’arte nutre costantemente la mia anima prima ancora della mia immaginazione.

– Sappiamo che sei anche una bravissima fotografa. Hai anche esposto in mostre fotografiche. Che rapporto c’è, secondo te, fra scrittura e immagine fotografica?
– Diciamo che mi diletto e ho un buon occhio fotografico, ma non sono una professionista. Questo però, e in parte è voluto, mi consente di sperimentare e di spaziare verso soggetti diversi in piena libertà. Poesia e fotografia sono due forme espressive molto diverse e apparentemente contrastanti, ma hanno entrambe un potere evocativo fortissimo e, in questo senso, diventano due vasi comunicanti. Il rapporto tra fotografia e poesia, infatti, per me è molto stretto e posso dire che amo creare immagini con le parole così come fare poesia con le immagini. Può sembrare un’utopia, ma rappresenta una grande sfida e come tutte le sfide mi affascina.




Infatti alcune splendide fotografie entrano in dialogo con le composizioni poetiche del suo terzo libro, “Archeologie del cielo”. C’è un rapporto paritario tra le due forme espressive, per cui le poesie finiscono per essere come fotografie senza immagine, e le fotografie come poesie senza parole. È un libro di trascendenza immanente, di sublimazione concreta, di assalto carnale del mistero. Infatti assomma gli esiti dei due libri precedenti: la poesia è un lievito che ri-anima le cose del loro brivido ancestrale, ricongiungendo lo spirito alle radici del sacro e risvegliando l’atteggiamento di adorazione degli antenati. E questo le consente di esplorare labirinti enigmatici di incanto e paura, ai bordi dell’indicibile complessità.

*
Io vivo. Ma se fossi sogno?
L’allegoria sarebbe il giorno
e la luce tempo.
I colori brillerebbero di una tale infamia
che la notte sarebbe
l’unico porto sicuro.
Il porto in cui la quiete
ha sepolto il giorno.
Ma i ricordi, i ricordi
le fluttuazioni
chi spegnerebbe loro il lume fioco?
Anche il cielo,
il più nero di stelle,
ha le sue prigioni.
*
Noi siamo la continuazione
di quanto è stato prima
e ci sarà domani.
Apparenza e realtà
in una sola dimensione.
Ed è cosa piccola, così piccola
così impossibile da contenere!
Un raggio di luce che danza
qui, ora lì, oltre,
fin dove la penombra può arretrare.
Forse eravamo qui da sempre.
Lo siamo già nei ricordi del Golgota
e nelle valli scoscese,
lo siamo nelle case di pietra,
nelle finestre
diventate azzurre.
Anche loro riflettono cielo,
come noi
che di cielo abbiamo avuto le mani
e quanto abbiamo toccato
è diventato pianta, acqua, animale, dio
Universo
potremmo già essere santi
o dannati per sempre:
chi può decidere il destino?
Guardami, è l’alba,
io sono stata in questa luce
e sono ancora
il principio del mondo.
*
Illuminata dal basso
si ergeva, alta, la rupe.
Era il silenzio immobile
sacro come la croce
su cui muoiono gli uomini
e Dio.
– Un rosso sangue
languente nel cielo –
Più in basso scorreva la vita
infinitamente più in basso
nel fiume scorreva
l’ora precipitava
nel buio profondo
pur continuando a errare.
*
Il cielo ha molti segreti
ma alla vista
si aprono chiare le nuvole.
Nei petali hanno raccolti di nettare
e producono un suono strano:
a volte scoppi di risa
oppure un borbottare
fitto fitto.
Ascolto e aspetto
la replica dei rami
che le foglie persistano o cadano
o se ne vadano
con lo stesso struggente rumore
della mano che si allontana.
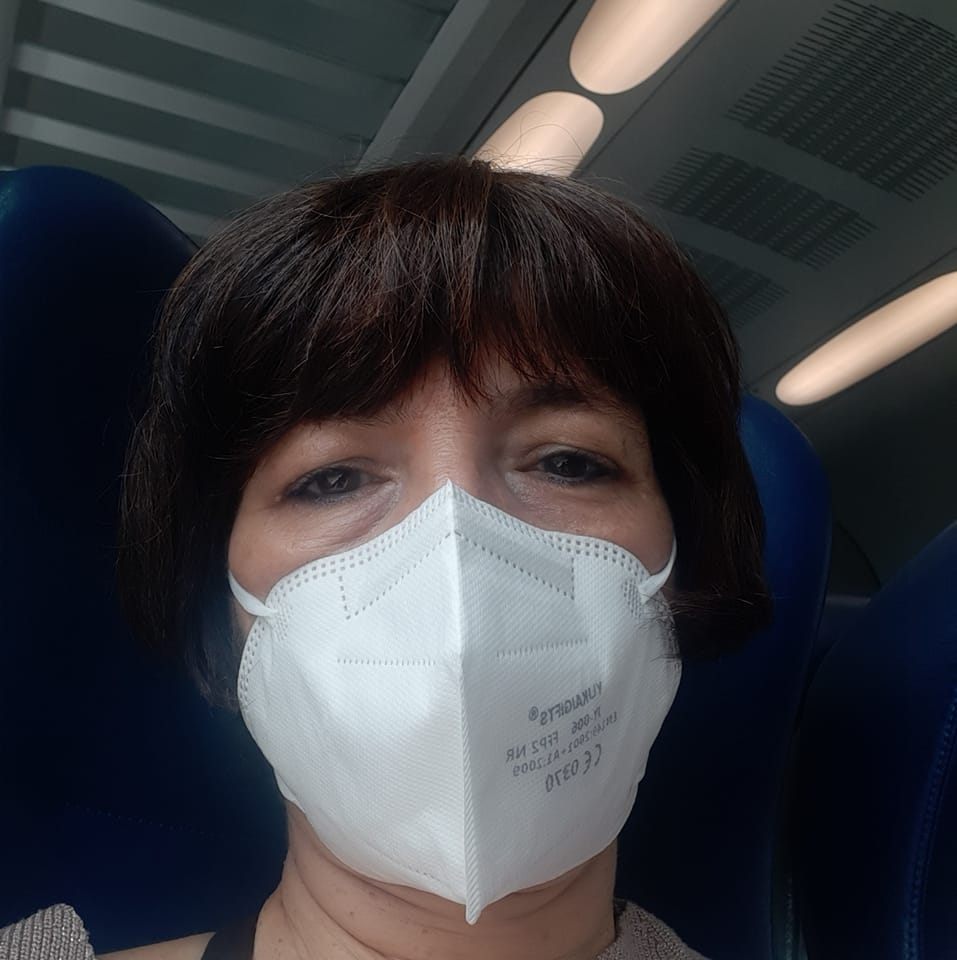
E arriviamo così al quarto libro, le prose liriche di “Amen” in cui Chiara immagina che Giulia, la protagonista autobiografica delle vicende narrate, faccia i conti con una infanzia traumatica e dolorosa, segnata dalla malattia psichiatrica della madre e dalle conseguenti fughe familiari del padre. Ho avuto il piacere di scrivere la Prefazione del libro, in cui fra l’altro dichiaro che «Amen è lo stadio finale di una conquista: significa scendere a patti col passato, con l’annosa e mai del tutto superata “paura di vivere”. Significa imparare a perdonare, abbracciare, amare, benedire e lasciare andare. Significa guardare nello spavento del buio con una fiducia e una forza tali da vederci una luce che brilla». “Amen” è notevole anche perché, grazie all’intensità dello sguardo e dello stile, riesce a intessere la consonanza di due dimensioni estetiche generalmente difficili da accordare, se non inconciliabili: l’umano e il sublime.
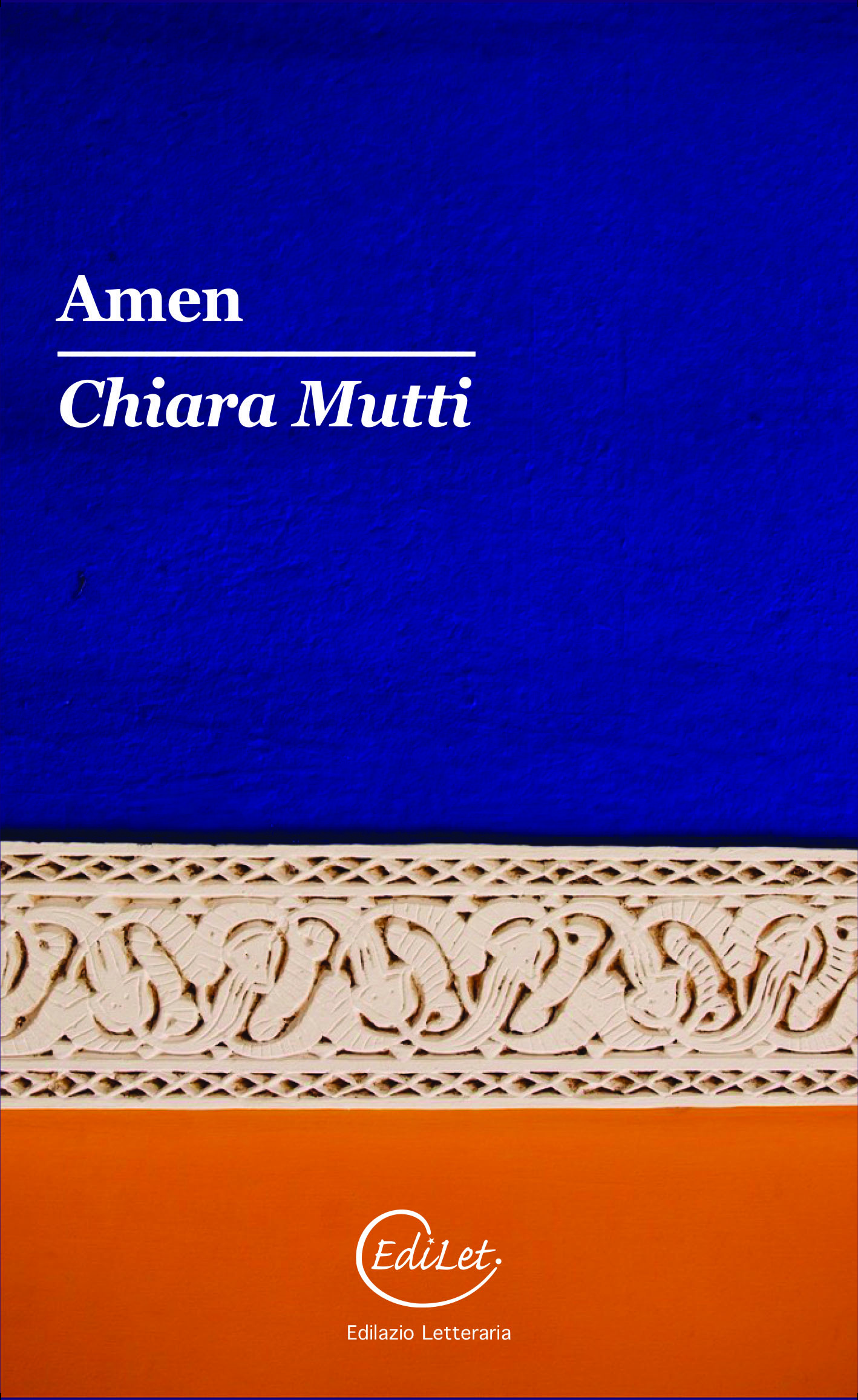
*
Quando suo padre morì, vent’anni dopo, si era già imposta di precludersi alla sua vista, alle sue mani, alla sua voce per il resto della sua vita. Si rifiutò di andare al suo funerale ma gli concesse una corona di fiori. Era consolatorio, pensava, che quella corona fosse lì in sua assenza, era consolatorio e vendicativo. Ma così facendo lo tratteneva con sé. Le ci vollero altri dieci anni per risolversi a lasciarlo andare: “Ora sediamoci qui, uno di fronte all’altro, come non siamo mai stati in grado di fare. Potremmo scegliere il muretto del noce, ricordi?”
“Attorno al noce” diceva suo padre, “metti le pietre una sull’altra” e lei le faceva combaciare scegliendole una per una, che combaciassero perfettamente. Una per una, perché rivelassero la loro parte migliore. Anche lei, come quelle pietre, avrebbe voluto mostrare la sua parte migliore! Aveva sempre la capacità di stimolare il suo orgoglio: era bravo a elargire consigli, a dare la direzione, a sollecitare, a indurre, a manipolare il suo bisogno di piacergli. Aveva nella sua bella voce, bassa, con una elegante francesissima pronuncia della erre moscia, qualcosa che l’attraeva, che la convinceva, come se rivelasse una particolare sapienza; una padronanza del mondo, pensava, capace di svelarne i misteri.
“Anch’io riderò delle vostre sventure, mi farò beffe quando su di voi verrà la paura”…“ma chi ascolta me vivrà in pace e sarà sicuro senza temere alcun male.”
Giulia immaginò di sedersi proprio attorno a quel noce, sul muretto di sassi che aveva tanto amorevolmente costruito, e finalmente aprì gli argini dando libero sfogo al fiume delle sue parole:
“Ora sono io che faccio i conti con te, sono qui a fare i conti perché non avanzi niente, a rinfacciarti i dolcetti di marzapane e l’amore sprecato per la tua persona, i tuoi monologhi ascoltati come fossero oro colato, e tutte le volte che li hai smentiti con la tua condotta, gli sforzi per aderirti e la sensazione di non valere mai abbastanza, il rifiuto e il senso di colpa per il rifiuto, la delusione e la rabbia e la rabbia e la rabbia.
Sono qui per dimenticare la paura del buio, per perdonare l’abbandono, per vincere il senso di colpa, per onorare la furia della rivolta, per abbracciare me stessa.
Sono qui a dirti che ho smesso di essere te e il contrario di te, e qualsiasi persona tu abbia voluto che fossi.
Sotto l’albero mi sono seduta, ho liberato dal laccio il mio piede, posso vedere l’istante prima e tutti gli istanti dopo quel primo istante, anche se posso comprendere solo una parte del tutto.
Ora che sono libera sono ancora una volta sola, ma posso essere cielo, vento, terra, albero e sono acqua che scorre.”
Non è dato sapere come abbia reagito il padre di Giulia a queste parole, né se si sia mai posto domande, in vita, a questo proposito, né se le sia poste dopo la morte. Non sappiamo d’altronde se esista vita dopo la morte, o meglio in che modo e in che forma la nostra energia si riunisca al cosmo.
Sappiamo solo che un padre non è altro che un uomo, pertanto fallibile. Non è il superuomo che avremmo desiderato che fosse! E allora prendiamo la nostra vita e lasciamo che scorra: nessuna diga, per quanto robusta, potrà rallentarne il corso, e quella diga che abbiamo tanto attentamente costruito, con gli errori degli altri, non è altro che la nostra paura di vivere.
A quell’uomo che Giulia ha tanto amato e odiato io oggi dico: “Va’! Riposa in pace.”
Amen

– Uno dei temi principali ravvisabili in “Amen” è quello del perdono. Come lo intendi? Come lo hai affrontato nel corso del libro?
– Non parlerei propriamente di perdono, non nell’accezione cristiana del termine. Si tratta di accogliere e accettare la realtà dei fatti per quelli che sono e di superare il proprio rancore. Diciamo che è qualcosa che, prima di tutto, concediamo a noi stessi per crescere ed essere liberi, e così raggiungere uno stato di pace e consapevolezza. La chiamerei più poeticamente un’epifania.
– Sostanzialmente sei conosciuta come poetessa. Com’è stato passare dai versi alla prosa? C’è un rapporto possibile tra la Poesia e la Narrativa?
– Senz’altro nasco poetessa e, a mio avviso, continuo ad esserlo. Nel senso che si tratta comunque di prosa poetica. Il romanzo segue altre vie, ha delle regole ben precise e nasce da altri presupposti ed io temo di essere troppo indisciplinata per seguire delle regole, finisco per seguire il mio impulso creativo, che è sostanzialmente di natura poetica. Per contro la prosa dà sicuramente maggiore libertà formale e questo mi ha permesso di esprimermi maggiormente.
– Sei stata già tradotta in Romania e hai in preparazione un libro di poesie in Francia, in edizione bilingue. Qual è il titolo? Che emozione provi nell’essere tradotta?
– Sì, il libro è ancora in fase di lavorazione ma dovrebbe uscire nel corso del prossimo anno con il titolo Murmures (Sussurri). Essere tradotti in un’altra lingua dà una grande emozione: significa portare i propri versi in un’altra dimensione, varcare i propri confini, non solo geografici ma anche umani. Provo una grande riconoscenza per chi si adopera nell’arte della traduzione, per la difficoltà che comporta e per la grande cura, l’attenzione che offre ai nostri versi. Il francese è una lingua che amo anche per le sue sonorità.
Ora vorrei tentare di portarmi alle radici dello sguardo poetico di Chiara: “strazio” e “struggimento”, secondo me, rappresentano le parole-chiave. È la temperie autunnale dell’anima, il cammino della caducità che segna d’ombre-luci il trascolorare inesorabile della decadenza. Percepisce così la fine ininterrotta delle cose, attimo dopo attimo, ma questo non le impedisce di adorare la realtà, anzi l’aiuta ad estrarne il sacro e ad abbracciarne la bellezza attraverso un manto di malinconia, di dolce tristezza che rende sostenibile e quasi caro il dolore che prova.
– Quanto influiscono le tue origini lombarde nel tuo modo di guardare e sentire le cose? Per esempio nel tuo modo di descrivere il paesaggio… E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– Influiscono molto, non solo nel mio modo di descrivere il paesaggio: contribuiscono a creare un mio personale paesaggio interiore e influiscono, anche se parzialmente, nel mio modo di intendere la vita, pur non avendo mai vissuto stabilmente in quei luoghi. Forse le nostre origini sono inscritte nel nostro DNA e in qualche modo costituiscono un nostro patrimonio etico, oltre che genetico. Ho molto caro quel senso di lontananza che provocano i grandi spazi della pianura padana, i cieli rosa nell’aria gelida e limpida dell’inverno che fanno da sfondo ai filari di pioppi, le imperscrutabili nebbie e la bruma gelida che risale i canali, il senso di dolce, struggente malinconia e le tante suggestioni che ne derivano.
– E quanto invece c’è di romano e laziale nella tua cultura? Le bellezze storiche di Tivoli sono state importanti per la tua poesia?
– C’è tanto anche di romano e di laziale, Roma è la città dove sono nata e dove lavoro, dove quindi vivo gran parte della giornata. È una signora zozza e un po’ cafona che non smette mai di sorprenderti, di commuoverti con la sua sconvolgente bellezza e di sfiancarti con i suoi perenni contrasti. Ad ogni angolo trovi qualcosa che non avevi ancora visto o che, pur avendolo visto, ti sorprende ancora e ancora. E la luce che si riflette sui muri rossi e giallo ocra dei vicoli di Roma… una luce diafana trasparente… E i rumori, i suoni più prossimi che, in certe strade, ti giungono come da infinite lontananze, echi di rumori. A Tivoli vivo, o per meglio dire dormo, ormai da molti anni. È una cittadina bellissima, ricca di vestigia e di ville patrimonio Unesco. Senz’altro diversi miei componimenti sono ispirati ai suoi panorami ed alle atmosfere che li animano. Mi piacerebbe però che i tiburtini imparassero ad amare di più la propria città, a rispettare e far rispettare il bene comune. In questi ultimi anni ho visto dei progressi per quel che riguarda il turismo, ma ci sarebbe ancora da fare molto! Poi ho vissuto in altri luoghi, e infine ci sono le città d’elezione, le città simbolo, le città sogno. Un poeta ha un forte legame immaginifico con le proprie città, le mie sono tante ma non mi sento legata a nessuna in particolare, pur amando Roma sopra ogni altra.

– Che cosa bolle in pentola? Quale sarà il tuo prossimo libro?
– Non faccio quasi mai programmi, vivo la letteratura e la poesia per ispirazione e per quel che viene giorno per giorno, leggo molto, scrivo poco, o comunque con delle lunghe pause tra una pubblicazione e l’altra. Se volessi però dare una risposta un po’ più concreta, e svelare un mio vecchio sogno nel cassetto: mi piacerebbe realizzare un libro di fotografie. Poi l’idea di rimettere mano alle mie poesie giovanili, già da qualche tempo mi ‘frulla in testa’, chissà che prima o poi non la realizzi.
– Lavori al Ministero della Cultura. Non voglio metterti in imbarazzo, ma secondo te dove sta andando la cultura italiana?
– Ehm… c’è una domanda di riserva?! Sarò sincera, non mi sento molto positiva al riguardo: immagino stia andando lì dove sta andando l’Italia. Ma forse in questo momento, dopo l’ennesima riforma del Ministero, sono un po’ contrariata. La missione principale, a mio avviso, resta sostanzialmente la tutela e la conservazione del bene e questo, checché se ne dica, comporta essenzialmente costi, oltre che grandissimo impegno e competenza. Potremmo diventarne ricchi? È un’attività che non dà ricavi: è un servizio atto a preservare il bene e a impedirne la distruzione. Poi sì, c’è la valorizzazione e la promozione, che, a mio avviso, dovrebbero garantirne la conoscenza e l’accesso da parte di tutti i cittadini. Ma anche questo aspetto non può diventare un business, perché altrimenti vorrebbe dire rendere la cultura un privilegio per pochi. Quello che ho trovato, invece, positivo nell’evoluzione del concetto di bene culturale in questi ultimi anni è stato il modo di ripensare lo spazio culturale, renderlo interattivo, cioè coinvolgere il cittadino nelle attività culturali… ché poi renderlo partecipe significa anche renderlo corresponsabile del bene stesso, quindi contribuire alla sua tutela, e così il cerchio si chiude.
(a cura di Marco Onofrio)

Chiara Mutti, autrice di origini lombarde (bresciane e mantovane, per l’esattezza), è nata a Roma, vive da 30 anni a Tivoli e lavora al Ministero della Cultura in qualità di funzionario per le tecnologie. È appassionata di archeologia, antropologia e fotografia. Ha pubblicato tre raccolte poetiche – “La fanciulla muta” (Lepisma Edizioni, 2013), “Scatola nera” (Fusibilia Edizioni, 2016), “Archeologie del cielo” (Terra d’ulivi Edizioni, 2019) – con le quali ha vinto numerosi premi nazionali e internazionali. Con “Amen” (EdiLet, 2023) ha pubblicato il suo primo libro di narrativa.
Note di riflessione sul Premio “Moby Dick-Gruppo H24”, a pochi giorni dalla Cerimonia di Premiazione a Palazzo Colonna. Intervista di Maurizio Aversa all’ideatore e presidente, Marco Onofrio
Come hai partorito l’idea del Premio “Moby Dick”?
Mi è balenata in testa grazie a un fortunato “filotto” di intuizioni che si sono accese e illuminate a vicenda. Tra l’Associazione culturale di Bibliopop/ACAB (Associazione Comune Autonomo Boville) e il capitano Achab dell’immortale capolavoro di H. Melville (1851), si è accesa all’improvviso una scintilla. Il passo successivo, subito dopo, è stato evocare la celebre canzone del Banco del Mutuo Soccorso (1983), e quindi l’attuale leader della band, il M° Vittorio Nocenzi. Marinese Doc, Nocenzi vive e compone musica a Genzano, da cui parte e a cui ritorna prima e dopo i numerosi concerti in tutta Italia: era dunque la figura iconica perfetta per rappresentare un premio letterario nazionale, sì, ma nato e contestualizzato nei Colli Albani. Contattato da un “certo” Maurizio Aversa [ride, n. d. R.], Nocenzi ha accolto con entusiasmo la proposta della presidenza onoraria del Premio. Da lì, è partito tutto.
Qual è il significato del Premio?
La celebrazione umanistica dell’Ideale. L’iniziativa è dedicata a tutti i sognatori, a chi non abbassa lo sguardo davanti alla realtà, a chi cerca e cattura visioni oltre l’orizzonte. I grandi temi irradiati dalla sua “mission” e sintetizzati per sempre dal mito della balena bianca sono: il sogno, l’utopia, l’immaginazione, la trasfigurazione, la ricerca e l’inseguimento senza fine di un mondo migliore. Il Premio obbedisce alla necessità sempre più urgente di seminare e raccogliere umanesimo per contrastare la deriva di questa disumana e alienante società tecnocratica globalizzata, che sta producendo un arretramento dell’evoluzione umana e un generale degrado dell’intelligenza. Viviamo le estreme propaggini dell’epoca che H. Hesse – nel romanzo “Il giuoco delle perle di vetro” (1943) – chiama “appendicistica”, cioè di fatua banalizzazione divulgativa, di perdita del centro in grado di unificare le più svariate esperienze e prospettive, e insomma: di fine dell’umanesimo. Abbiamo assistito impotenti alla meccanizzazione e alla mercificazione dell’esistenza; all’incredulità dei popoli, disorientati da informazioni contraddittorie e massacrati da decenni di disillusioni, ma per altri versi fin troppo ingenui o indifferenti; alla falsità istituzionale assurta al comando del pianeta. La menzogna viene creduta sulla parola, mentre per la verità non bastano neppure le prove! Ci sentiamo tutti stranieri, anzi: esuli.
Conoscendoti, hai sicuramente scrittori da citare in proposito…
Certo! Penso subito alle parole profetiche di Pasolini, quando scrive del desiderio nostalgico di “qualcosa che contraddica la vita come si va configurando all’uomo moderno, la sua grigia orgia di cinismo, ironia, brutalità pratica, compromesso, conformismo, glorificazione della propria identità nei connotati della massa, odio per ogni diversità, rancore teologico senza religione…” Noi ci chiediamo inutilmente: quando finirà questa discesa nell’abisso? Questa insipienza che raccoglie consensi e suscita applausi? Questo vuoto pneumatico generalizzato? La guerra comincia nella testa delle persone, anche quelle comuni, prima che nei campi di battaglia. Vorremmo poter aderire alle parole pronunciate da E. Montale mentre riceveva il Nobel, nel dicembre 1975: “Ma non è credibile che la cultura di massa per il suo carattere effimero e fatiscente non produca, per necessario contraccolpo, una cultura che sia anche argine e riflessione”. Eppure, quale possibilità ha l’individuo in un mondo di inaudita e indicibile complessità, in cui i condizionamenti esterni sono diventati così schiaccianti che i moventi interni non hanno più alcun peso?
Che risposte ti dài?
Una sola risposta auspicabile: svegliandosi e cominciando ad agire bene, cioè nel modo giusto, fin dalle minime cose. Abbinando quantità a qualità. Costruendo cultura autentica “dal basso”, con un movimento ascensionale come quando la balena riemerge dagli abissi dell’oceano. Citerò un altro scrittore, l’americano R. Pirsig: “Qualsiasi lavoro tu faccia, se trasformi in arte ciò che stai facendo, con ogni probabilità scoprirai di essere diventato per gli altri una persona interessante e non un oggetto”. Questione di qualità, cioè di adesione profonda tra forma e sostanza: a tal fine mira il discorso di Pirsig. Così fa anche l’artista quando opera all’altezza del suo appello interiore, esprimendo valori mediante simboli in vicendevole rapporto, come le onde di uno stesso mare. E appunto la qualità è assimilabile a un’onda. Continua Pirsig: “quel lavoro di Qualità che pensavi nessuno avrebbe notato viene notato eccome, e chi lo vede si sente un poco meglio: probabilmente trasferirà negli altri questa sua sensazione e in tal modo la Qualità continua a diffondersi. È così che il mondo può migliorare”.
In questo si possono rintracciare le radici del cosiddetto “impegno”?
Sì, attraverso strade più o meno programmatiche, ma ciò che conta è l’attitudine, il pensiero che muove il percorso, il ritmo del suo andamento. Ci sono equilibri invisibili e sottili che maturano in silenzio attorno a noi. Abbiamo il potere di spostarli, sia pure impercettibilmente, con i pensieri, le parole, le scelte e le azioni di ogni giorno. Dice un adagio popolare: “fai bene le cose ordinarie, e per magia ti ritroverai a fare cose straordinarie”.
Impegno, popoli, sviluppo e non progresso, alienazione e non partecipazione, declinati con uno degli aspetti umani che finalizzano tutto ciò alla gestione del potere, la lotta delle classi e la politica: come li affronta/risolve lo spirito di Moby Dick/Marco Onofrio?
Con la consapevolezza che cultura “è” politica, nella misura di una implicazione totale nelle memorie, nelle vicissitudini e nei destini di tutti gli esseri umani, nessuno escluso. Così come noi votiamo anche decidendo di acquistare o no un prodotto commerciale, facciamo politica anche leggendo un libro o vedendo un film che ci aprono la mente, ci rendono più consapevoli, lucidi, combattivi. Il potere della gente è maggiore di quello della gente di potere: se solo si unissero le forze, passando indenni attraverso le reti di contenzione che le oligarchie tessono per mantenere lo status quo di ingiustizia, il futuro del mondo potrebbe davvero essere migliore.
Che cos’è infine, per te, la cultura?
Uno spazio di condivisione e resistenza umana al pericolo incombente della barbarie. Abbiamo la speranza e la convinzione che le tenebre non prevarranno: noi lottiamo per la luce! È anche questo il significato profondo del Premio “Moby Dick”…
Gli alunni di una scuola media sul tema della guerra: “Racconti brevi in tempi complessi”. Lettura critica
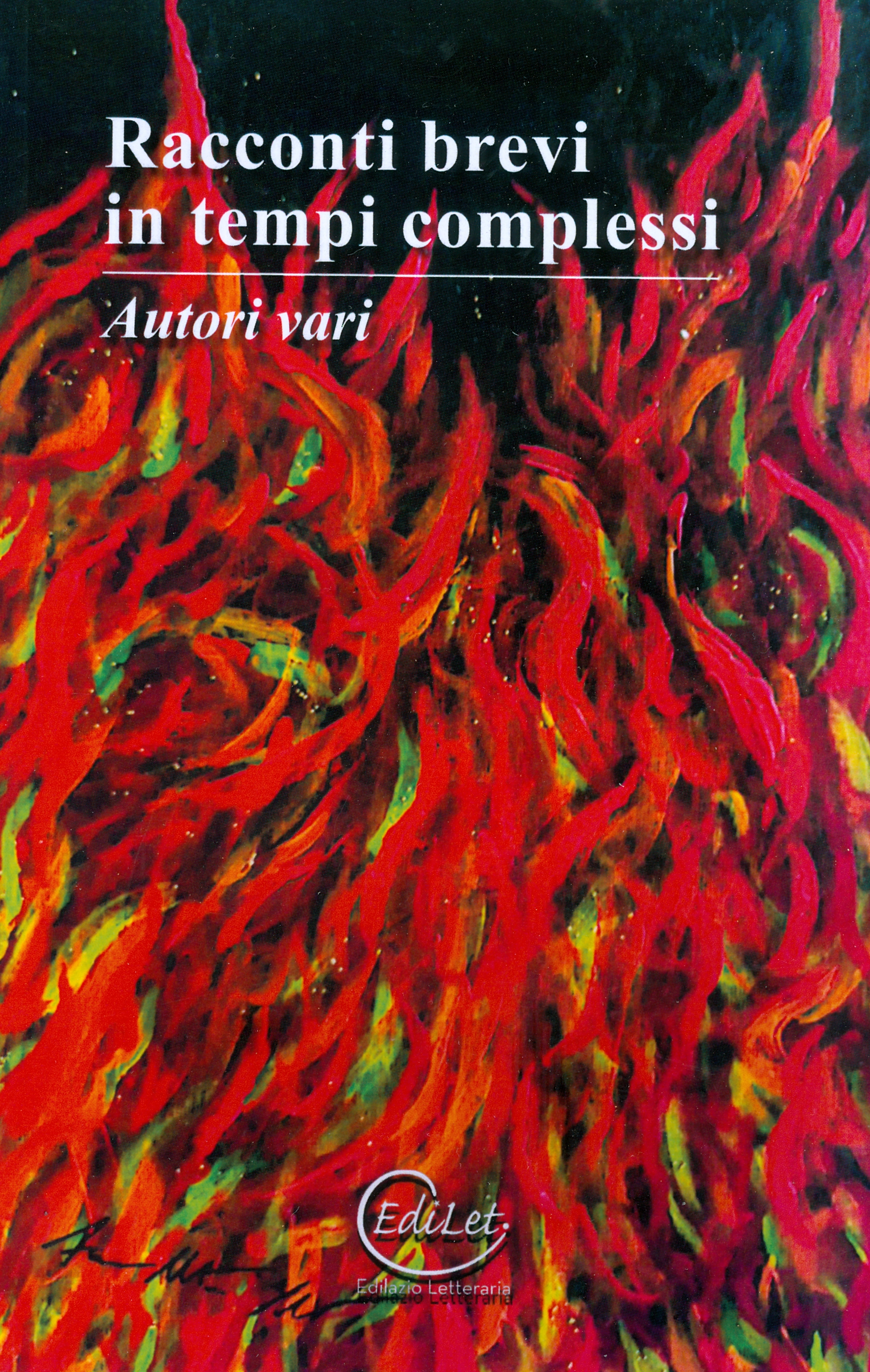
I dodici testi creativi assemblati in questa agile ed encomiabile antologia (“Racconti brevi in tempi complessi”, EdiLet, 2022, pp. 64, Euro 10) consentono al lettore il continuo passaggio dalla cronaca alla storia, in un movimento biunivoco che “doppia” quello – dalla realtà alla fantasia – con cui i ventiquattro giovani autori tentano anche di trasfigurare, alla luce di una possibile speranza, le implicazioni del tema assegnato. I toponimi inventati per l’occasione (Chymis, Kayn, Zikorio, Poliest, Ultaar, Krastovosh, Pietraia, Allapolla, Aniarcu, Noccarian, Pomodoria, ecc.) hanno una suggestione fonosimbolica che per lo più ricorda lo spunto estemporaneo da cui è nato il libro: la guerra in Ucraina. Però ovviamente il discorso riguarda tutte le guerre di ogni tempo e luogo; anche quelle di cui, per motivi politici, si è parlato e si parla di meno.
La coscienza etica degli alunni avverte per istinto, prima ancora d’ogni educazione o lezione acquisita, che la guerra è il male assoluto. Non occorre averne vissuto la terribilità per capire che è una belva immonda, che sparge fetore terrore sangue e distruzione; una belva che se esce dalla gabbia non si riprende più, finché non esaurisce la sua carica devastatrice. L’illusione delle guerre-lampo ha sempre dovuto fare i conti con il principio dell’“eterogenesi dei fini” che ne complica lo sviluppo: chiunque creda di cavarsela in breve tempo e con un sacrificio minimo, in termini di perdite umane, sconterà la sua presunzione ritrovandosi incastrato dentro meccanismi enormi e incontrollabili, di inconcepibile complessità. Ma ecco anzitutto, per essere più concreti, il brivido di orrore suscitato dall’urlo della sirena antiaerea, come quella che “suonava forte” nel racconto “Il bambino di nome Jhonny”, di Matteo Tricarico e Drusilla Brunella. La guerra sconvolge e distrugge tutto ciò che può esistere di bello: persone, destini, animali, affetti, cose. Ad esempio nel racconto “La magia che coccola il cuore”, di Enricomaria Ciotola e Maria Andreea Dunà: “di sera ci rifugiamo in metropolitana per precauzione. Stiamo dormendo lì da almeno tre notti, insieme a tante persone. Ci sono bambini piccolissimi, stanchi e terrorizzati: vedere i loro visi così piccoli e indifesi mi fa piangere il cuore”. Polemos, il demone mitologico della guerra, è apoteosi dell’odio e della morte, quindi nemico giurato dell’amore (etimologicamente a-mors, cioè opposto della morte). E infatti spezza l’amore appena nato tra Anastasya e Aliam, il protagonista del racconto “Quel mio pensiero nitido”, di Cristian Pietrosanti e Maria Buonavita. Però la guerra – e questo in filigrana è il grande spessore umano del libro – fa anche emergere per contrappeso i valori-salvagente dal mare tempestoso del Caos. Talvolta riaggiusta, per assurdo, crepe maturate in tempo di pace, come nel racconto “Legami invisibili” di Valentina Onofrio e Kevin Kalaj. In ogni caso, fa sentire “come era bella la vita prima della guerra” – cito dal racconto “La perdita di tutto”, di Gabriele Carducci e Salma Haiaalla. Fa rimpiangere la normalità che magari annoiava, così come per apprezzare la salute, che tendiamo a dare per sottintesa, occorre il confronto corpo a corpo con la malattia. La morte, insomma, evoca per contrasto la vita e tutte le sue innumerevoli dolcezze, per esempio cucinare che – come in uno dei titoli citati – è una “magia che coccola il cuore”.
Da tutto il libro emerge una grande, ineludibile presa di coscienza contro la barbarie, che spesso è figlia della stessa cosiddetta “civiltà” preposta a combatterla! Ecco il senso tangibile della fratellanza: “Gli occidentali e gli orientali erano popoli vicini e fratelli che appartenevano alla stessa grande comunità, quella umana”. Lo sguardo fresco di questi ragazzi ci fa capire una volta di più che occorre come il pane un’etica planetaria, uno scatto di coscienza superiore che ci porti finalmente a considerare la Terra come essere vivente, casa comune e unica patria; di conseguenza l’umanità come tempio di una nuova coscienza cosmica fondata sul rispetto reciproco di tutte le forme viventi affidate alla tutela del pianeta. Non c’è retorica edulcorante disciolta a cucchiaiate nella melassa dei “buoni sentimenti”, ma semplice e autentica verità che scaturisce dal nucleo originario delle cose, purché viste senza pregiudizi o secondi fini. La presa di coscienza, difatti, non esime dall’esplorazione reale della morte, anzi dallo shock dell’uccisione, come nel racconto “Pensieri in guerra”, di Alessio Corsi e Leonardo Lucario: “Ho ucciso un uomo. Ho ucciso un essere come me. Sono scosso”.
Ma le implicazioni estratte dal macro-tema non finiscono qui: i ragazzi hanno una visione complessa e raffinata dei problemi. Emergono ad esempio le manipolazioni del potere, l’informazione drogata dalle agenzie di governo, l’azione ambigua dei cosiddetti spin-doctors: “L’informazione è sicuramente controllata dal potere: ogni presidente vuol far arrivare il messaggio che il suo governo stia facendo la cosa giusta” (p. 21). O ancora: l’impotenza della diplomazia, che sempre più difficilmente riesce a evitare i conflitti armati: “Ora io voglio sapere il perché, di tutto questo. (…) La guerra si sta facendo per ottenere qualcosa, ma perché non si può fare lo stesso senza coinvolgere morti e sacrifici dei cittadini? (…) uomini costretti ad andare a morire, uccidere, per volere di persone più importanti” (p. 24). [Pablo Neruda diceva: “Le guerre sono fatte da persone che si uccidono senza conoscersi, per gli interessi di persone che si conoscono ma non si uccidono”]. O ancora: la paura come chiave per dominare e manipolare le persone, cosicché le dittature si basano sempre sul “terrore”. O ancora: le spie infiltrate (“scoprimmo che un nostro compagno era in realtà una talpa, una spia dei nemici”, nel racconto “Una missione suicida”, di Ludovico Morena e Matteo Roca), e quindi il doppio gioco, i complotti, i servizi segreti (“soldati senza uniforme inviati dai servizi segreti per seminare il caos con attacchi terroristici” inscenati per attribuirli ai nemici, nel racconto “I segreti della famiglia Hardcastle”, di Manuele Ujkaj e Melissa Nilaj), ecc.
È chiaro che la guerra dà il via libera ad ogni tipo di “gioco sporco”, è uno scenario apocalittico dove non ci sono più regole: l’umanità si mostra chiaramente come jungla. I cumuli di macerie materiali e soprattutto morali prodotti dalla guerra sono visti o intravisti in una dimensione fluida e atroce di traumi e incubi adesi alla percezione sconvolta di una realtà incapacitabile, tra sogno e realtà, come nel racconto “Nightmare”, di Roberto Boschi e Matteo Muccini. Uno dei racconti, “Il punto informativo”, di Bruno Baldoni e Alessandro Romani, è pensato sotto forma di comunicato stampa in stile giornalistico. Ma le “cronache dal fronte” continuano anche nel racconto “Un supereroe per l’Aniarcu”, di Damiano Armini ed Enrico Verdolino, di cui voglio riportare l’incipit dallo stile incalzante “a raffica”:
La guerra è iniziata, l’operazione speciale è una copertura, non ascoltarli, poi di colpo una persona. Stava prendendo il caffè.
No, aspetta, hanno suonato alla sua porta. È andato ad aprire.
C’è un signore, è vestito elegante.
Cosa si stanno dicendo?
Non lo so, fammi avvicinare. Operazione speciale, soldato, Aniarcu, Aissur. Sono queste le parole che ho sentito.
Non sai dirmi altro?
No. Ma cosa ci facciamo noi qui?
Non lo so.
Lo spaesamento spaziotemporale porta con sé il tema del rapporto tra storia e natura. Ecco le stagioni che continuano indifferenti malgrado la guerra scatenata dagli uomini, e tuttavia anche la natura può subire danni (per esempio da un conflitto nucleare, che finirebbe per distruggerla, insieme a tutti noi), e quindi sconvolgersi, andare in sofferenza: “Il terreno brulicava di carri armati. L’aria era sempre più pesante, e l’odore di polvere da sparo sovrastava la brezza e la freschezza invernale”; oppure: “La luce della luna e la magnificenza delle stelle erano ormai sparite, coperte da fumo e da aerei. Sempre più missili colpivano innocenti e soldati, perché la guerra non fa distinzioni” (p. 44).
Ora, appurato e compreso tutto ciò, la grande questione è: in che modo fermare o, ancor meglio, prevenire la guerra. Non abbiamo bisogno di un “supereroe”, come nel racconto pocanzi citato, o del teletrasporto per salvare persone portandole in epoche di pace, come nel racconto “Il portale”, di Gaia Scognamiglio e Lucian Denis Tcaciuc. Tutto il mondo deve affrontare il presente senza fuggire o nascondersi dietro un dito, e quindi diventare “supereroe” di se stesso, grazie alla pratica quotidiana di una normalità civile in grado di opporre la “banalità del bene” a quella del male che tanti danni apporta. Occorre operare dall’interno per smontare il motore della guerra.
Qual è il motore della guerra? L’economia! Specialmente quella malsana di oggi, priva di scrupoli e fondata sul profitto ad ogni costo e quindi non più – secondo etimologia – oîkos e nomia, “governo della casa”, cioè amministrazione equa e naturale del pianeta. Tutte le guerre scoppiano per colpa di persone che hanno solo interessi finanziari, a cui sottomettono qualunque valore immateriale. La rapacità degli Stati in cerca di risorse ha alimentato e giustificato le carneficine dell’imperialismo. La guerra stessa è sempre uno sporco affare da cui troppi ottengono “giovamento”. Se dunque è, con ogni evidenza, la quintessenza del male nella Storia, cos’è che impedisce alla memoria la facoltà di impedirla? “Perché la memoria del male non riesce a cambiare l’umanità?” (Primo Levi). Proprio per i profitti indebiti che muovono la guerra e dalla guerra conseguono! Tanto che, se non ci fosse, verrebbe provocata ad arte per tutelare gli interessi di chi ne trae vantaggio, e anzitutto l’industria bellica. L’indimenticato film di Alberto Sordi, “Finché c’è guerra c’è speranza” (1974), è assai eloquente in tal senso. Non esistono guerre “giuste”: “La guerra non restaura diritti, ma ridefinisce poteri” (Hannah Arendt). Infatti esige non mezzi o mezzucci di compromesso, spesso tuttavia utili nella ricerca del cosiddetto “male minore”, bensì risposte potenti, radicali e ad ampio raggio. Questione anzitutto di civiltà umana. Con le parole di Gino Strada: “La guerra non si abolisce coi trattati, ma stimolando la riflessione e la cultura di tutti”.
Le armi efficaci contro la barbarie sono giocoforza preventive: educazione, cultura, comprensione, compassione, forza di cooperazione. Nessuna pace può essere duratura senza la garanzia della giustizia. Occorre alimentare la coscienza civica, fin da bambini. Coltivare i semi dell’umanesimo. Ma, soprattutto, tutelare la prassi della buona comunicazione, la sua arte appianante e pacificatrice. La guerra, anche tra singoli individui, nasce sempre da deficienze comunicative: chi non sa “incontrarsi” finisce inevitabilmente per “scontrarsi”. Anche i singoli individui litigano quando e perché non hanno più parole per venirsi incontro, e allora sfogano in rabbia l’impotenza che deriva da quella debolezza: infatti “la violenza è l’ultimo rifugio degli incapaci” (Isaac Asimov). Forse non si è pienamente consapevoli che tra i più importanti operatori di pace non ci sono soltanto ambasciatori e diplomatici, ma anche traduttori, interpreti, intellettuali, artisti, assistenti sociali e insegnanti illuminati e illuminanti come quelli che, in una scuola media di Marino Laziale (RM), hanno dato vita a questo progetto – in primis il Prof. Francesco Mattia Macrì, che lo ha ideato. In realtà la situazione è così grave e pericolosa che tutti i cittadini del pianeta sono oggi chiamati con urgenza a farsi operatori di pace, cominciando dalle quattro mura domestiche. In tale prospettiva, questo libriccino dà il suo esile ma prezioso contributo alla pace nel mondo: una goccia di speranza pulita in un oceano sempre più inquinato di dolore e grigia indifferenza.
Marco Onofrio







